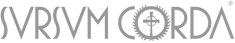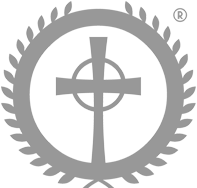• Passiamo ora a confrontare il dominio imperiale con quello regale e con quello politico: perché, come risulta da quanto abbiamo detto, esso ha delle somiglianze con ambedue; e con quello politico concorda per tre caratteristiche. In primo luogo infatti riguardo all’elezione. Infatti, come i consoli e i dittatori romani, che reggevano politicamente il popolo, prendevano la carica o con l’elezione o dai senatori, così pure avveniva per gli imperatori che erano eletti talvolta dall’esercito romano, come - a quanto sappiamo dalla storia - Vespasiano in Palestina (anche Foca fu eletto in una maniera analoga da una rivolta militare in Oriente contro l’imperatore Maurizio, che poi uccise); talora poi gli imperatori venivano scelti dai senatori, come avvenne per Traiano e Diocleziano, anche se uno proveniva dalla Spagna, l’altro dalla Dalmazia. Così pure Elio Pertinace fu scelto dai senatori.
• Inoltre essi non sempre provenivano dalla nobiltà; che a volte erano di origine oscura, come risulta per gli imperatori Vespasiano e Diocleziano, che abbiamo menzionato prima, stando a quanto ci racconta la storia. Il che era avvenuto anche per i consoli e i dittatori romani, come abbiamo visto prima riguardo a Lucio Valerio e a Fabrizio. E Sant’Agostino nel De Civitate Dei racconta che Quinto Cincinnato, pur avendo soltanto quattro iugeri da coltivare, fu fatto dittatore. Altra somiglianza si riscontra nel fatto che il loro potere non passava ai loro discendenti, onde, non appena erano morti, finiva anche il loro potere.
• Quanto poi a queste due cose abbiamo un esempio anche nei tempi moderni, perché ci sono stati degli imperatori eletti, come Rodolfo che era semplice conte d’Asburgo e, alla sua morte, Adolfo di Nassau; ed essendo questi stato ucciso da Alberto, figlio di Rodolfo, fu fatto il nuovo imperatore nella stessa maniera. Questa dunque è regola generale, a meno che alcuni non vengano fatti imperatori, o per la loro bontà, o per merito del loro padre, come accadde per Arcadie e Onorio, figli di Teodosio I e per Teodosio il giovane, figlio di Onorio. Infatti, poiché governavano bene lo Stato e la Corte imperiale, meritarono che il potere rimanesse per qualche tempo nella loro famiglia.
• La stessa cosa era avvenuta per i consoli romani; poiché, anche se allora si eleggevano i consoli ogni anno, almeno per quanto riguarda la magistratura, come si vede nel primo Libro dei Maccabei, tuttavia piuttosto spesso avveniva che, per la probità della persona o della famiglia, il potere passava ai discendenti, come successe a Fabio Massimo; il quale, secondo quanto racconta Valerio Massimo, vedendo che il Consolato era stato tenuto da lui cinque volte e spesso dal padre, dal nonno, dal bisnonno e dai suoi antenati, con la massima severità fece notare al popolo, che ogni tanto bisognava dare alla famiglia Fabia degli intervalli, perché la magistratura più alta non restasse sempre in una sola famiglia.
• Capitò anche talvolta che il potere fosse usurpato con la violenza, e non per merito delle virtù, come accadde nel caso dello scelleratissimo Caligola, che era nipote di Tiberio, durante il cui impero ci fu la Passione di Cristo.
• Lo stesso va detto per Nerone. La stessa cosa capitò per i due consoli di Roma che con la loro empietà - come narra la storia - usurparono il potere, cioè per Silla e Mario, che misero a soqquadro la città e il mondo. Orbene, da tutti questi elementi emerge la somiglianza del potere imperiale con quello politico.
• Ma una somiglianza può riscontrarsi anche col dominio regale, sotto tre aspetti.
• In primo luogo per il modo di governare: poiché, come i Re, l’Imperatore ha una giurisdizione e anche a lui spettano, per via di una sorta di diritto di natura, tributi e rendite che non si possono omettere senza peccato, come nel diritto regale che abbiamo definito sopra: potere superiore a quello dei consoli e di qualunque altro reggitore di città che in Italia governi in modo politico, come diremo più avanti. Infatti in tal caso i tributi e le rendite sono devoluti all’erario pubblico. Ne parla appunto Sallustio, nel riferire come Catone in un suo discorso rimproverava i consoli romani del suo tempo.
• Infatti, dopo aver lodato gli antichi, perché «furono in patria operosi, fuori esercitarono un potere giusto, ebbero l’animo libero nel giudicare, non soggetto al capriccio e al delitto», aggiunge: «In luogo di queste cose noi oggi abbiamo il lusso e l’avarizia, la miseria del pubblico erario e l’opulenza privata».
• La seconda somiglianza degli Imperatori con i Re è la corona, perché vengono incoronati come i Re. Infatti ci sono due corone, per quelli che vengono eletti imperatori: una presso Milano, a Monza, dove sono sepolti i re longobardi: e questa corona ferrea si dice che sia il segno che il primo imperatore germanico, Carlo Magno, sottomise i Re longobardi e la loro gente. La seconda corona, d’oro, la ricevono dal Sommo Pontefice, allorché s’inchinano genuflettendosi, in segno della loro soggezione e fedeltà alla Chiesa Romana.
• Ora tale dignità non l’avevano né i consoli né i dittatori di Roma; perché, come sta scritto nel primo Libro del Maccabei, fra i magistrati romani nessuno portava il diadema né si vestiva di porpora; mentre i Re e gli Imperatori fanno ambedue queste cose.
• La terza somiglianza che gli Imperatori hanno coi Re, e per cui differiscono dai consoli e dai reggitori politici in generale, è la facoltà di fare leggi e la potestà arbitraria che esercitano sui sudditi nei casi già detti. Perciò il loro potere si chiama anche maestà, imperiale o regale: il che non compete ai consoli e ai reggitori politici, perché questi non possono agire se non secondo le direttive delle leggi che hanno ricevuto, ovvero secondo l’arbitrio del popolo; e non possono emettere giudizi al di là di questa norma. • Risultano dunque chiaramente le qualità del governo imperiale secondo i diversi tempi, e dal confronto di esso col governo politico o democratico e con quello regale.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XX del Libro III: Paragone fra il dominio regale e quelli imperiale e politico.
• E allora cambiò la successione dell’Impero: perché a Costantinopoli fino ai tempi di Carlo Magno nella designazione si conservò il modo antico; infatti talora i regnanti si prendevano dalla stessa famiglia, talora da altre parti; e talora la designazione era fatta dal Principe, talora dall’esercito. Ma, fatto imperatore Carlo, cessò il metodo elettivo e gli Imperatori venivano fatti per successione dinastica, dalla stessa famiglia, in modo che l’Imperatore fosse sempre il primogenito. E questo sistema durò fino alla settima generazione. Finita anche questa nel tempo trascorso da Carlo a Ludovico, essendo la Chiesa vessata da alcuni malvagi romani, fu chiamato in suo aiuto Ottone I, Duca dei Sassoni. Liberata quindi la Chiesa dall’oppressione dei Longobardi, degli empi romani e del tiranno Berengario, egli fu incoronato Imperatore da Leone VII, di razza tedesca. Questa famiglia tenne l’Impero per tre generazioni, e si chiamarono tutti e tre Ottone.
• E da allora, come sappiamo dalla storia, Gregorio V, anch’egli di razza teutonica, stabilì che l’elezione fosse fatta da sette Prìncipi della Germania. Questo sistema dura ancora ai nostri tempi, da 270 anni o quasi, e durerà fin tanto che la Chiesa Romana, che nel Principato ha il primo posto, lo giudicherà utile ai fedeli di Cristo.
• E in questo caso, cioè per il buono stato della Chiesa universale, come risulta chiaramente dalle parole di Cristo citate sopra, il Vicario di Cristo mostra di avere la pienezza della potestà, e questa pienezza gli compete per tre tipi di diritto.
• In primo luogo per diritto divino, perché dalle parole citate (e lo dimostreremo anche più avanti) si vede con sicurezza che Cristo ha voluto così. In secondo luogo per diritto naturale; perché, posto che egli abbia il primato nel dominio, è necessario definirlo capo; cosicché da lui nel corpo mistico viene ogni movimento e ogni senso, perciò concludiamo che ogni funzione di governo dipende da lui. Di più: in una comunità bisogna mirare alla sua conservazione; perché questo richiede la natura umana, la quale non può vivere senza società. Ma questa non si può conservare se non tramite un reggitore supremo che guida qualsiasi ordine di uomini: e questo nell’agire degli uomini è il compito del primo Gerarca, cioè di Cristo. Questi perciò è il primo dirigente, consulente e motore; e il Sommo Pontefice fa le sue veci. Inoltre, nel primo libro abbiamo detto che il Principe nel regno è come Dio nel mondo, e come l’anima nel corpo.
• Ebbene, è risaputo che ogni operazione della natura dipende da Dio come governante, movente e conservante, poiché «in Lui abbiamo la vita, il movimento e l’essere», come è scritto negli Atti degli Apostoli (17, 28); e il Profeta dice: «Tutte le opere nostre hai operato in noi» (Isaia, 26, 12). E lo stesso possiamo dire dell’anima, poiché ogni azione della natura nel corpo dipende dall’anima secondo tre generi di casualità. Ora nel caso di Dio noi vediamo questo, che governando e dirigendo il mondo egli permette la corruzione di qualche ente particolare per la conservazione del tutto; così fa anche la natura, per virtù dell’anima, per la conservazione del corpo umano. In modo simile si comporta il Principe nei confronti di tutto il regno: perché, per conservare il suo potere sui sudditi arriva all’imposizione di taglie, e alla distruzione di città e castelli per la conservazione di tutto il regno. Dunque molto di più questo va attribuito al sommo e supremo Principe, cioè al Papa, per il bene di tutta la Cristianità.
• Ecco perché il primo Concilio di Nicea, alla presenza di Costantino, gli attribuì il primato nei primi canoni che stabilì. Anche le leggi che vennero emanate dopo questo Concilio esaltano particolarmente questo primato, affermando che le sentenze del Papa si devono considerare come uscite dalla bocca di Dio. Questa stessa cosa è ribadita da Carlo Magno; inoltre afferma che non è lecito appellarsi contro la sua sentenza; che egli non ha superiore; e che esercita sulla terra le veci di Dio.
• E questa è la terza via, o ragione, per la quale si dimostra e si conclude che il Sommo Pontefice, nel caso suddetto, ha la pienezza della potestà. In due casi abbiamo un ampliamento del suo potere, come emerge da quanto abbiamo detto prima: o a causa di una colpa, o per il bene della fede nel suo insieme, secondo la bella espressione del profeta Geremia il quale dice della persona del Vicario di Cristo: «Ecco, ti ho stabilito sopra le genti e sopra i regni per svellere e distruggere, disperdere e dissipare». E questo lo possiamo riferire al caso della colpa, poiché in quelle quattro parole troviamo i diversi generi di pena che possono essere inflitti a ciascun fedele, o suddito, ossia «sopra le genti»; oppure «e sopra i regni». C’è poi una seconda parte, da cui conosciamo un altro ampliamento dei poteri del Sommo Pontefice, ossia nelle parole; «e per edificare e piantare». Parole che si riferiscono al compito del Vicario di Cristo di provvedere al bene della Chiesa Universale.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XIX del Libro III: Come cambiò la successione dell’Impero da Carlo Magno fino a Ottone III; e donde tragga origine l’opportunità che il Sommo Pontefice abbia la pienezza della potestà.
• Ci furono ancora molti altri Concilii da Costantino a Carlo Magno, pur restando questi i principali, nei quali i Prìncipi si mostrarono sottomessi e fedeli alla Chiesa. Soprattutto Giustiniano dopo lo svolgimento del quinto Concilio di 120 vescovi (...). Questo infatti risulta evidente dalle leggi che egli fece a favore dello stato ecclesiastico. E anche dalla lettera che mandò in tutto l’impero dopo la celebrazione del Concilio di Costantinopoli, nella quale dichiarava di sottomettersi alle istituzioni della Chiesa, ordinando ai popoli di obbedirle in tutto, ribadendo anche le deliberazioni dei quattro Concili che abbiamo ricordato e riconfermandole, mettendo le sue sanzioni e le sue leggi al servizio delle Istituzioni ecclesiastiche, soprattutto riguardo alle usure e al matrimonio, intorno ai quali è imbastita tutta la vita.
• Questo Concilio fu celebrato contro Teodoro e i suoi seguaci di Costantinopoli, i quali affermavano che il Verbo di Dio era distinto dal Cristo, e negavano anche la Beata Maria. Il sesto, poi, fu celebrato nella città imperiale predetta col patrocinio di Costantino IV; vi parteciparono 150 vescovi, su richiesta di Papa Agatone contro (coloro) che sostenevano esservi in Cristo una sola operazione e una sola volontà, secondo l’eresia di Eutiche. In questo concilio Costantino, che visse 150 anni dopo Giustiniano, favorì molto la fede, distruggendo gli eretici monoteliti, che il padre e il nonno avevano favorito, e fece restaurare le chiese da loro distrutte.
• I fatti ricordati bastino a dimostrare che gli Imperatori di Costantinopoli furono protettori e attivi difensori della Chiesa di Roma fino al tempo di Carlo Magno. A quell’epoca, essendo la Chiesa oppressa dai Longobardi, e poiché l’impero di Costantinopoli non portava aiuto, forse perché non poteva, dal momento che la sua potenza era diminuita, il Pontefice Romano chiamò in sua difesa contro quei barbari il Re dei Franchi. Prima il Papa Stefano e il suo successore Zaccaria chiamarono Pipino contro Astolfo Re dei Longobardi; poi Adriano e Leone chiamarono Carlo Magno contro Desiderio figlio di Astolfo. Dopo che questi fu tolto di mezzo e vinto insieme alla sua gente, a causa di un così grande beneficio, Adriano, celebrato a Roma un Concilio di 150 vescovi e venerabili abati, trasferì l’Impero dai Greci ai Germani nella persona del Magnifico Principe Carlo; e in questo episodio si vede con sufficiente chiarezza come il potere imperiale dipenda dal giudizio del Papa. Infatti, finché gli Imperatori di Costantinopoli difesero la Chiesa di Roma, come fece Giustiniano per mezzo di Belisario contro i Goti, e Maurizio contro i Longobardi, la Chiesa favorì questi imperatori. Dopo che vennero meno, come al tempo dell’Imperatore Michele contemporaneo di Carlo Magno, si provvide di un altro Imperatore per la sua difesa.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XVIII del Libro III: I due concili ecumenici successivi e le ragioni per cui l’impero fu trasferito dai Greci ai Germani.
• Dopo questi avvenimenti (cfr. Sursum Corda n° 145 e precedenti), essendo stato Giuliano ucciso durante la guerra coi Parti, fu restituita la pace alla Chiesa da Gioviano suo fratello, uomo cattolico; però questi regnò poco tempo. Ma un fatto notevole si riscontra negli Imperatori, da allora fino a Carlo Magno: furono quasi tutti obbedienti ed ossequienti alla Chiesa di Roma, per il suo primato, sia per quanto riguarda il dominio spirituale, come definì il santo Concilio di Nicea, sia per quello temporale. Perciò Papa Gelasio potè scrivere all’imperatore Anastasio che, come insegna la storia, l’Imperatore dipende dal giudizio del Papa, e non viceversa. Anche Valentiniano - che fu l’immediato successore di Gioviano - (a quanto apprendiamo dalla storia ecclesiastica) disse nell’imminenza dell’elezione dell’Arcivescovo di Milano: «Ponete nella sede pontificale una persona a cui noi che governiamo l’impero possiamo piegare il capo sinceramente, e riceverne le ammonizioni quando da uomini sbagliamo, come dal medico riceviamo la medicina».
• E poiché questa materia serve a mostrare l’ossequio dei prìncipi nei confronti del Vicario di Cristo, dobbiamo qui trattare degli Imperatori fino ai tempi di Carlo Magno. E ancora di quelli del periodo da Carlo a Ottone I, nel quale periodo furono cambiate tre cose. In primo luogo il metodo per eleggerli; secondo, le leggi di successione; terzo, il metodo di governo. E, affinché questo appaia chiaramente, bisogna riportare qui qualcosa della successione degli Imperatori fin dal tempo di Costantino, che furono sottomessi alla Chiesa, tranne i già detti tiranni.
• La storia infatti racconta che Costantino, dopo essersi sottomesso al Vicario di Cristo cedendogli Roma, si trasferì con satrapi e prìncipi nella Tracia, laddove comincia l’Asia Maggiore e finisce l’Europa, e lì scelse una città chiamata Bisanzio. E, come sappiamo dalla storia, la rese quasi uguale a Roma e la chiamò col proprio nome. E questa fu la sede imperiale fino a Carlo Magno, nella cui persona Papa Adriano, riunito un Concilio a Roma, trasferì l’impero dai Greci ai Germani.
• In tutto questo si vede chiaramente come gli Imperatori di Costantinopoli dipendessero dal Vicario di Cristo, cioè dal Sommo Pontefice, come scrisse Papa Gelasio all’Imperatore Anastasio: cosicché il loro impero era ordinato a governare i fedeli secondo i dettami del Sommo Pontefice, in modo da potersi denominare giustamente esecutori e cooperatori di Dio nel governo del popolo cristiano.
• Ciò si può vedere in primo luogo a proposito dei quattro Imperatori che regnarono in questo tempo intermedio e furono presenti ai quattro più solenni e universali Concili, ne approvarono i deliberati e vi si sottomisero. Il primo fu quello di Nicea, di 318 vescovi, al tempo di Costantino, nel quale fu condannato Ario prete di Alessandria, il quale, come sappiamo dalla storia, sosteneva che il Figlio di Dio era inferiore al Padre. Si racconta che Costantino sostenne tutte le spese di quel Concilio, quasi per riconoscere con questo gesto come suo Signore il Vicario di Cristo, le cui veci erano tenute da tutto il Concilio; poiché San Silvestro era assente per motivi particolari. Il secondo Concilio si svolse a Costantinopoli durante il pontificato di Ciriaco (tuttavia alcuni affermano che si svolse sotto Papa Damaso), alla presenza di Teodosio I, come racconta la storia, e si radunarono 150 vescovi. In esso furono condannate molte eresie, ma principalmente quella del vescovo di Costantinopoli Macedonio, il quale negava che lo Spirito Santo fosse Dio, consustanziale al Padre e al Figlio.
• Teodosio, anzi, fu così ossequiente verso la Chiesa che, come scrive Gelasio all’imperatore Anastasio, quando Sant’Ambrogio gli vietò l’ingresso in chiesa, non osò entrare; avendolo egli scomunicato per aver dato il suo consenso all’uccisione di una grande quantità di Tessalonicesi, i quali avevano assassinato un giudice imperiale, come racconta la Storia Tripartita. E il Principe cattolico sopportò pazientemente tutto questo; e infine, duramente rimproverato da Sant’Ambrogio, fece pubblica penitenza prima di riottenere l’accesso alla chiesa.
• Il terzo Concilio, di 200 vescovi, fu celebrato sotto Teodosio II figlio di Arcadie, ad Efeso, al tempo di Papa Celestino I, anche se questi non fu presente; ma ne fece le veci Cirillo vescovo di Alessandria, con la fiducia di Teodosio, che fu di così grande onestà, maturità di consiglio ed ossequio al culto divino che gli fu permesso di regnare anche in tenerissima età, come sappiamo dalla storia. Questo Concilio fu riunito contro Nestorio, vescovo di Costantinopoli, che sosteneva essere presenti in Cristo due persone e due suppositi, per cui si giungeva a negare la vera unione delle due nature.
• Il quarto Concilio, di 630 vescovi, fu celebrato a Calcedonia sotto San Leone I, alla presenza dell’Imperatore Marciano, del quale si racconta che per ossequio alla Chiesa di Roma così abbia detto durante la settima azione di questo Sinodo: «Noi siamo voluti intervenire a questo Concilio per confermare la fede e non per una dimostrazione di potenza, sull’esempio del religiosissimo Costantino, affinché, trovata la verità, il popolo non sia ulteriormente discorde per l’influenza di malvagie dottrine». Da ciò si può dedurre che anticamente tutta l’intenzione dei Prìncipi era volta a favorire la fede in ossequio e onore della Chiesa di Roma. In questo Concilio fu condannato Eutiche con Dioscoro vescovo di Alessandria i quali, mentre Nestorio sosteneva che in Cristo come sono distinte due nature devono distinguersi due persone, sostenevano che erano unite e mescolate anche le due nature.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XVII del Libro III: Sottomissione degli imperatori di Costantinopoli alla Chiesa di Roma e ai primi quattro Concili ecumenici.
• Per tali motivi Cristo nostro re permise che i prìncipi di questo mondo dominassero, sia mentre Egli era in vita, sia dopo la sua morte, fino a quando cioè il suo regno non fosse perfetto e ordinato nei suoi fedeli con opere virtuose e decorato del loro sangue. Se infatti Marco Attilio Regolo, per lo zelo verso la patria si fece uccidere dai Cartaginesi; se Marco Curzio si buttò in un crepaccio della terra per liberare la patria; se Bruto e Torquato uccisero i figli per conservare la giustizia e la disciplina militare, come apprendiamo dalla storia, cosicché per il loro zelo il dominio di Roma, da piccolo che era, divenne grande; e se Seleuco, che regnava sui Locresi - come racconta Valerio Massimo nel sesto libro - privò il figlio e se stesso di un occhio, per un adulterio che quegli aveva commesso, affinché fosse osservata la giustizia contro il delitto perpetrato dal figlio, spartendo mirabilmente in se stesso le funzioni di padre misericordioso e di giudice giusto; perché non dovrebbero essere lodati ancora di più i cristiani nell’esporsi a patimenti e torture per lo zelo della fede e per amore di Dio, e nello sforzo di far fiorire le varie virtù, per conseguire il regno eterno e per accrescere il dominio di Cristo coi loro meriti? Di queste cose tratta molto sottilmente e diffusamente Sant’Agostino quasi in tutta l’opera De civitate Dei, essendo lo scopo per cui scrisse questo libro.
• Ebbene tutto ciò avvenne nel periodo compreso tra la Passione del Signore e il tempo di San Silvestro e Costantino. In questo periodo un’infinita moltitudine di fedeli si immolò e si unì con la morte al suo Signore Cristo, e seguì il suo principe e condottiero. E in primo luogo i primi capi, gli Apostoli e gli altri discepoli di Cristo, tutti i vicari di Cristo e successori di Pietro, per 350 anni, e sul loro sangue, sui loro corpi e sui meriti della loro vita fu fondata la Chiesa, come su pietre vive e preziose, e su fondamenta ineffabili, che né i venti, né la pioggia, né le tempeste dei più svariati tormenti o turbamenti possono abbattere.
• Ma, al tempo opportuno, affinché si rivelasse al mondo come già costituito il regno di Cristo, la virtù del nostro principe Gesù Cristo mosse un principe del mondo, Costantino, colpendolo con la lebbra e guarendolo col miracolo al di là delle possibilità umane. Dopo codesta prova egli si piegò al potere del vicario di Cristo, cioè di San Silvestro, al quale era dovuto di diritto per le cause e le ragioni sopra esposte. Con tale sottomissione al regno spirituale di Cristo fu aggiunto il potere temporale, mentre quello spirituale rimaneva nel suo vigore; poiché il primo deve essere ricercato di per sé dai fedeli di Cristo, l’altro invece come secondario, solo in quanto serve al primo. Diversamente si opera contro l’intenzione di Cristo.
• Allora si compì ciò che aggiunge Isaia alle parole già citate: «II suo impero crescerà, e la pace non avrà fine» (9, 7). Da allora infatti furono aperte le chiese, e Cristo cominciò ad essere predicato pubblicamente; cosa che prima non era possibile senza pericolo di morte. E, nello stesso anno in cui Costantino fu guarito dalla lebbra e si convertì alla fede, furono battezzati nel territorio di Roma più di centomila uomini per i miracoli compiuti dal vicario di Cristo che abbiamo ricordato.
• Ma qui bisogna spiegare quello che dice il Profeta: « ...e la pace non avrà mai fine». È risaputo infatti che, dopo la morte di Costantino, suo figlio si lasciò contagiare dall’eresia ariana e portò turbamento nella Chiesa. Perciò durante il suo impero patirono l’esilio i grandi dottori della Chiesa Ilario di Poitiers, Atanasio vescovo di Alessandria, Eusebio di Vercelli e molti altri dottori e chierici delle varie chiese; anzi, il capo della Chiesa, il sommo Pontefice Liberio, vacillò nella verità della fede per la grande persecuzione di Costante, come sappiamo dalla storia. Dopo di lui ci fu Giuliano l’Apostata, fratello di Gallo e cugino di Costanzo. Questi intraprese una nuova persecuzione contro i fedeli, durante la quale furono martirizzati i fratelli Giovanni e Paolo. E allora, come può dirsi avverata la parola di Dio detta per bocca del Profeta, che abbiamo ricordato?
• Ebbene è necessario riferire le suddette parole alla pace del cuore, e non a quella del corpo. Infatti il Signore stesso, quando offre la pace ai discepoli nel Vangelo di San Giovanni (Gv., 14, 27), si esprime in questi termini: «Vi do la mia pace. Io ve la do non come la dà il mondo». Ora è noto che quelle parole furono dette ai discepoli nell’imminenza della passione. Ed è anche risaputo che essi patirono la persecuzione. Cosicché in quella circostanza furono loro dette anche queste parole: «Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi».
• Perciò si tratta di quella pace che gli eletti fedeli di Cristo non possono perdere, se essi non lo vogliono. E se gli Stoici poterono dire che i beni dell’uomo, ossia le sue virtù, rimangono sempre nell’uomo, e non possono essere rubate senza la volontà dei virtuosi, (...) perché non lo diremo ancora di più delle anime dei fedeli, che non vi sarà limite alla loro pace, aderendo esse al Fine che vive senza fine?
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XVI del Libro III: Contributo dei martiri al dominio di Cristo. La pace costantiniana.
• C’è anche un altro motivo per cui nostro Signore assunse una condizione umile, nonostante fosse il Signore del mondo: per far capire la differenza fra il suo dominio e quello degli altri prìncipi. Infatti, quantunque fosse anche temporalmente Signore del mondo, tuttavia ordinò direttamente il suo principato alla vita spirituale, secondo le parole del Vangelo di San Giovanni (10, 10): «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
• Da qui trovano conferma anche le sue parole prima ricordate: «Il mio regno non è di questo mondo». Perciò egli visse umilmente, per trarre col suo esempio i discepoli ad agire secondo virtù, nel quale compito la via più adatta è l’umiltà e il disprezzo del mondo, come già avevano dimostrato gli Stoici ed i Cinici, secondo la testimonianza di Sant’Agostino e di Valerio Massimo. Lo stesso Seneca, che fu un perfetto stoico, lo dichiara nelle opere De Dei providentia e nel De brevitate vitae a Paolino. Per mezzo dell’umiltà, inoltre, ci si rende degni del regno eterno, il cui conseguimento fu lo scopo principale del dominio di Cristo. Perciò egli stesso, nel Vangelo di San Luca, disse ai suoi discepoli e seguaci: «Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; e io vi preparo un regno, come il Padre mio l’ha preparato per me, affinché mangiate e beviate alla mia mensa nel mio regno» (Luca, 22, 28-30).
• Dunque il Signore volle che i suoi seguaci vivessero umilmente, sulla scorta del suo esempio, per il motivo già detto, secondo le parole evangeliche; «Imparate da me che sono mansueto e umile di cuore» (Matteo, 11, 29), ed a questo volle ordinare il suo dominio temporale. Ecco perché la vita spirituale dei fedeli è chiamata regno dei cieli: perché differisce dal regno di questo mondo, e perché è ordinata al regno eterno e non soltanto al dominio temporale. Quindi Cristo, per togliere dal cuore degli uomini il sospetto che avesse assunto il principato per dominare nel mondo, e che questo fosse il suo fine, come lo è degli altri prìncipi, scelse una vita misera, pur essendo il vero Signore e Re; poiché «il principato fu costituito sopra la sua spalla», secondo l’espressione del Profeta.
• E questo fu predetto ottimamente con le parole di Isaia già riportate: perché in primo luogo lo presenta umile e misero, «Ci è nato un pargolo»; aggiungendo poi a questa piccolezza la virtù e l’eccellenza del suo dominio: «Ci fu dato il Figlio». Infatti poiché in Cristo l’umanità era unita con la divinità, come suo strumento, egli era di una virtù onnipotente. Ecco perché il Profeta descrive qui il suo ineffabile dominio con molte espressioni di singolare potenza, le quali devono essere sottolineate tutte una per una, come spiega San Girolamo e come appare evidente dall’ordine delle espressioni.
• Primo, per far notare la sicurezza e la solidità del suo dominio, è detto: «Il suo principato è stato posto sulle sue spalle». Poiché le cose che sono portate sulle spalle sono più stabili: è in questo modo infatti che i pesi vengono trasportati più saldamente. Secondo, per sottolineare la novità del suo potere, sta scritto: «E sarà chiamato col nome di Ammirabile», poiché egli è degno di ammirazione, perché, pur essendo umile e povero, è tuttavia Signore del mondo. Terzo, per far rilevare la chiarezza della sua sapienza, qualità che è particolarmente necessaria ai prìncipi (poiché si legge: «Guai al paese che ha per re un fanciullo», Ecclesiaste, 10, 16; il che accade quando il principe non può deliberare nulla da sé, ma agisce, anzi, per meglio dire, «è agito», mosso dall’altrui consiglio), si aggiunge «consigliere». Quarto, si accenna alla dignità del suo dominio, chiamandolo «Dio». Poiché, infatti, in Lui c’è una sola ipostasi e una sola persona, nella quale sono unite la natura divina e quella umana; e siccome il principato di Cristo agisce in virtù dell[a sua divinità], si aggiunge l’appellativo di «forte». Il principato di Cristo, infatti, riceve l’influsso dalla virtù divina, la quale era in Lui personalmente; potenza di cui Cristo usò durante la Passione, quando i Giudei volevano ucciderlo e Lo cercavano. Allora, appena egli disse: «Sono io», subito caddero a terra, come sta scritto nel Vangelo di San Giovanni.
• Tale potenza va al di là dei limiti imposti al suo vicario: poiché risulta chiaro che il Vicario dì Cristo non è Dio, e in questo il potere di Cristo trascende quello dei suoi vicari; cosicché Cristo, a proposito dell’ordinazione e del governo dei suoi fedeli, poté fare molte cose che San Pietro e i suoi successori non hanno potuto, come sopra abbiamo spiegato.
• Da questa stessa considerazione, cioè dal fatto che egli era bambino, si deduce la sesta singolare condizione del suo dominio: la benignità nel governare, essendo presentato come «padre del secolo venturo». E questo lo possiamo riferire alla pienezza della grazia; perché coloro che ne sono pieni portano facilmente ogni giogo della legge. Per questa ragione San Paolo scrive (Gal., 5, 18); «Se vi lasciate condurre dallo Spirito non siete più sotto la legge». Perciò per governare su persone simili non è necessaria la verga di ferro: e questa particolarità è propria del principato di Cristo.
• La settima ed ultima condizione si deduce dalla stessa causa, ossia dalla tranquillità del suo governo, e vi accenna l’espressione: «principe della pace», sebbene si tratti non della pace del corpo, ma del cuore. È questa che Cristo nostro re e principe ha offerto da vivo e ha lasciato ai suoi discepoli. Dice infatti: «Vi ho detto queste cose perché abbiate la pace in me. Nel mondo avrete tribolazioni; ma confidate: io ho vinto il mondo!» (Gv., 16, 33). Anche questo è proprio soltanto del suo principato. Dunque egli fondò il suo dominio nell’umiltà e nella povertà, nelle avversità, nelle fatiche e tribolazioni; cioè nella stessa maniera in cui, secondo Catone, si era dilatato il dominio di Roma, ossia non col fasto e con le pompe della superbia, come riferisce Sallustio, e come anche Valerio Massimo dimostra.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XV del Libro III: Secondo motivo per cui il Signore assunse una condizione di vita misera e nascosta, pur essendo il vero Signore del mondo.
• Ma ora sorge la questione circa l’inizio di questo principato del Signore, poiché risulta che in seguito molti regnarono, Lui invece scelse una vita umile. Perciò nel Vangelo (Matteo, 8, 20) sta scritto: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli dell’aria hanno dei nidi; ma il Figliuolo dell’uomo non ha dove posare il capo». Ugualmente in Giovanni sta scritto che, per schivare il popolo, si nascose, perché la gente voleva prenderlo e farlo re. Ugualmente nello stesso Vangelo egli dice: «Il mio regno non è di questo mondo» (Giov., 18, 36).
• La risposta al quesito è evidente: il principato di Cristo iniziò al momento stesso della sua nascita temporale. Ne abbiamo le prove nel ministero e nell’annuncio degli Angeli proclamato in quello stesso giorno. Perciò in Luca (2, 10) si legge che «l’angelo disse loro: io vi reco una grande gioia, poiché è nato per voi il Salvatore del mondo»; ugualmente l’adorazione dei Magi. Infatti in Matteo (2,1) sta scritto; «Nato Gesù in Bethlehem di Giuda al tempo del re Erode, alcuni Magi, venuti dall’Oriente, giunsero a Gerusalemme e chiesero: Dov’è il nato re dei Giudei? Perché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». In tutti questi atti risulta abbastanza evidente il suo principato e il tempo dell’inizio, peraltro profetato e preannunziato da Isaia con le parole riportate sopra.
• Si deve poi notare che egli apparve dotato di virtù e di potenza, come era richiesto dalla grandezza del suo dominio, più durante l’infanzia che nell’età adulta, per suggerire che la sua debolezza era volontaria, non necessaria, dal momento che l’aveva assunta lui stesso: e che non ne usava se non in casi speciali, per due ragioni che fanno al caso nostro. La prima ragione fu quella di insegnare ai prìncipi l’umiltà che rende graditi nell’esercizio del governo. Poiché l’umiltà attira la simpatia, secondo il detto: «La gloria andrà incontro all’umiltà» (Proverbi, 29, 23); ed ancora: «Con mansuetudine compi le tue opere, e, oltre il plauso degli uomini, n’avrai l’affetto» (Ecclesiastico, 3, 19); e nella Lettera di San Giacomo (4, 6) si legge: «Dio resiste ai superbi e dà la grazia agli umili». Ma tanto più è necessaria al principe quanto più per l’eminenza della sua condizione può subire il morso dell’invidia che non tollera superiorità. Ciò considerando, il re Davide, replicando a Micol, all’altera figlia di Saul, che lo rimproverava di essersi spogliato in presenza delle sue ancelle per lodare Dio e onorare l’arca santa - che allora era considerata come la divinità -, rispose quello che leggiamo nel secondo Libro dei Re (6, 21-22); «Davanti al Signore, che elesse me piuttosto che tuo padre o qualsiasi altro della tua casa, e mi comandò di essere il duce del popolo del Signore in Israele, danzerò e mi renderò ancora più vile di quel che abbia fatto; e mi renderò abietto agli occhi miei».
• Questa regola Cristo la volle osservare in se stesso, secondo la volontà di Dio Padre, preannunziata dal profeta Zaccaria, che l’evangelista San Matteo afferma essersi compiuta in Cristo: «Ecco il tuo re viene a te mansueto, cavalcando un’asina e un asinello» (Matteo, 21, 5). Perché, se si lodano i prìncipi del mondo per l’umiltà e la povertà, per cui sono graditi ai sudditi e il loro governo divenne prospero, come non lodare di più la perfetta umiltà di Cristo?
• Infatti Valerio Massimo, nel secondo Libro, scrive di Codro, re di Atene (e ne parla anche Sant’Agostino nel De civitate Dei), che quando i Peloponnesiaci combattevano contro gli Ateniesi, avendo appreso da un oracolo di Apollo che avrebbe prevalso quell’esercito il cui comandante si fosse votato alla morte, per la salvezza del suo popolo, si espose ai nemici in umili sembianze, affinché lo uccidessero. Ma appena morto, i nemici furono volti in fuga. Perciò gli Ateniesi affermavano che egli era stato inserito tra gli dèi.
• Il medesimo Sant’Agostino, nel libro già citato, e così pure Valerio Massimo, narrano di alcuni consoli romani, e particolarmente di Lucio Valerio, che morirono in così grande povertà, che gli amici furono costretti a fare una colletta di denaro per la loro sepoltura. Di ciò è grandemente lodato anche il console Fabrizio. Infatti, come narra il medesimo Valerio Massimo, e come scrive Vegezio nel quarto libro del De re militari (e già l’abbiamo detto prima), pur vivendo alla stregua di un povero, agli ambasciatori epiroti che gli offrivano una grande quantità di oro, nel rifiutarlo rispose: «Dite agli Epiroti che preferisco comandare su coloro che possiedono queste cose, piuttosto che possederle io stesso».
• Ma che insistiamo ancora? Tutti i grandi prìncipi e monarchi soggiogarono il mondo con l’umiltà, mentre persero il potere con l’alterigia della superbia, come si è accennato sopra. Perciò nell’Ecclesiastico (3, 20) sta Scritto: «Quanto più tu sei grande, (tanto più) umiliati in tutto, e al cospetto del Signore troverai grazia». Di più: se le virtù dell’umiltà e della benevolenza si possono lodare in qualsiasi principe, molto di più devono lodarsi nel Signore nostro Gesù Cristo, come colui che è costituito nel massimo grado di virtù.
• Si può dunque concludere per il suddetto motivo, che l’umiltà e la povertà di Cristo furono conformi alla ragione, quantunque Egli fosse legittimo Signore.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XIV del Libro III: Inizio e nascondimento della regalità di Cristo. Il primo motivo di tale nascondimento.
• Questa quinta monarchia, che successe a quella dei romani, per la verità è superiore a tutte per tre motivi.
• In primo luogo per il numero degli anni, perché è durata di più e ancor oggi dura, e durerà fino alla fine del mondo, come appare chiaramente dalla visione di Daniele, riferita in precedenza, e come ora chiariremo ancora di più.
• In secondo luogo la sua eccellenza è manifesta dall’universalità del dominio, perché «per tutta la terra sì spande il loro suono, e sino ai confini del mondo le loro parole». Non c’è infatti alcun angolo del mondo, alcuna regione in cui il nome di Cristo non venga adorato. «Tutto ha posto (Iddio) sotto i piedi di lui», come dice San Paolo alla fine della prima Lettera ai Corinzi. Anche all’inizio del Libro del profeta Malachia viene descritto questo dominio: «Da dove sorge il sole fin dove tramonta, il mio nome è grande fra le genti; e in ogni luogo si sacrifica e si offre al mio nome un’oblazione pura; perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti» (Malachia, 1, 11). Da queste parole appare abbastanza chiaramente che il potere di Cristo è ordinato alla salvezza dell’anima ed ai beni spirituali, come già apparirà chiaramente, per quanto non possa essere escluso dai beni temporali, nella misura in cui essi sono ordinati a quelli spirituali. Ecco perché Cristo, pur essendo adorato dai Magi e glorificato dagli Angeli in segno dell’universalità del suo dominio, tuttavia giacque in un luogo umile, avvolto in poveri panni: gli uomini, infatti, sono attirati alla virtù più per questa strada, che dalla forza delle armi. E a questo egli mirava, quantunque spesso usasse la sua potenza come vero Signore. Perciò egli visse nell’umiltà, e sopportò perfino che sotto Augusto si facesse un censimento di tutto il mondo in occasione della nascita del Signore, come testimonia l’Evangelista San Luca.
• Durante questo censimento si pagavano le tasse, ossia i tributi, come insegna la storia, in riconoscimento della dovuta sudditanza, però non senza mistero, perché era nato colui che era il vero Signore e Monarca del mondo, di cui Augusto faceva solo le veci, sebbene senza saperlo, ma per volontà di Dio, cioè nel modo stesso in cui anche Caifa fu profeta. Così per una ispirazione divina il detto imperatore ordinò in quel tempo, come narra la storia, che nessuno del popolo romano lo chiamasse Signore. E dopo la nascita di Cristo, vero Signore, Augusto fece le sue veci per quattordici anni; perché, come computano gli Atti dei prìncipi romani, Cesare Augusto tenne il principato per cinquantasei anni e sei mesi. Anche Tiberio, che successe ad Augusto, deliberò - come narra la storia - che Cristo come vero Signore fosse trasferito tra gli dèi, anche se ne fu impedito dal superbo e altero senato, intollerante di ogni soggezione.
• C’è poi un terzo motivo dal quale appare l’eccellenza della monarchia di Cristo sulle quattro precedenti, ed è la dignità del sovrano, poiché egli è insieme Dio e uomo. Per questo la natura umana in Cristo è resa partecipe di una virtù infinita, per cui ha una potenza e una virtù, superiore alla potenza e alla virtù dell’uomo. Questa è così descritta da Isaia in rapporto alla potenza temporale di Cristo, per la quale lo chiamiamo Monarca: «Ci è nato un pargolo, ci fu dato un figlio: e il principato è stato posto sulle sue spalle, e sarà chiamato col nome di Ammirabile, Consigliere, Dio forte. Padre del secolo venturo. Principe della pace. Il suo impero crescerà, e la pace non avrà più fine» (Isaia, 9, 6-7), In queste parole sono menzionate tutte le prerogative che si richiedono in un vero principe. Anzi egli trascende i limiti di tutti i dominatori, come sarà spiegato nel capitolo seguente, e come appare chiaramente a chi vi ponga attenzione. Dunque questo principato o dominio trascende, annulla e abbatte tutte le monarchie e signorie, perché tutti i regni gli sono soggetti; cosa che è annunciata per bocca del medesimo profeta: «Lo giuro per me stesso, dice il Signore: A me si piegherà ogni ginocchio» (Isaia, 45, 23). E San Paolo nella Lettera ai Filippesi (2, 10) afferma: «Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, e degli esseri celesti e dei terrestri, e di quei sotto terra».
• Parlando Daniele di questa monarchia, dopo aver spiegato a Nabucodonosor il significato della visione che aveva avuto in sogno, conclude: «E in quel tempo (cioè dopo le quattro monarchie degli Assiri, dei Persiani e dei Medi, dei Greci e dei Romani) il Dio dei cieli susciterà un regno che non sarà mai in eterno distrutto e il suo impero non sarà trasferito ad altro popolo; esso annienterà e farà sparire tutti cotesti regni ed esso durerà in eterno» (Daniele, 2, 44). La ragione della sua eternità è evidente: perché questo principato si congiunge all’eterno, essendone signore l’Uomo-Dio.
• E così il cerchio si chiude, tornando al punto di partenza; perché, come sopra abbiamo dimostrato, ogni potere ha origine da Dio. Ora, nel suddetto dominio, percorsi i moti e le vicende umane, il principato termina come in una condizione immobile al dì là della quale non c’è movimento. E così, dalle cose che abbiamo detto, bisogna concludere che questo dominio non può venir meno.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XIII del Libro III: La monarchica regalità di Cristo e la sua eccellenza.
• Dopo i poteri predetti sembra opportuno parlare di quello imperiale che sta nel mezzo fra il politico e il regale, per quanto sia più universale. Perciò sotto questo aspetto dovrebbe essere anteposto al potere regale; c’è invece un altro motivo per il quale deve essere posposto, e che ora tralasciamo.
• A proposito del potere imperiale bisogna fare attenzione a tre cose. La prima riguarda il nome, poiché questo nome trae origine con fasto e solennità dal supremo potere, come se indicasse il signore universale. Infatti il superbo Nicanore, richiesto dai Giudei di rimandare la battaglia dopo il giorno santo, cioè dopo il sabato, domandò loro con arroganza se fosse potente in cielo colui che aveva comandato di santificare quel giorno; e, ricevuta la risposta che «il Signore Dio è potente nel cielo», replicò con smodata superbia: «Ed io sono potente in terra», e comandò di prendere le armi (II Maccabei, 15, 5). Per codesto atto egli in seguito, per disposizione divina, come è narrato nel secondo Libro dei Maccabei, fu vergognosamente catturato da Giuda Maccabeo in guerra, gli furono tagliate la testa e la mano destra, che aveva levato contro il tempio, terminando la vita con una brutta morte.
• Altri titoli, poi, di questo potere furono desunti dal nome di alcuni uomini eccellenti in codesto tipo di dominio per una qualche prerogativa riscontrata in essi, come l’appellativo di Cesare fu preso da Giulio Cesare, il quale - come narra la storia - fu chiamato così perché - stando a quanto scrive Isidoro nel nono Libro delle Etimologie - fu estratto col taglio cesareo dall’utero della madre morta; oppure perché nacque con una folta capigliatura (caesaries): e da questo gli imperatori successivi furono così chiamati, perché portavano la chioma. L’appellativo di Augusto (dall’«accrescere» lo stato) per la prima volta fu dato a Ottaviano, come scrive lo stesso Isidoro.
• In conformità, poi, di quello che stiamo trattando, dobbiamo occuparci dello svolgimento di questo impero, perché prima abbiamo accennato a quattro monarchie; ma possiamo aggiungervi anche una quinta, della quale parleremo in seguito. La prima fu quella degli Assiri - il cui capo fu Nino al tempo del Patriarca Abramo - e durò 1240 anni, come scrive Sant’Agostino nel quarto libro del De civitate Dei, fino a Sardanapalo, che perdette il regno per ragioni di donne. Arbace lo trasferì ai Medi e ai Persiani. E in quel tempo regnava sui Latini Procace, come dice Sant’Agostino nel diciottesimo libro. La seconda monarchia, cioè quella dei Medi e dei Persiani, durò fino al tempo di Alessandro, 233 anni, fino a quando cioè Dario fu sconfitto dal suddetto principe, come scrive sempre Sant’Agostino nel dodicesimo libro. La monarchia dei Greci poi cominciò da Alessandro e con lui finì. E di questo si parla nel primo Libro dei Maccabei, dove è scritto che Alessandro regnò dodici anni e poi morì.
• Ma, per quanto i Greci non avessero prima un impero universale, il regno macedone fino alla morte di Alessandro (del quale il predetto libro fa menzione) era durato 485 anni, come scrive Sant’Agostino nel medesimo dodicesimo libro. In questo regno macedone Alessandro iniziò il suo dominio, succedendo a suo padre nel regno, come racconta la storia.
• Dopo questa monarchia prese incremento l’Impero romano. Infatti, parlando di Giuda Maccabeo, che visse quasi subito dopo la morte di Alessandro, regnando Tolomeo [figlio] di Lago, il primo Libro dei Maccabei racconta molte cose riguardanti i Romani. Da queste appare come la loro potenza fosse diffusa in tutte le parti del mondo, però sotto il governo dei consoli: poiché quando c’erano ancora i re erano in lotta con le regioni confinanti ed erano di modesta potenza. Il consolato, successo alla monarchia, durò fino ai tempi di Giulio Cesare, che per primo si impadronì dell’impero. Ma vi rimase poco, perché fu ucciso dai senatori per abuso di potere. A lui successe Ottaviano, figlio di una sua sorella, che, dopo essersi vendicato degli uccisori di Giulio e dopo aver ucciso Antonio, che regnava sull’Oriente, ebbe tutto il potere per sé solo. E a causa della sua moderazione mantenne il principato a lungo; e nel quarantaduesimo anno del suo governo, compiutasi la settantaseiesima settimana, secondo Daniele, del suo dominio, essendo venuto a cessare il regno e il sacerdozio in Giudea, nacque Cristo che fu il vero Re e Sacerdote e il vero Monarca: perciò, dopo la sua resurrezione, apparendo ai suoi discepoli disse: «Ogni potere è stato dato a me in cielo e in terra». Parole, queste, che secondo Sant’Agostino e San Gerolamo devono essere riferite alla sua umanità; perché, quanto alla sua divinità, nessuno dubita che il potere egli l’abbia sempre avuto.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XII del Libro III: Il potere imperiale, onde ebbe origine codesto nome ed altri appellativi consimili.
• Ora dobbiamo esaminare il potere regale, rilevando in esso varie distinzioni secondo le diverse regioni, e secondo i vari autori che ne trattano. E prima di tutto notiamo che nella Sacra Scrittura le leggi del dominio regale sono tramandate da Mosè nel Deuteronomio in un modo, e dal profeta Samuele, nel Libro dei Re, in un altro. Ambedue, però, in maniera diversa, sempre parlando in nome di Dio, ordinano il re al bene dei sudditi; e questo è proprio dei re, come insegna Aristotele nell’ottavo libro dell’Etica. Si legge infatti nel Deuteronomio: «Quando il re sarà stato proclamato non accrescerà il numero dei suoi cavalli, né fidandosi dei suoi cavalieri ricondurrà il popolo in Egitto... Non avrà una moltitudine di mogli, che seducano il suo cuore, né eccessiva quantità d’argento e d’oro (come poi questo debba intendersi è stato detto prima in questo libro)... Scriverà per suo uso in un volume una copia di questa legge-, e la terrà presso di sé, e la leggerà tutti i giorni della sua vita, per impararvi a temere il Signore Dio tuo, ed a custodire i comandamenti e le osservanze prescritte nella sua legge» (Deut., 17, 16-19), e cioè affinché possa dirigere il popolo secondo la legge divina. Perciò anche il re Salomone al principio del suo regno chiese a Dio questa sapienza, per indirizzare il suo governo al bene dei sudditi, come è scritto nel terzo Libro dei Re. Aggiunge poi Mosè nel medesimo libro (Deut., 17, 20): «Non monti in superbia il suo cuore rispetto ai suoi fratelli, né pieghi verso destra o verso sinistra, acciocché regni lungamente sopra Israele, egli ed i suoi figlioli».
• Invece nel primo Libro dei Re le leggi del regno sono dirette principalmente all’utilità del re, come abbiamo visto prima, nel secondo Libro di quest’opera (capitolo IX), dove sono scritte parole perfettamente adatte alla condizione servile; e tuttavia Samuele afferma che le leggi che ha enunziato, pur essendo interamente dispotiche, sono le leggi del regno.
• Aristotele però nell’ottavo libro dell’Etica, concorda di più con le prime [ossia col Deuteronomio]. Nello stesso libro, infatti, stabilisce tre princìpi riguardo al re, e cioè che è legittimo solo il re, il quale miri anzitutto al bene dei sudditi; secondo, che egli basti a se stesso, ossia che abbia una grande abbondanza di tutti i beni, affinché non abbia a gravare sui sudditi; terzo, che si preoccupi a che i sudditi agiscano bene, come un pastore fa col suo gregge.
• Da tutte queste cose risulta chiaramente che sotto questo profilo il dominio dispotico differisce molto da quello regale, come afferma Aristotele nel primo libro della Politica. Risulta inoltre che il regno non è per il re, ma il re per il regno: poiché Dio dispose che i re reggano il regno e lo governino tutelando ciascuno nel proprio diritto; e questo è il fine del governo: perché se agiscono diversamente, curando il proprio vantaggio, non sono re, ma tiranni. E contro di essi il Signore nel libro di Ezechiele (34,24) dice: «Pastori sciagurati d’Israele, che pascevano se stessi: oh, non sono forse i greggi che dai pastori si fanno pascere? Voi vi nutrivate del latte e della lana vi eravate ricoperti, e le più pingui scannavate, e non pascevate il mio gregge. Non avete sostentato le inferme, né curato le ammalate, né fasciato le fratturate, né ricondotto le sbandate, né cercato le smarrite, ma avete spadroneggiato con rigore e prepotenza».
• E con queste parole ci viene efficacemente insegnata la forma del buon governo, mentre si condanna il suo contrario.
• Di più: un regno è costituito da uomini, come una casa lo è dalle pareti e il corpo umano dalle membra, come dice Aristotele nel terzo libro della Politica. Dunque il fine del re, affinché il governo sia prospero, è che gli uomini siano conservati ad opera sua. Ed è per questo che il bene comune di qualsiasi principato è una partecipazione della bontà divina; cosicché Aristotele nel primo libro dell’Etica può dire che il bene comune è lo scopo cui mirano tutti i componenti, e che è un bene divino. Come Dio, infatti, - che è il Re dei re e il Signore dei dominanti, per virtù del quale i prìncipi governano, come è stato provato in precedenza -, ci regge e governa non per se stesso, ma per la nostra salvezza, cosi devono fare anche i re e gli altri dominanti della terra.
• Dal momento però che nessuno si fa arruolare nell’esercito a proprie spese, ed esistendo per ciascuno un certo diritto di natura a trarre un guadagno dal proprio lavoro, come afferma San Paolo nella prima Lettera ai Corinzi, ne deduciamo che ai prìncipi è lecito percepire tributi e censi annui dai loro sudditi. Perciò San Paolo, dopo aver detto ai Romani che ogni potere viene da Dio, infine li esorta a retribuire secondo il lavoro: «Per questo dovete pagare i tributi, perché quelli che sono addetti a questo compito sono funzionari di Dio». Anche Sant’Agostino, trattando lo stesso argomento nell’opuscolo De verbis Domini, prova la stessa cosa. Bisogna dunque concludere che il re legittimo deve reggere e governare secondo la forza inculcata nel Deuteronomio.
• E questo ce lo insegnano anche gli esempi, perché a tutti quelli che agirono diversamente capitò del male.
• E prima di tutto ai re di Roma, che per la superbia e la violenza che esercitavano furono cacciati dal regno, come Tarquinio il Superbo col figlio, secondo quello che racconta la storia. Ugualmente Achab e sua moglie Iesabel morirono di cattiva morte per la violenza che fecero a Naboth a causa della sua vigna, come è scritto nel quarto Libro dei Re. Qui è anche narrato che i cani leccarono il sangue dei loro cadaveri nella vigna suddetta, come segno della cattiva azione commessa contro Naboth.
• Non così, invece, si comportò il re David, come narra il terzo Libro dei Re. Volendo infatti innalzare un altare per placare Dio grandemente offeso dal suo superbo censimento del popolo, comprò un’aia da Arauna il Gebuseo. E poiché questi l’offriva gratuitamente, il re la rifiutò e, come sta scritto nel Libro dei Paralipomeni, per l’aia suddetta David diede seicento sicli d’oro a peso giustissimo. Da questo apprendiamo che i prìncipi devono essere contenti delle loro rendite, e non possono gravare i propri sudditi sui beni e sulle cose, se non in due casi, e cioè, o a causa di un delitto, o per il bene comune del regno. Nel primo caso, infatti, il principe priva i suoi sudditi del feudo a causa dell’ingratitudine; negli altri per un motivo di quella giustizia, in vista della quale viene concesso il dominio, come abbiamo visto in precedenza, E nei Proverbi si legge che il trono del re è sostenuto dalla giustizia. Anzi, anche la legge divina comanda che i trasgressori dei comandamenti di Dio siano lapidati, o colpiti da varie pene.
• Tutto questo risulta ragionevole, se rivolgiamo l’attenzione a qualsiasi cosa creata, e soprattutto al corpo umano; perché, per conservare la parte più nobile, ci priviamo di quella più vile. Infatti amputiamo la mano per salvare il cuore o il cervello, nei quali principalmente risiede la vita dell’uomo. Tale criterio è approvato anche dalla legge evangelica là dove dice: «Se il tuo occhio è per te occasione di scandalo, o anche la mano, o il piede», e questo Sant’Agostino lo interpreta come una graduatoria di uomini, «cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita senza una mano o zoppo che essere gettato nella Geenna del fuoco con due mani e due occhi» (Matt., 18, 8, 9).
• Lo stesso si dica per quanto il re può esigere per il bene dello stato, come per la difesa del regno o per qualunque altra causa ragionevolmente pertinente al bene comune del suo dominio; la ragione è evidente. Perché, posto che la società umana è naturale, come è stato già provato, tutte le cose necessarie alla conservazione comune di questa società saranno di diritto naturale. Ora, questo rientra in ciò che abbiamo premesso. Posto dunque un legittimo governo regale, il re può esigere dai sudditi ciò che si richiede al loro bene.
• Si deve inoltre notare che l’arte, nella misura in cui le è possibile, imita la natura, come insegna Aristotele nel secondo libro della Fisica. Ma la natura non ha mancanza delle cose necessarie. Dunque neppure l’arte. Ma fra tutte le arti, l’arte di vivere è migliore e più grande, come abbiamo accennato sopra e come prova Cicerone nelle Tuscolane, dal momento che le altre arti sono ordinate ad essa. Perciò anche nella necessità del regno, che è diretto alla salvaguardia della vita sociale degli uomini, il re, che è come l’artefice architetto di questa società, non deve avere mancanze, ma supplire ad ogni manchevolezza di detta società.
• Perciò si deve concludere che in questo caso si possono legittimamente imporre esazioni, taglie, censi e tributi, purché non superino la misura del bisogno. Ecco perché Sant’Agostino nel De verbis Domini, spiegando il passo di San Matteo «Date a Cesare quel che è di Cesare», afferma: «Perciò bisogna sopportare ciò che Cesare ordina, tollerare ciò che comanda; ma diventa intollerabile quando gli esattori accumulano la preda». E poi, spiegando le parole che San Giovanni Battista aveva detto ai soldati: «Non fate violenza né frode a nessuno, ma state contenti delle vostre paghe», scrisse: «Questo si può riferire ai soldati, ai magistrati e a tutti i governanti». Infatti chiunque riceve paghe pubblicamente decretategli, se cerca di avere dell’altro, è condannato dalle parole di San Giovanni per frode e violenza. Dunque sotto questo duplice aspetto il principato dispotico si riconduce a quello regale: ma principalmente a causa della colpa per la quale fu introdotta la servitù, come afferma Sant’Agostino nel diciottesimo libro del De Civitate Dei. Infatti, sebbene anche nello stato di innocenza ci sarebbe stato ugualmente il potere, come abbiamo già detto, non avrebbe avuto altro fine che quello di consigliare e dirigere, senza la sete di potere e l’intendimento di sottomettere qualcuno in maniera servile.
• Invece le leggi sul potere regale trasmesse al popolo d’Israele dal profeta Samuele furono date in base a questa considerazione: perché questo popolo per la sua ingratitudine e la sua durezza di cervice meritava di udire leggi di quel genere. Talora, infatti, quando il popolo non riconosce il beneficio del buon governo, è bene che ci sia la tirannide, poiché questa è uno strumento della giustizia divina. Ecco perché certe isole e certe province, a quanto narra la storia, hanno sempre avuto tiranni a causa della malizia del popolo, perché diversamente, senza la verga di ferro, non potevano essere governate. Dunque in regioni così dissolute è necessario che i re governino dispoticamente; non in conformità con la natura del potere regale, ma in conformità con quello che si meritano i sudditi e della loro caparbietà. E questa è l’argomentazione di Sant’Agostino nel libro di cui abbiamo già parlato. Anche Aristotele nel terzo libro della Politica, nel punto dove distingue i vari tipi di regno, mostra che presso talune nazioni barbare il potere regale è completamente dispotico, perché non possono essere governate diversamente. Tale dominio vigeva allora particolarmente in Grecia e presso i Persiani, almeno in rapporto al governo popolare.
• Sono queste le conclusioni circa il dominio: ed ecco in che senso il principato dispotico possa essere ricondotto ad esso, e come si differenzi da quello politico; argomento che sarà esposto più chiaramente nel capitolo sul dominio politico.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo XI del Libro III: Il potere regale: in che cosa consiste, in che cosa differisce da quello politico, e come si distingue in vari modi, secondo diversi criteri.
• Per un’identica causa e ragione il dominio è passibile di quattro divisioni. Poiché ce n’è uno che è insieme sacerdotale e regale. Il secondo poi è solamente regale - e in questo è compreso il dominio imperiale e ogni altro potere della stessa specie, come risulterà chiaro più avanti. Il terzo invece è politico. Il quarto è economico, o domestico.
• Il primo è superiore a tutti gli altri per varie ragioni; ma la più importante si desume dalla istituzione divina, cioè dall’istituzione fatta da Cristo. EssendoGli, infatti, stata conferita ogni potestà in ordine alla sua umanità, come risulta dal Vangelo di San Matteo, comunicò questa potestà al suo vicario quando disse: «Ed io ti dico che tu sei Pietro e sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che tu legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che tu scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Matteo, 16, 18-19). Parole in cui si riscontrano quattro clausole, poste tutte a significare il dominio di Pietro e dei suoi successori sopra tutti i fedeli e per le quali a ragione il Sommo Pontefice Vescovo di Roma può essere chiamato Re e Sacerdote. Se infatti Nostro Signore Gesù Cristo viene così chiamato, come attesta Sant’Agostino nel diciassettesimo libro del De Civitate Dei, non può giudicarsi erroneo chiamare così anche il suo successore, tralasciando le ragioni che possono essere addotte, perché la cosa è troppo evidente. Ma è necessario tornare alle clausole cui abbiamo accennato: la prima di esse si desume dalla grandezza del nome imposto, la seconda dalla virtù del dominio, la terza dalla sua ampiezza, la quarta infine dalla sua pienezza.
• Desumiamo la prima da quelle parole del Signore: «Ed Io ti dico che tu sei Pietro e sopra questa Pietra edificherò la mia Chiesa». Con questo nome, infatti, come spiegano i sacri dottori quali Ilario e Agostino, il Signore indica il potere di Pietro; poiché dalla pietra, che - a detta dell’Apostolo - è il Cristo, che egli aveva appena confessato, Pietro ebbe il suo nome, affinché anche secondo una certa partecipazione acquistasse e nome e potere, meritando di ascoltare: «E sopra questa pietra edificherò la mia Chiesa»; nel senso che tutto il potere di Pietro tra i fedeli, da Pietro sarebbe derivato a tutti i suoi successori.
• La seconda clausola poi implica la virtù del dominio. E questo lo esprimono le parole che seguono: «E le porte dell’inferno non prevarranno contro di essa». Tali porte sono le corti dei tiranni e dei persecutori della Chiesa, come insegnano i sacri dottori; e sono chiamate così perché sono causa di tutti i peccati in seno alla Chiesa militante. A tali prìncipi, infatti, ricorrono tutti gli scellerati, come avvenne nella corte di Federico II, di Corradino e di Manfredi. Ma essi non prevalsero contro la Chiesa di Roma; anzi furono tutti estirpati da una brutta morte; perché, come sta scritto nel libro della Sapienza (3, 19), «dura è la fine di una generazione ingiusta».
• L’ampiezza del potere poi risulta da quanto il Signore aggiunge: «Io ti darò le chiavi del Regno dei cieli». In questo infatti è indicato il potere di Pietro e dei suoi successori, che si estende a tutta la Chiesa, cioè a quella militante e a quella trionfante, designate come Regno dei cieli, le quali vengono chiuse dalle chiavi di Pietro.
• Invece la pienezza di codesto potere viene espressa da quell’ultima frase: «E tutto ciò che tu legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che tu scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Essendo infatti il Sommo Pontefice il capo nel corpo mistico di tutti i fedeli di Cristo, e provenendo dal capo, nel corpo reale, ogni movimento e sensazione, così pure sarà nel caso di cui si parla. Perciò si deve affermare che nel Sommo Pontefice c’è la pienezza di tutte le grazie, perché egli soltanto può conferire l’indulgenza plenaria per tutti i peccati, dal momento che gli compete ciò che, come a primo dei prìncipi, attribuiamo al Signore, che «della pienezza di lui tutti abbiamo ricevuto» (Gv., 1, 16).
• Se poi si obbiettasse che ciò deve essere riferito alla sola potestà spirituale, [noi risponderemmo che] ciò non può essere, poiché ciò che è corporale e temporale dipende dalla virtù dell’anima. Come dunque il corpo riceve dall’anima essere, virtù ed operazione - come risulta dalle parole di Aristotele e da quelle di Sant’Agostino nel De immortalitate animae -, così anche la giurisdizione temporale dei prìncipi si riceve da quella spirituale di Pietro e dei suoi successori.
• Una dimostrazione di questo la possiamo desumere dagli atti dei sommi Pontefici e degli Imperatori, poiché questi [ultimi] si sottomisero quanto alla giurisdizione temporale.
• In primo luogo ciò risulta dal fatto che Costantino nell’impero si sottomise a Papa Silvestro. Così dal fatto che Carlo Magno fu fatto imperatore dal Papa Adriano; e che Ottone I fu fatto e nominato imperatore da Papa Leone, come narra la storia. Ma il potere dei papi appare con chiarezza dalla deposizione di prìncipi compiuta dall’autorità apostolica. E per primo troviamo Zaccaria, che esercitò questo potere sul re dei Franchi, poiché lo depose dal trono e sciolse tutti i baroni dal giuramento di fedeltà. Ugualmente Innocenzo III tolse l’impero a Ottone IV; e la stessa cosa capitò anche a Federico II, da parte di Onorio III, immediato successore di Innocenzo III. Certo su tutti costoro i Sommi Pontefici non stesero la mano se non a cagione della loro [dei prìncipi] iniquità, poiché il loro potere, e quello di qualsiasi altro signore, va ordinato al bene del sudditi. Diversamente non sono signori legittimi, ma tiranni, come prova Aristotele e come abbiamo detto in precedenza. Ecco perché il Signore nel Vangelo di San Giovanni fa una domanda insistente, chiedendo per tre volte al suo successore Pietro, se lo ama, per dirgli poi di pascere il suo gregge: «Pietro, mi ami tu? Pasci i miei agnelli» (Gv., 21, 17); quasi che in questo consista tutta la cura pastorale, cioè nel vantaggio del gregge.
• Supposto dunque che egli agisce a vantaggio del gregge, come vuole Cristo, il Papa sta al di sopra di ogni altro dominio, come appare chiaramente da quello che abbiamo già detto; e questo è ben dimostrato dalla prima visione di Nabucodonosor, cioè dalla statua, la cui testa era d’oro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e il femore di bronzo, le tibie di ferro; dei piedi, poi, una parte era di ferro, l’altra di argilla. Ma, mentre guardava questa statua, si staccò dal monte una pietra senza che la muovesse alcuna mano e frantumò tutti codesti metalli. Questa pietra, poi, diventò un grande monte e riempì tutta la terra. E il profeta Daniele, come spiegano i Santi Girolamo ed Agostino, applicò questa visione ai quattro imperi, cioè a quello degli Assiri per quanto riguarda la testa d’oro, a quello dei Medi e dei Persiani per l’argento delle braccia e del petto; a quello dei Greci per il ventre e il femore di bronzo; infine a quello dei Romani per le tibie di ferro e per i piedi in parte di ferro e in parte di argilla. Ma dopo queste cose il profeta Daniele dice che «il Dio dei cieli susciterà un regno che non sarà mai in eterno distrutto, e il suo impero non sarà trasferito ad un altro popolo: esso annienterà e farà scomparire tutti cotesti regni, ed esso durerà in eterno» (Daniele, 2, 44). E questa profezia la riferiamo tutta a Cristo e in sua vece alla Chiesa Romana, se mira a pascerne il gregge.
• Bisogna anche osservare che un’istituzione divina non può essere sovvertita, perché Cristo prese i suoi successori soltanto come dispensatori e ministri, come disse San Paolo: «Noi dobbiamo essere considerati come servitori di Cristo e come amministratori dei misteri di Dio» (1 Cor., 4, 1). Infatti il solo Cristo fondò la Chiesa, il cui ministero affidò a Pietro ed agli Apostoli. «Nessuno può porre altra base diversa da quella che è stata posta e che è Gesù Cristo» (1 Cor., 3, 11). Perciò i sacri dottori attribuiscono a Cristo un potere, che né Pietro né i suoi successori hanno mai avuto, e che definiscono «di eccellenza»; e in tal senso il potere di Pietro e dei suoi successori non è uguale a quello di Cristo, anzi quest’ultimo gli è nettamente superiore. Infatti Cristo poteva salvare anche senza battesimo; e per questo San Gerolamo, nel commento a San Matteo, afferma che Gesù non guarì nessuno nel corpo senza averlo guarito nell’anima, e tuttavia senza battesimo; cosa che Pietro non ha potuto fare. Perciò, come si legge negli Atti degli Apostoli, battezzò il centurione Cornelio con tutta la sua famiglia anche dopo la discesa dello Spirito Santo. Cristo, inoltre, aveva anche il potere di cambiare la forma e la materia dei sacramenti, mentre né Pietro né i suoi successori hanno questo potere.
• Basti ora quello che è stato detto, lasciando ai sapienti gli argomenti più sottili che si potrebbero addurre. Tuttavia la conclusione di questo capitolo sia ben ferma in questo: i vicari di Cristo, ossia i pastori della Chiesa, hanno un potere superiore tutti, per le ragioni che abbiamo addotto.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo X del Libro III: Il dominio dell’uomo nei suoi gradi e dignità; e in primo luogo il dominio del Papa che è superiore ogni altro potere.
[Nota dall'edizione usata: Abbiamo lasciato al lettore intelligente il compito di correggere le inesattezze (... presenti in) questa compilazione].
• Passiamo ora ai vari tipi di dominio, secondo i diversi modi e gradi di potere e di principato esistenti fra gli uomini.
• E il primo è quello comune a tutti, che compete all’uomo secondo natura, come insegna Sant’Agostino nel diciottesimo libro del De Civitate Dei: e in questo concorda anche Aristotele nel primo libro della Politica. Lo conferma inoltre la Sacra Scrittura quando, nel racconto della creazione dell’uomo, quasi riferendosi alla sua intrinseca natura, comanda: «Signoreggiate i pesci del mare e i volatili del cielo, e tutti gli animali che si muovono sulla terra» (Genesi, 1, 28). In queste parole sta la dimostrazione che Dio attribuì tale potere all’intrinseca natura umana. Infatti Colui che disse: «La terra germoglierà erba verdeggiante» (dando così agli alberi la virtù di germinare), ugualmente disse anche a noi: «Signoreggiate i pesci del mare... etc». E così da quello che abbiamo detto risulta che il potere dell’uomo sopra le altre creature è naturale.
• Per la stessa ragione Aristotele prova che anche la caccia e l’uccellagione derivano dalla natura. E Sant’Agostino, lo dimostra, nel libro citato sopra, dal dominio che gli antichi Padri erano soliti avere, come pastori di armenti, che in precedenza abbiamo definito ricchezze naturali. E, quantunque tale dominio sia diminuito a causa del peccato, poiché ci sono alcuni animali inferiori che hanno potere su di noi e sono diventati nocivi per noi - e questo agli uomini succede proprio per la causa suddetta -, tuttavia tanto maggiormente siamo partecipi di questo dominio, quanto più ci avviciniamo allo stato d’innocenza, e questo ce lo promette anche la parola del Vangelo, se saremo stati imitatori di Cristo nella giustizia e nella santità.
• Infatti il Signore nell’esortare i discepoli a salvare le anime predicando la parola di Dio, così parla della loro potenza: «Scacceranno i demoni nel mio nome; parleranno lingue nuove; prenderanno in mano serpenti e quand’anche bevessero veleno non, ne riceveranno alcun male» (Marco, 16, 17). E questo lo abbiamo potuto osservare in uomini virtuosi e perfetti, come è scritto nelle storie dei Santi Padri. Riguardo a San Paolo si legge negli Atti degli Apostoli che una vipera non gli fece alcun male; né il veleno fece effetto su San Giovanni Evangelista; e così pure di molti altri Padri santissimi che guadavano il Nilo sui coccodrilli, animali ferocissimi, ovvero rettili velenosi, affinché si compisse in essi quello che il Signore aveva detto ai discepoli: «Ecco, io vi ho dato il potere di calcare serpenti e scorpioni, e di superare tutta la potenza del nemico» (Luca, 10, 19).
• Orbene, ci sono tre vie per dimostrare la convenienza di questa signoria conferita all’uomo sulla creazione.
• Primo, si prova dall’ordine genetico stesso esistente in natura. Infatti, come nella generazione naturale si può individuare un certo ordine per il quale si procede dall’imperfetto al perfetto (poiché la materia è a causa della forma, e le forme più imperfette sono in funzione di quelle più perfette), così avviene anche nell’uso delle cose esistenti in natura: le più imperfette, infatti, sono per l’uso di quelle più perfette. Le piante infatti usano della terra come loro nutrimento, gli animali delle piante, l’uomo infine delle piante e degli animali. Perciò si può concludere che l’uomo per natura ha il dominio sugli animali; perciò, come abbiamo accennato prima, Aristotele nel primo libro della Politica prova che la caccia agli animali selvatici è giusta per natura, perché per mezzo di essa l’uomo si prende ciò che gli appartiene per natura.
• Secondo, questo appare chiaramente dall’ordine della divina Provvidenza, che sempre governa le cose inferiori per mezzo di quelle superiori: perciò, dal momento che l’uomo è superiore agli altri animali - in quanto fatto a immagine di Dio -, giustamente gli altri animali sono sottoposti al dominio dell’uomo.
• Terzo, lo stesso risulta dalle proprietà dell’uomo e degli altri animali. Infatti negli altri animali si può trovare una qualche partecipazione alla prudenza, in particolari istinti e funzioni; nell’uomo, invece, si riscontra una prudenza universale, che è la ragione pratica preposta alle cose agibili. Ora, tutto ciò che è per partecipazione è sottomesso a ciò che è universalmente e per essenza. Perciò è evidente che la sottomissione degli altri animali all’uomo è naturale.
• Ma circa il problema relativo al dominio dell’uomo sull’uomo, se esso sia naturale, oppure permesso o predisposto da Dio, si può raggiungere la verità rifacendoci alle cose già dette. Poiché, se parliamo di dominio come sudditanza servile, esso fu introdotto a causa del peccato, come è stato detto in precedenza; ma se parliamo del dominio che importa la funzione di consigliare e di dirigere, sotto questo aspetto esso si può quasi definire naturale, poiché ci sarebbe stato anche nello stato di innocenza. E questa è la dottrina esposta da Sant’Agostino nel diciannovesimo libro del De Civitate Dei. Perciò questo dominio è proprio dell’uomo in quanto animale per natura sociale, o politico, come abbiamo già detto.
• Infatti è necessario che questa società sia ben ordinata nei reciproci rapporti. Ma tra gli esseri che sono reciprocamente ordinati deve esserci sempre qualcosa di principale in funzione di primo ordinatore, come insegna Aristotele nel primo libro della Politica. E questo lo dimostra anche la ragione o natura intrinseca dell’ordine; poiché, come scrive Sant’Agostino nel libro citato, l’ordine è «la disposizione delle cose pari ed impari che attribuisce a ciascuna ciò che le compete». Perciò è chiaramente dimostrato che la stessa parola ordine comporta l’ineguaglianza, e questo rientra nella natura del dominio. Perciò sotto quest’aspetto il dominio dell’uomo sull’uomo è naturale, come lo è fra gli Angeli; e ci sarebbe stato anche nel primitivo stato [di innocenza] e c’è anche ora. Di esso qui dobbiamo trattare con ordine, considerandolo nei suoi gradi e dignità.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo IX del Libro III: Il dominio che l’uomo ha per natura sugli animali selvatici e sulle altre cose prive di ragione.
• Ma bisogna parlare ancora dell’intervento della divina Provvidenza nel dominio. Infatti talora accade che quando qualcuno assume il principato sia un uomo virtuoso e che per un certo periodo perseveri in questo stato. Ma taluni, dopo un poco di tempo, si insuperbiscono per il favore degli uomini e la prosperità delle cose attinenti al regno e diventano ingrati verso Dio per i benefici da Lui ricevuti. Perciò Aristotele nel quinto libro dell’Etica dice che «il principato rivela l’uomo», come accadde per Saul del quale nel primo libro dei Re è scritto che «in tutta la tribù di Beniamino non c’era un uomo migliore di lui». Ma dopo due anni diventò disubbidiente a Dio; e per questo al profeta Samuele Dio disse di lui: «Fino a quando piangerai Saul, mentre Io l’ho rigettato perché non regni sopra Israele?» (I Re, 16, 1), quasi fosse stato rigettato per un’ineluttabile sentenza divina. Perciò alla fine questo re fu ucciso con i suoi figli, e tutta la sua discendenza fu allontanata dal potere. Cosicché nei Paralipomeni si afferma che Saul morì per le sue iniquità.
• La stessa cosa, poi, avvenne per Salomone, che fu esaltato al di sopra di tutti i re che c’erano stati prima di lui, come è scritto nell’Ecclesiaste; e tutta la terra desiderava ascoltare la sapienza di Salomone. Ma, come dice Sant’Agostino (De civ. Dei, c. 17): «II favore degli eventi fu dannoso a questo re; perché, caduto nella lussuria, precipitò nell’idolatria»; per questo divenne abominevole agli occhi del popolo, tanto che i suoi servi gli si ribellarono rapinando le spoglie della sua regione e devastando la terra, senza trovare alcuna resistenza; mentre prima tutti obbedivano a un suo cenno, come aveva notato la regina di Saba, secondo quanto è scritto nel terzo libro dei Re. Spinto, all’inizio del suo regno, a grandi cose, per la riverenza che aveva mostrato verso Dio, alla fine cadde in basso a causa dei delitti che commise: «Poiché il peccato immiserisce i popoli» (Proverbi, 14, 34). Tuttavia gli Ebrei tramandano, come riferisce San Gerolamo nel suo commento all’Ecclesiaste, che alla fine della sua vita, angustiato da molte avversità, riconobbe il suo errore e si dispose a penitenza per i peccati commessi, e compose il libro che abbiamo nominato or ora, nel quale, come uno che l’ha sperimentato, afferma che tutte le cose sono soggette alla vanità, e si sottomette, per il timore di Dio, all’osservanza dei Suoi comandamenti. Perciò alla fine di questo libro (12, 13) conclude: «La fine di (tutto) il discorso ascoltiamola insieme: Temi Dio e osserva i Suoi comandamenti, perché tutto l’uomo sta qui».
• Ma, oltre ai re adoratori del vero Dio, che dirò dei prìncipi dei gentili? Essi, finché furono grati a Dio e coltivarono la virtù, ebbero un florido dominio; ma quando per la superbia del potere ebbero un comportamento contrario, finirono la loro vita con una brutta morte, come accadde al suddetto Ciro imperatore dei Persiani. La storia infatti racconta che, avendo sottomesso l’Asia e la Persia, tentò di soggiogare gli Sciti, portando loro una lunga guerra, durante il regno della regina Tamari, che dominava sui Massageti; e prima di tutto combattè contro il figlio della regina, che era ancora un adolescente; lo sconfisse e lo uccise e, senza risparmiare alcuna età, fece una grande strage. Poiché dunque fu crudele in Babilonia e nel regno di Lidia, trucidando con morte crudele in ambedue queste regioni re e prìncipi, e comportandosi allo stesso modo nel regno dei Massageti, Dio lo punì con uguale pena. Racconta infatti la storia che la regina Tamari radunò un esercito contro di lui - Sciti, Massageti e Parti - e fra i monti, per mezzo di insidie appositamente tramate, invase il suo accampamento: e lo prese così di sorpresa, con l’impeto degli armati, che duecentomila uomini di Ciro furono uccisi e lui stesso catturato; la regina, fattagli tagliare la testa, comandò che fosse rinchiusa in un otre pieno di sangue, e si gridasse contro di lui: «Hai avuto sete di sangue: bevi sangue!»; quasi che la morte ignominiosa subita fosse simbolo della sua atrocità.
• Lo stesso accadde a tutti i monarchi che vennero dopo di lui, come in Grecia ad Alessandro Magno. Questi fino a che trattò i suoi Macedoni con reverenza, chiamando padri i soldati perché più anziani di lui, fece grandi progressi nella sua monarchia; ma, diventato ad essi sgradito, fu avvelenato dalla sorella. Questo accadde soprattutto perché, dopo avere sconfitto Dario, avendone presa la figlia in moglie, incominciò a trascurare le cose militari, invischiato nella lussuria, e, divenuto immemore di sé, terminò la vita con una morte dolorosa.
• E così si può addurre l’esempio di molti altri prìncipi pagani, come Giulio Cesare e Annibale, che, per l’abuso che fecero del loro potere, furono uccisi crudelmente, affinché si avverassero per loro le parole dell’Ecclesiaste (8, 9): «Può talora capitare che un uomo domini sull’altro a suo proprio danno». E anche quella sentenza del Profeta Isaia che è valida riguardo a tutti i tiranni. Infatti, dopo aver mostrato che essi sono gli esecutori della giustizia divina contro i peccatori, quali carnefici dei loro dominanti, come si riscontra nelle parole che precedono (Isaia, 10, 5): «Assur verga del mio furore»; subito aggiunge: «Ma egli non ragionerà così e il suo cuore non penserà a questo modo (quasi egli agisse come strumento inconsapevole di Dio), anzi avrà in cuore di distruggere e di sterminare non poche nazioni. Infatti egli dirà: “I miei prìncipi non sono altrettanti re?”», attribuendo cioè questo alla propria virtù e non a Dio che lo muove per punire i trasgressori dei comandamenti divini. Ma subito il Signore rimprovera e punisce molto gravemente questa ingratitudine e presunzione dei tiranni, come risulta evidente nelle vicende dei prìncipi di cui abbiamo parlato prima. Perciò il Profeta nel medesimo luogo (Isaia, 15) aggiunge: «Come si glorierà la scure contro colui che con essa taglia? O si leverà la sega contro colui che l’ha fatta? Come se il bastone potesse alzarsi contro colui che lo sostiene; e alzandosi il bastone, esso non fosse pur sempre un legno».
• E qui dobbiamo considerare la similitudine, poiché è molto giusta. Infatti la virtù di chi governa sta a Dio come la virtù del bastone sta a colui che colpisce e come la virtù della sega all’artigiano che la usa. Ora è chiaro che la virtù della sega o della scure nell’azione è nulla, se non c’è l’opera dell’artigiano che la muove e la dirige: così è anche della virtù di chi esercita il dominio, la quale è nulla senza Dio che la muove e la dirige. È dunque cosa stolta e presuntuosa gloriarsi della propria virtù.
• Questo ragionamento è abbastanza chiaro e può essere dedotto dalle parole di Aristotele che abbiamo riportato prima. E poiché la virtù di qualsiasi motore mosso dipende dalla virtù del primo motore, questo sarà anche suo strumento. Perciò questa vanagloria dispiace a Dio, perché pretende limitare la potenza divina. Perciò in Giuditta sta scritto che «Dio umilia coloro che si gloriano della propria virtù»; e il già citato profeta Isaia afferma: «Per questo il dominatore, il Signore degli eserciti, manderà nelle sue impinguate carni l’estenuazione, e sotto la sua gloria si accenderà un incendio, come un incendio di fuoco». E in questo è simboleggiata, sia la pena sensibile che viene inflitta a tali tiranni, sia la perdita del regno, come risulta evidente dagli esempi precedenti. Resta dunque che ogni potere, sia esso legittimo o tirannico, viene da Dio, secondo le diverse vie della Sua imperscrutabile Provvidenza.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo VIII del Libro III: Qui si dimostra come talora il dominio vada a danno dei dominanti; perché, insuperbitisi per la loro ingratitudine, vengono pesantemente abbattuti. - La prossima settimana, a Dio piacendo, studieremo il Capitolo IX del Libro III: Il dominio che l’uomo ha per natura sugli animali selvatici e sulle altre cose prive di ragione. Ah!, se i politici nostrani piegassero il loro intelletto a questi santi insegnamenti!
• Ma c’è anche un’altra ragione per cui un dominio viene talora permesso da Dio. La desumiamo dalla Scrittura, anche se non contrasta con i pareri dei filosofi e dei sapienti di questo mondo. È quella che Sant’Agostino illustra nel diciannovesimo libro del De civitate Dei. In quel luogo egli dimostra che la schiavitù fu introdotta a causa del peccato. Perciò anche la Sacra Scrittura dice: «Fa regnare il malvagio per i peccati del popolo» (Giobbe, 34, 30). E questo appare chiaramente dal fatto che nei primi tempi coloro che nel mondo esercitarono il dominio furono uomini iniqui, come narra la storia. Caino, per esempio, Nembrot, Belo, Nino e sua moglie Semiramide che dominarono nella prima e nella seconda età del mondo.
• La ragione poi per cui costoro ebbero il dominio si può desumere o dai sudditi, o dai dominanti stessi: perché i tiranni sono lo strumento della giustizia divina per punire i delitti degli uomini, come il re degli Assiri per il popolo d’Israele, e il re dei Goti, flagello di Dio per l’Italia, come racconta la storia. Lo stesso fu Dionigi in Sicilia: sotto il suo dominio il popolo fu reso schiavo, e infine da lui rimesso in libertà, come narra Valerio Massimo nel quarto libro. E in quale maniera il re degli Assiri fosse destinato a punire i delitti del popolo è mostrato dal profeta Isaia: «Assur è la verga del mio furore, egli è il mio bastone; in mano a lui la mia collera. Io lo manderò alla nazione perfida e contro il popolo della mia indignazione; e gli ordinerò di saccheggiare e di depredare e di calpestarlo come il fango delle piazze» (Isaia, 10, 5 segg.). E tutte queste cose si avverarono quando Gerusalemme fu assediata dai Caldei, presa e incendiata da Nabucodonosor re degli Assiri, i suoi prìncipi catturati col re Sedecia, al quale furono cavati gli occhi e i figli uccisi, come è raccontato alla fine del quarto Libro dei Re: da ciò risulta sufficientemente chiaro come Dio punisca i peccatori per mano dei tiranni. Perciò si può concludere che essi sono strumento di Dio come i demoni, il cui potere è considerato dai sacri dottori sempre giusto, anche se la volontà loro è sempre perversa. E questo ce lo mostra anche il governo tirannico in sé, perché non è ordinato se non a gravare e molestare i sudditi. È proprio del tiranno infatti cercare soltanto la propria utilità e il proprio comodo, come abbiamo detto prima e come insegna Aristotele nell’ottavo libro dell’Etica, dove afferma che il tiranno si comporta coi sudditi come il padrone con gli schiavi e come l’artigiano con l’organo, ossia con lo strumento. Ora, questo è una sofferenza per i sudditi e contrario alla natura del dominio, come sopra abbiamo dimostrato. Ma anche se si esamina la cosa in rapporto ai regnanti, appare chiaro che un tale dominio può essere concesso da Dio, in primo luogo come nel caso già contemplato; oppure perché Dio dispone per i sudditi un destino migliore, cioè perché il principe, benché peccatore, è portato ad agire secondo la volontà di Dio, come dice Isaia (45, 1) riguardo a Ciro re dei Persiani: «Così dice il Signore a Ciro mio unto, che ho preso per la destra per assoggettare a lui le nazioni e far voltare le spalle ai re; aprire davanti a lui le porte e schiudere i serrami». E questo si adempì, come insegna la storia, quando, prosciugatisi improvvisamente l’Eufrate ed il Tigri che attraversavano Babilonia, entrò in città e uccise il re Baldassarre con la sua gente, e distrusse la città stessa, trasferendone il dominio ai Medi, sui quali allora regnava Dario, parente di Ciro, come scrive Giuseppe. Dio aveva predisposto così perché Ciro si era mostrato umano nei confronti dei fedeli Giudei che erano tenuti prigionieri in Assiria e che egli rimandò liberi in Giudea con i vasi del tempio, comandando di riedificare il tempio stesso. Egli, a causa di queste opere buone e virtuose, ottenne il dominio di tutto l’Oriente, come sopra abbiamo visto.
• Baldassarre invece fu ucciso, come appare dalle parole di Daniele: «Non conservasti umile il tuo cuore, ma ti sei levato contro il Dominatore del Cielo; i vasi della sua casa furono portati davanti a te e in essi tu e i tuoi nobili e le tue mogli e le tue concubine avete bevuto il vino.... mentre al Dio che ha in sua mano il tuo alito e tutti i tuoi destini non hai reso gloria. Per questi motivi dunque sono state mandate da lui le dita della mano che vergò lo scritto qui davanti tracciato» (Daniele, 5, 22-24). E quello che apprendiamo dalla divina sentenza contro di lui, dopo fu provato dal verificarsi del fatto. Infatti la storia di Daniele narra che mentre Baldassarre, re dei Babilonesi, persisteva nell’offendere Dio, come risulta da ciò che abbiamo detto, di fronte alla tavola dove banchettava vide le dita di una mano che scrivevano sulla parete: ed egli rimase terrorizzato da quella scrittura, come se fosse l’annuncio della sua morte. Racconta infatti il libro di Daniele che, dalla visione dello scrivente, di cui non vedeva se non le dita della mano, il volto del re restò atterrito e i pensieri lo turbavano, le compagini dei suoi reni si dissolvevano e le sue ginocchia si percuotevano a vicenda: e tutte queste cose erano indizi del suo grandissimo timore e del giudizio che ci sarebbe stato contro di lui. Ma siccome il re non riusciva a capire quella scrittura, fu chiamato Daniele, il quale nelle tre parole comprese ed annunziò la sua morte imminente. Le tre parole erano: Mane, Thecel, Phares. Mane: «Dio ha contato il tuo regno e lo ha fatto terminare», cioè lo ha posto sul limitare, come la somma già contata, che viene tolta e separata dalla massa del denaro. Thecel: «Sei stato pesato sulla bilancia, e sei stato trovato mancante», perciò sei meritevole di morte. Phares: «Il tuo regno fu diviso e dato ai Medi e ai Persiani», come abbiamo visto prima. E da tutte queste cose si è capito con sufficiente chiarezza che quelle parole non hanno propriamente un significato secondo una qualche lingua, ma secondo una predisposizione divina, come un fatto qualsiasi, nel quale un Profeta comprende la volontà di Dio a nostro riguardo. Si può dunque concludere che Dio in quella scritta espresse la sentenza contro il re di Babilonia, che per i suoi peccati meritava la morte e la perdita del regno, secondo le parole della Scrittura: «Da un popolo all’altro si trasferisce il regno a causa delle ingiustizie e delle frodi» (Ecclesiastico, 10, 8).
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Capitolo VII del Libro III: Come Dio talora permetta certe dominazioni per la punizione dei malvagi, e come un tale dominio sia quasi uno strumento della giustizia divina contro i peccatori.
• La terza virtù, per la quale i Romani sottomisero il mondo e meritarono l’impero fu la singolare pietà e la benevolenza civile; poiché, come dice Valerio Massimo nel quinto libro, «la dolcezza dell’affabilità penetra nell’animo dei barbari»; e questo è provato dall’esperienza. Perciò nel libro dell’Ecclesiastico (6,5) sta scritto che «la parola soave moltiplica gli amici e placa i nemici». Sempre la Scrittura dice: «Una risposta dolce calma l’ira e una parola aspra desta la collera» (Proverbi, 15,1). E la ragione di questo si desume dalla generosità dell’animo «il quale, dice Seneca, è piuttosto condotto che non trascinato. La mente infatti ha qualcosa di eccelso e di alto che non tollera ciò che le è superiore, ma è sottomessa dal piacere di una certa reverenza o dolcezza, per mezzo della quale immagina di poter conseguire ciò che le è pari e di non discendere dalla propria altezza». Perciò anche Aristotele nel settimo libro dell’Etica dice che «la benevolenza è il principio dell’amicizia». Quanto poi gli antichi Romani siano stati eccellenti in questa virtù, con cui trassero all’amore verso di sé i popoli stranieri e ottennero il loro spontaneo assoggettamento, ce lo mostreranno i loro esempi.
• E prima di tutto l’esempio di Scipione il quale, come racconta Valerio Massimo nel quarto libro, trovandosi in Ispagna come comandante dell’esercito romano contro la gente di Annibale, a ventiquattro anni, avendo colà sottomesso Cartagena fondata dai Fenici, prese in essa una vergine di eccezionale bellezza; ma appena venne a sapere che essa era di nobile famiglia e promessa sposa, la restituì inviolata ai genitori e aggiunse alla sua dote l’oro che gli era stato consegnato per il suo riscatto.
• Con questo comportamento spinse all’amore per i Romani i nemici stessi ammirati dalla tanto casta morigeratezza di questo condottiero; poiché, mentre egli, come lo stesso autore racconta, da giovane fu piuttosto dissoluto, trovandosi in una situazione di così grande libertà e potere, sì conservò immune da ogni colpa. Perciò Tito Livio, nel suo racconto della guerra punica, narra che Scipione parlò allo sposo della vergine e in quel discorso mostrò una pudicizia degna d’imitazione da parte dei prìncipi e meritevole del comando. Sempre riguardo a lui lo stesso Livio scrive che in quella vittoria ebbe un comportamento invitante alla benevolenza. Infatti, nell’inviare a Roma gli ostaggi, prima li esortò tutti a stare di buon animo, dal momento che erano caduti in mano dei Romani, «che preferiscono legare a sé gli uomini col beneficio piuttosto che col timore, ed avere unite a sé le genti straniere con la fedeltà e l’amicizia, piuttosto che tenerle sottomesse con un’infelice schiavitù».
• A questo proposito anche Sant’Agostino nel primo libro del De civitate Dei dice che fu proprio dei Romani «perdonare ai sottomessi e debellare i superbi»; e che, se avevano ricevuto un’ingiuria, preferivano perdonare piuttosto che vendicarsi. Il medesimo Dottore nello stesso libro racconta anche dì Marco Marcello che sparse le lacrime davanti alle rovine di Siracusa che aveva espugnato; ed ebbe una così grande pudicizia e continenza d’animo e un cuore così buono che, prima di ordinare l’assalto della città, stabilì con pubblico editto che nessuno osasse violare il corpo di un uomo libero.
• Ma a che pro insistere con altri esempi? Quando anche i Maccabei, cioè Giuda, Gionata e Simone, della stirpe dei Giudei, che erano soliti disprezzare l’alleanza di altre nazioni - sia perché, come dice Macrobio nel commento al Somnium Scipionis, erano saturnini, sia perché le leggi loro lo impedivano - considerata la benevolenza dei Romani, stabilirono con essi un’alleanza, come è scritto nel primo libro dei Maccabei; e in questo libro, tra le altre cose elogiative su di essi, per cui attiravano genti e popoli diversi alla propria alleanza e alla sottomissione politica o dispotica, si sottolinea in breve che dei capi romani «nessuno portava il diadema né si vestiva di porpora per grandeggiare in essa. Inoltre essi hanno costituito una curia e ogni giorno vi tengono consiglio in trecentoventi per il bene del popolo. E ogni anno affidano a un solo uomo la loro magistratura suprema per comandare su tutto il loro territorio, e tutti gli obbediscono, e non c’è tra loro invidia e rivalità». E qui si deve osservare come era ben ordinato a quell’epoca il governo in Roma: era questo il motivo principale per cui ogni nazione e provincia desiderava di essere governata dai Romani e di sottomettersi ad essi.
• C’era però anche un altro motivo che induceva ad assoggettarsi a loro: essi non si facevano chiamare, per cupidigia di potere, signori, ma alleati e amici. Svetonio ricorda che Giulio Cesare non chiamava suoi dipendenti i soldati, ma compagni e commilitoni. Alla stessa maniera si comportavano pure gli antichi Consoli verso i Giudei, i quali, pur avendo un modesto dominio in Oriente, si allearono con i Romani con un patto di amicizia. E, pur avendo i Romani un grande impero in Oriente e in Occidente, e nelle altre parti del mondo, come risulta chiaramente dal primo libro dei Maccabei, di cui abbiamo parlato prima, non sdegnarono di allearsi con i Giudei e, con un pubblico editto, riconoscersi reciprocamente alla pari.
• Dalle cose che abbiamo detto risulta chiaro, quindi, che gli antichi Romani meritarono l’impero per la loro virtù; perciò anche altre nazioni si sottomisero al loro dominio, sia per il loro amor di patria, per la quale disprezzavano ogni altra cosa; sia per il loro attaccamento alla giustizia, per la quale si opponevano ad ogni malfattore e perturbatore della pace; sia per la loro benevolenza civile, con la quale traevano le altre nazioni al loro amore. Per tutte queste cose insieme sembra che la divina bontà abbia loro concesso l’impero, per i motivi e le ragioni che abbiamo addotto. Così infatti si merita il potere, come insegna Aristotele nel quinto libro dell’Etica, poiché, com’egli dice, non ci si lascia dominare da un uomo in cui sia soltanto la natura umana, ma da uno che sia perfetto secondo ragione, ossia nel modo che abbiamo descritto.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro III, Capitolo VI, Come da Dio fu concesso l’impero ai Romani per la loro benevolenza civile.
• C’è anche un’altra ragione per la quale i Romani furono degni di avere l’impero, e cioè lo zelo per la giustizia. E in questo modo ebbero la preminenza come per un diritto di natura, dal quale trae origine ogni giusto dominio. E in primo luogo perché, come scrive il medesimo santo Dottore (Agostino, ndR), deliberavano per la patria con decisioni libere, dal momento che tenevano fuori dal dominio l’avarizia e anche l’amore del guadagno disonesto, e non erano soggiogati dalla colpa e dal vizio, cose per le quali può andare in rovina un dominio già stabile. Gli uomini erano attratti alla benevolenza verso di loro, cosicché a causa delle loro leggi così giuste si sottomettevano spontaneamente. Perciò lo stesso Apostolo Paolo, essendo troppo vessato e ingiuriato dai Giudei, si appellò a Cesare dinanzi al governatore Pesto in Cesarea di Palestina, e si sottopose alle leggi romane, come ci è raccontato dagli Atti degli Apostoli.
• Di che qualità poi erano le loro leggi e come erano giuste, ce ne parlano sempre gli Atti quando raccontano che, trovandosi Pesto a Gerusalemme, andarono da lui i prìncipi dei sacerdoti e i sacerdoti a chiedere la condanna a morte di Paolo; e ad essi Pesto, soggetto alle leggi romane, rispose che non era consuetudine dei Romani condannare o assolvere chicchessia, se non erano presenti gli accusatori e non aveva luogo la difesa per scagionarsi dal delitto. Perciò il medesimo dottore Sant’Agostino nel diciottesimo libro De Civitate Dei dice che «piacque a Dio soggiogare per mezzo dei Romani tutto il mondo, affinchè, unito in una sola società di governo e di leggi, potesse in ogni parte pacificarlo».
• Secondo, è dì diritto naturale che chi ha cura di un altro abbia una ricompensa per il fatto che, come è scritto nell’Ecclesiastico (17, 12), «Dio ha affidato a ciascuno di provvedere al suo prossimo». Per questo motivo il diritto permette di appropriarsi delle cose altrui, di sottrarre le spese, di ricevere un premio conforme al merito dell’azione, quando i beni suddetti sono male adoperati da predoni o da altri ladroni. Ciò posto appare chiaro che è conforme alla natura il fatto che il dominio sia concesso per conservare la pace e la giustizia e per eliminare liti e discordie.
• Terzo, è compito di chi governa provvedere a che i cattivi siano puniti e i buoni premiati; e in questo compito chi governa deve ricavare il suo guadagno; poiché da questo riceve sovvenzioni e tributi. Perciò, San Paolo, dopo aver spiegato che ogni potere proviene da Dio: «Non v’è potestà se non da Dio», e tutte le altre cose riguardanti il potere contenute in questo brano, infine conclude: «Per questo anche voi pagate i tributi: perché costoro sono ministri di Dio da lui deputati a questo» (Rom., 13, 1). In quanto dunque degli uomini virtuosi ed eminenti per la loro probità si assumono la cura di governare un popolo che manca di un Re e non ha un reggente e lo tengono sottomesso alle leggi, non soltanto si muovono per una sorta di istinto divino, ma fanno le veci di Dio in terra, perché mantengono il popolo in una società civile, della quale l’uomo ha necessariamente bisogno, dal momento che egli è per natura un animale sociale, come dice Aristotele nel primo libro della Politica. Perciò è chiaro, anche da questo punto di vista, che il dominio [dei Romani] era legittimo.
• E questo lo prova anche Sant’Agostino nel quarto libro del De civitate Dei; infatti egli dice così: «Una volta allontanata la giustizia, che cosa sono gli stessi regni se non latrocini?». Dunque, supposta questa virtù, appare chiaro che il regno, o qualsiasi altra forma di governo, viene ad essere legittimato. Per provare il suo intento egli porta poi l’esempio di un pirata che si chiamava Dionide. Alessandro Magno, avendolo catturato, gli chiese perché infestasse il mare. Ed egli con sfrontatezza rispose: «Come fai tu per tutta la terra. Ma, siccome io lo faccio su una povera navicella, sono chiamato ladro; tu, invece, che lo fai con una grande flotta, sei chiamato imperatore». Per questa ragione, dunque, ai Romani fu dato da Dio il dominio.
• Perciò il medesimo santo Dottore, nel quinto libro della stessa opera, afferma che essi avendo, con le loro leggi giustissime, aspirato quasi per la retta via agli onori, al comando e alla gloria, non hanno di che lamentarsi della giustizia del sommo e vero Dio: infatti hanno ricevuto la loro mercede, dominando con giustizia e governando legittimamente. Quanto grande poi sia stato lo zelo per la giustizia degli antichi consoli romani contro i cattivi è provato da molti fatti. Perciò Sant’Agostino, nel quinto libro dell’opera che abbiamo spesso citato, ricorda che Bruto fece uccidere i suoi figli perché sollevavano discordie nel popolo: quindi a rigore delle leggi vigenti meritavano la morte. In lui, infatti, come dice il Poeta [Virgilio], «ebbe il sopravvento l’amore di patria e il grande desiderio di lodi». Racconta anche di M. Torquato, che fece la stessa cosa col proprio figlio, poiché contro l’ordine del padre, spinto da una sorta di ardore giovanile, aveva assalito i nemici; e quantunque fosse riuscito vittorioso, tuttavia, poiché aveva esposto al pericolo l’esercito dei suoi, lo condannò a morte secondo le leggi militari. Lo stesso Santo - Agostino - spiega a questo punto la ragione della sua morte, dicendo: «Affinchè il cattivo esempio dell’ordine trasgredito non costituisse un male più grande del bene della vittoria riportata sul nemico». E Valerio Massimo, sempre riguardo a lui, dice che preferì privarsi del proprio figlio piuttosto che essere indulgente su trasgressioni della disciplina militare. Così dunque appare chiaramente come per lo zelo della giustizia legale i Romani meritarono il dominio.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro III, Capitolo V, Come i Romani meritarono il dominio per le ottime leggi da essi emanate.
• Poiché fra tutti i re e i prìncipi del mondo i romani furono i più solleciti verso le cose di cui abbiamo parlato, Dio li ispirò per governare bene, e perciò degnamente meritarono l’impero, come prova Sant’Agostino nel De civitate Dei, per diverse cause e ragioni che qui, riassumendo, possiamo ridurre a tre - lasciando da parte le altre per motivi di brevità -, in considerazione delle quali meritarono il dominio.
• La prima ragione si trova nell’amor di patria; la seconda nello zelo per la giustizia; la terza nella cura per la concordia civile.
• La prima di celeste virtù era già da sola degna dell’impero; perché per mezzo di essa partecipavano in qualche modo della natura divina, nella misura in cui indirizzavano il loro effetto alla collettività. Essa infatti è rivolta agli interessi universali del popolo, così come Dio è la causa universale del creato; cosicché Aristotele nel primo libro dell’Etica afferma che «il bene di un popolo è un bene divino». E poiché il governo regale, e qualsiasi altra forma di governo, implicano una comunità, colui che ama la comunità merita la comunità del dominio, ottenendo così un premio conforme alla qualità del merito. La natura infatti della giustizia divina esige che si dia a ciascuno un premio conforme all’opera di virtù che egli compie, affinchè si adempia la parola dell’Apocalisse: «Le loro opere li seguono». E ancora nel Vangelo di San Matteo sta scritto, che «il Signore diede a ciascuno secondo la propria virtù».
• Secondo, l’amor di patria ha fondamento nella radice della carità che antepone le cose comuni alle proprie, non le proprie alle comuni, come dice Sant’Agostino quando spiega il passo di San Paolo sulla carità. Ora, la virtù della carità, nel merito viene prima di ogni altra virtù, perché il merito di qualunque virtù dipende dalla virtù della carità. Dunque l’amor di patria merita un grado d’onore superiore alle altre virtù; e questo è il potere.
• Quindi è giusto che uno ottenga il principato a causa dell’amore. Di questo amore di patria Cicerone afferma nel De officiis, che «fra tutti i legami nessuno è più gradito, nessuno è più caro di quello che si ha con la propria patria. Infatti ad ognuno di noi sono cari i genitori, i figli, i parenti e i familiari, ma la patria col suo amore abbraccia le parentele di tutti; e per essa quale uomo giusto esiterà ad affrontare la morte, se potrà giovarle?».
• Quanto grande poi fosse l’amor di patria negli antichi romani, lo riferisce Sallustio nel Catilinario, con una sentenza di Catone, che elenca alcune loro virtù, fra le quali è compreso questo amore: «Non crediate - dice - che i nostri antenati abbiano fatto grande la repubblica (da piccola che era) con le armi, poiché noi abbiamo una maggiore quantità di armi rispetto a loro; ma la fecero grande perché erano operosi in patria, fuori comandavano con giustizia, nel deliberare avevano un animo libero e non soggetto alla colpa e alle passioni. Noi, invece, al posto di queste qualità abbiamo il lusso e l’avarizia, nella cosa pubblica la miseria, nelle cose private l’opulenza, elogiamo le ricchezze, siamo indolenti, non facciamo alcuna distinzione fra buoni e cattivi e l’ambizione occupa tutti i posti meritati dalla virtù».
• Terzo, l’amor di patria contiene in sé il primo e più grande comandamento, di cui parla il Vangelo di San Luca, perché colui che si occupa con zelo della cosa pubblica acquista una somiglianza con la natura divina poiché diligentemente prende cura del popolo, facendo le veci di Dio. Adempie inoltre il comandamento dell’amore del prossimo, dal momento che uno ha cura con amore paterno di tutto il popolo che gli è stato affidato, e così rispetta il predetto comandamento, che nel Deuteronomio (6, 5) è espresso in questi termini: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso».
• E poiché da questo precetto divino nessuno è dispensato, ne deriva quello che dice Cicerone riguardo allo Stato, che nessun motivo può sopravvenire, in base al quale si possa rinnegare la propria patria.
• Di questo amore della patria abbiamo un esempio - tramandato dalla storia e riferito anche da Sant’Agostino nel quinto libro del De civitate Dei - nel nobile soldato Marco Curzio che, armato, si lanciò a cavallo in una voragine per allontanare la pestilenza da Roma. Così pure in Marco Attilio Regolo, il quale, avendo preferito la salvezza della Repubblica alla sua, quando fu interpellato dal popolo romano mentre fungeva da mediatore di pace fra il suo popolo ed i Cartaginesi, tornato in Africa, fu ucciso dai Cartaginesi. E fino a che punto i loro capi ebbero, per la salvezza della Repubblica, le mani monde da donativi, risulta chiaro dall’esempio di Manlio Curio, del quale Valerio Massimo nel quarto libro descrive come disprezzò le ricchezze dei Sanniti. Infatti, dopo aver riportato una vittoria su di loro, essendo stati i loro ambasciatori ammessi alla sua presenza, e avendolo trovato seduto su uno sgabello mentre cenava in una scodella di legno, gli offrirono una grande quantità di oro, invitandolo espressamente ad appropriarsene. Ed egli subito, ridendo, rispose: «È inutile: dite ai Sanniti che M. Curio preferisce comandare ai ricchi piuttosto che diventare ricco lui stesso. E ricordatevi che io non posso essere vinto in battaglia, né essere corrotto col denaro». Lo stesso autore racconta nello stesso libro [credo che San Tommaso stia citando il Factorum et dictorum memorabilium libri IX, ndR] un episodio simile di Fabrizio il quale, pur essendo ai suoi tempi superiore a tutti in onore e autorità, quanto al censo era il più povero; avendo i Sanniti, che egli aveva come clienti, cercato di accattivarselo, disprezzò il denaro e gli schiavi che gli avevano mandato, e li rimandò indietro delusi.
• «Per merito della sua parsimonia e per l’amor di patria fu ricchissimo senza denaro, e senza scorta di servitù fu abbondantemente accompagnato: poiché lo faceva ricco non già il possedere molto, ma il desiderare poco».
• Riguardo a queste persone il Santo Dottore citato [dovrebbe essere Sant’Agostino nel quinto libro del De civitate Dei, ndR] conclude che a loro non fu dato il potere di dominare se non dalla provvidenza del sommo Dio, allorché giudica che le vicende umane sono degne di doni così grandi. E aggiunge molte considerazioni simili, per mezzo delle quali stabilisce che il loro dominio fu legittimo e fu dato loro da Dio.
• Ma anche Matatia e i suoi figli, che pure appartenevano ad una famiglia sacerdotale, per l’amore verso la legge e verso la patria meritarono il comando nel popolo d’Israele, come risulta dal primo e dal secondo libro dei Maccabei. Essendo infatti vicino alla morte, egli così parlò ai suoi figliuoli; «Siate osservanti della Legge e date le vostre anime per la tradizione dei padri». E questo per Israele era l’equivalente dello Stato. Poi aggiunse: «E avrete una grande gloria e un nome eterno». Parole che possiamo riferire al principato dei figli dei quali l’uno successe all’altro, cioè Giuda, Gionata e Simone; e ognuno di essi, sacerdote e principe, fu potente in mezzo al popolo d’Israele.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro III, Capitolo IV, Come l’impero fu concesso da Dio ai Romani per il loro amor di patria.
• Anche partendo dal fine risulta chiara la stessa cosa. Infatti, se è proprio dell’uomo agire in vista del fine a causa del suo intelletto che in ciascuna azione predispone un fine, ogni natura, quanto più è intellettiva, tanto più agisce in vista del fine. Essendo dunque Dio la suprema intelligenza e puro atto intellettivo, la Sua azione deve implicare un fine in misura più grande. Dunque dobbiamo affermare che in ciascun fine particolare di ogni cosa creata è presupposta l’azione dell’intelletto divino, che noi chiamiamo anche prudenza divina, per mezzo della quale il Signore dispone tutte le cose e le guida al fine dovuto. È così che la chiama Boezio nel De consolatione philosophiae. Perciò nel libro della Sapienza è detto che la Sapienza di Dio «con sicurezza giunge da fine a fine e dispone dolcemente tutte le cose». Da ciò dunque si conclude che quanto più una cosa è ordinata a un fine più elevato, tanto più partecipa dell’azione divina. È proprio di tal fatta il governo di qualsiasi comunità, o collettività, sia esso di natura regale o di qualsiasi altro tipo: perché, essendo ordinato a un fine nobilissimo, come accenna Aristotele nell’Etica e nel primo libro della Politica, in esso deve presupporsi l’azione divina, e il governo di coloro che sono a capo della comunità è sottomesso alla sua virtù. E da questo forse trae verità il fatto che il bene comune da Aristotele nell’Etica sia chiamato «potenza».
• Secondo, nel governare il legislatore deve sempre mirare a che i cittadini siano guidati a vivere secondo virtù, anzi è proprio questo il fine del legislatore, come afferma Aristotele nel secondo libro dell’Etica. Perciò anche San Paolo afferma che «il fine dell’ammaestramento è la carità» (1 Tim., 1,5). Ma non possiamo conseguire questo fine senza un moto di origine divina, così come il calore non può riscaldare senza la virtù del calore del fuoco e ciò che è luminoso non può illuminare senza la virtù della luce. Però il movimento del primo movente è tanto più alto, quanto la virtù divina supera e trascende la virtù creata e ogni tipo di operazione; e influisce tanto più fortemente, al punto che il profeta Isaia dice: «Tutte le opere nostre tu hai operato per noi, o Signore» (Isaia, 26, 12); e la parola evangelica: «Senza di me non potete fare nulla» (Gv., 15, 5).
• Terzo, un fine muove tanto più efficacemente quanto più viene trovato nobile e migliore, come lo è il bene di un popolo rispetto al bene di una città, o di una famiglia, secondo quanto afferma Aristotele nel primo libro della Politica. Ora, il fine al quale principalmente il re deve tendere - e per se stesso e per i suoi sudditi - è la beatitudine eterna, la quale consiste nella visione di Dio. E poiché questa visione è il bene perfettissimo, deve muovere nella misura più grande possibile il re e qualunque governante, affinché i sudditi possano conseguire questo fine. Perché il suo governo allora è ottimo, quando in lui esiste un tale intendimento.
• In questo modo reggeva e governava i suoi il Re e Sacerdote Cristo Gesù, il quale diceva: «Io dò loro la vita eterna» (Gv., 10, 28); ed ancora: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano abbondantemente» (Gv., 10, 10). E questo compito il re lo assolve pienamente quando vigila sul suo gregge come il buon pastore; perché allora sopra di lui si irradia la luce divina, affinché possa ben governare, come s’irradiò sui pastori alla nascita del nostro Re e Salvatore. E questa irradiazione relativa al buon governo, sia sul principe che sui sudditi, si esplica nei tre moti circolare, retto ed obliquo, cui abbiamo accennato sopra e dei quali parla San Dionigi nel quarto capitolo del De divinis Nominibus. Infatti questo moto viene detto retto perché viene per illuminazione diretta divina sul principe affinché governi bene, e sul popolo per i meriti del principe. Ma si chiama obliquo quando, grazie all’illuminazione divina, governa i sudditi in modo tale che essi vivano virtuosamente e sorga in essi la lode verso Dio e il rendimento di grazie, in modo tale che si forma come la figura di un arco, formata da una corda retta ed un arco obliquo.
• Il movimento poi dei raggi divini si dice circolare, quando l’illuminazione divina irradia sul principe, o sul suddito, in modo da elevarli a contemplare ed amare Dio: e codesto moto si chiama allora circolare, perché parte da una sorgente per ritornare alla stessa, ossia al punto di partenza; e questo è proprio del moto circolare. Aristotele parla di questo movimento nel dodicesimo libro della Metafisica, dove dice che «il motore primo, cioè la causa prima, cioè Dio, muove le altre cose in qualità di cosa desiderata», cioè sotto l’aspetto di fine che è Lui stesso.
• Di questo parla anche il profeta Davide nel Salmo LXXI, sebbene il testo secondo i sacri Dottori debba essere riferito a Cristo nostro Re: «O Dio, il tuo giudizio concedi al re; e la tua giustizia al figliuolo di re; perché giudichi il tuo popolo con giustizia e i tuoi poveri con (equo) giudizio. Portino i monti la pace al popolo e i colli la giustizia!». E queste espressioni certo sono preghiere che un re e qualunque altro governante deve rivolgere a Dio per il buon governo del popolo, cui essi soprattutto devono tendere, come sopra abbiamo detto. E posto che abbiamo la mente così disposta a ricevere l’influsso divino per la salute dei sudditi, il Salmo aggiunge: «Scenderà come pioggia sulla messe, e come acqua irrorante la terra. Spunterà ai suoi dì la giustizia, e abbondanza di pace».
• Da tutte queste cose risulta abbastanza chiaramente che il potere proviene da Dio, sia considerando il fine remoto, che è Dio stesso, sia considerando il fine prossimo, che è l’agire secondo virtù.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro III, Capitolo III, Qui l’Autore prova la stessa cosa partendo dal fine.
• Come dice il libro dei Proverbi: «II cuore del re è nelle mani di Dio; a tutto ciò che vuole, Egli lo piega». E questo lo confessa anche il famoso grande monarca d’Oriente, Ciro, Re dei Persiani, con un editto pubblico. Infatti dopo aver sconfitto Babilonia, che aveva raso al suolo, come narra la storia, disse queste parole, come risulta all’inizio del Libro di Esdra: «Così dice Ciro Re dei Persiani: - Il Signore, l’Iddio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra». Da ciò risulta evidente che ogni dominio proviene da Dio come dal primo signore: cosa che si può dimostrare, come accenna Aristotele, mediante tre vie, cioè considerandolo in quanto ente, in quanto motore, in quanto fine.
• Sotto l’aspetto di ente: perché tutti i singoli enti si devono ricondurre al primo ente, come a principio di ogni ente, come ogni calore si deve ricondurre al calore del fuoco, secondo le spiegazioni di Aristotele nel secondo libro della Metafisica. Dunque, per la stessa ragione per cui ogni ente dipende dal primo ente, dipenderà da lui anche il dominio; poiché esso si fonda sull’ente; e su un ente tanto più nobile, quanto, per dominare sugli uomini di natura uguali, un uomo viene anteposto ad essi. Ma da questo uno non deve trarre motivo di insuperbire, bensì di governare con umanità il suo popolo, come dice Seneca in una lettera a Lucilio. Ecco perché nell’Ecclesiastico sta scritto: «Ti hanno fatto capo? Non mettere superbia: sii tra loro come uno di essi». Perciò, come ogni ente dipende dal primo ente, che è la causa prima, così anche ogni dominio della creatura dipende da Dio come da primo dominante e primo ente.
• Di più: ogni pluralità procede dall’uno, e si misura con l’unità, come insegna il decimo libro della Filosofia Prima di Aristotele; dunque allo stesso modo anche la pluralità dei dominanti trae origine da un unico dominante, che è Dio. Precisamente come nella corte regale alle varie mansioni troviamo i rispettivi soprintendenti, ma tutti dipendono da uno solo, cioè dal re. Perciò Aristotele nel libro dodicesimo della Filosofia Prima dice che «Dio, cioè la causa prima, sta all’intero universo come il comandante, dal quale dipende tutta la molteplicità degli accampamenti, sta all’esercito». Perciò anche Mosè nell’Esodo chiama Dio condottiero del popolo: «Nella tua misericordia - dice - ti sei fatto condottiero del popolo che tu hai liberato». Dunque ogni dominio trae origine da Dio.
• Ancora, sullo stesso argomento: la virtù è proporzionata all’ente al quale appartiene e gli è adeguata; poiché la virtù scaturisce dall’essenza della cosa, come risulta chiaramente dal I e II libro de Il cielo di Aristotele. Dunque, come l’ente creato sta all’increato, che è Dio; così la virtù di ciascun ente creato sta alla virtù increata, anch’essa Dio, perché tutto ciò che è in Dio è Dio. Ma ogni ente creato trae origine dall’ente increato. Dunque la virtù creata trae origine da quella increata. Questo fatto poi è presupposto nel dominio, poiché non c’è dominio quando non ci sia potenza, o virtù; dunque ogni dominio deriverà dalla virtù increata, e questa è Dio, come abbiamo già detto. E così si ha la medesima conclusione di prima. Ecco perché San Paolo afferma (agli Ebrei), che Dio «sostiene ogni cosa con la potenza della sua parola». E nell’Ecclesiastico si legge: «Uno solo è l’altissimo, il creatore onnipotente, il re potente e terribile oltremodo, che siede sul suo trono. Iddio dominatore». Da queste affermazioni appare chiaramente chi sia colui da chi ogni creatura riceva l’essere, la virtù e l’operazione, e per conseguenza il dominio; e in misura molto maggiore il re, come già abbiamo dimostrato.
• Ma che il dominio provenga da Dio non si dimostra soltanto partendo dall’ente, ma anche partendo dal moto. E prima di tutto si deve assumere l’argomentazione di Aristotele nell’ottavo libro della Fisica: «Si parte cioè dal fatto che tutto ciò che si muove, viene mosso da altri. E d’altra parte nella serie dei moventi e dei soggetti mossi non si può andare all’infinito. Perciò si deve giungere ad un primo motore immobile che è Dio, ossia alla causa prima». Ora fra tutti gli uomini quelli che partecipano maggiormente del moto sono i re e i prìncipi e tutti coloro che stanno a capo, sia nel governare, sia nel giudicare, sia nel difendere, e in tutte le altre funzioni pertinenti alla cura del governo. Perciò Seneca nel suo opuscolo De Consolatione, indirizzato a Polibio, per esortarlo a disprezzare il mondo, così parla di Cesare: «Quando vorrai dimenticare tutto pensa a Cesare. Osserva quanta sicurezza tu debba alla bontà della sua vita, e quanta cura; comprenderai che a te non è dato piegarti più che a lui. Se nei miti si parla di qualcuno sulle cui spalle poggia il mondo, questo possiamo dirlo anche di Cesare, a cui tutto è lecito; e per lo stesso motivo molte cose non gli sono lecite: La sua vigilanza difende le cose di tutti, la sua fatica il riposo di tutti, la sua attività i piaceri di tutti. Per il fatto che Cesare si è dedicato a tutto il mondo, si è sottratto a se stesso; come gli astri che, mai fermi, seguono sempre il loro corso, e non possono mai fermarsi ne fare qualcosa di loro proprio».
• Se dunque ai re e agli altri signori va attribuito tanto moto, è chiaro che non possono compierlo se non mediante l’influsso e la virtù del primo motore, cioè di Dio, come abbiamo provato prima. Perciò nel libro della Sapienza, dove sono enumerati gli effetti della virtù divina per mezzo della sua sapienza, l’autore, volendo mostrare come tutte le cose partecipino l’influsso del moto divino, subito aggiunge: «Di tutto ciò che si muove è più mobile la sapienza, e arriva dappertutto a cagione della sua purezza». E chiama «purezza» l’assoluta, superiore e pura virtù con cui Dio muove ogni cosa a somiglianza della luce materiale che, sotto questo aspetto, imita la luce divina.
• Secondo, ogni causa primaria influisce sull’effetto più di una causa secondaria. Ora la causa prima è Dio. Dunque se tutte le cose si muovono in virtù della prima causa, e tutte ricevono l’influsso del primo moto, anche il moto di coloro che governano deriverà dalla virtù di Dio e dalla mozione divina.
• Terzo, se c’è una subordinazione nei moti corporali, ancora di più ci sarà in quelli spirituali. Così vediamo nei corpi, che gli inferiori sono mossi dai superiori, e tutti si riconducono al moto di quello supremo, che è la nona sfera, secondo Tolomeo (Almagesto, 1), ovvero l’ottava secondo Aristotele (Il cielo, 2). Dunque, se tutti i moti dei corpi sono regolati dal primo, e dal primo ricevono influsso, molto di più questo avverrà per le sostanze spirituali per la maggiore somiglianza che hanno tra loro. Perciò esse sono più adatte a ricevere l’influsso del primo e supremo motore che è Dio. Di questo moto tratta San Dionigi nei libri I nomi divini e La gerarchia celeste, distinguendo i moti delle sostanze spirituali come quelli nei corpi, in moto circolare, retto e obliquo. Questi moti poi consistono in particolari illuminazioni che ricevono dalle sostanze superiori, per agire, come spiega il medesimo Dottore; e per ricevere queste illuminazioni è necessaria la disposizione della mente su cui si esplica quest’influsso motore. Ora, fra tutti gli uomini che devono essere maggiormente disposti, vi sono i re, i prìncipi e gli altri dominatori del mondo, sia per la funzione che hanno, sia per tutte le universali funzioni di governo, per le quali la mente deve maggiormente elevarsi alle cose divine, sia perché ad essi incombe il dovere di disporre se stessi al governo del gregge, in modo tale da sentire efficacemente il moto impresso da Dio sui loro atti di governo, che sono ad essi superiori e che eccedono la natura particolare.
• Così infatti si dispose il Re David; e per questo, a causa del moto della divina illuminazione suddetta, meritò nei suoi Salmi uno spirito profetico superiore a quello di tutti i re e i profeti, come dicono i conoscitori della Sacra Scrittura. E, per un’azione contraria a questa, i prìncipi pagani, di cui parla il profeta Daniele, quali Nabucodonosor e Baldassarre, padre e figlio, meritarono di essere ottenebrati. Cosicché l’influsso dell’illuminazione divina mosse la loro fantasia a visioni immaginative, come risulta dal Libro di Daniele, affinché sapessero che cosa dovevano fare nel governo del regno; ma poiché la loro mente non era disposta, bensì avvolta nelle tenebre, non furono in grado di comprenderle. Ecco perché a Daniele, dotato di lume profetico, fu detto: «Ti fu dato lo spirito d’intelletto per interpretare queste cose»; affinchè si constatasse quello che Salomone dice nei Proverbi: «Mio è il consiglio e l’equità, mia la prudenza, mia la fortezza. Per me regnano i re e i legislatori decretano il giusto, per me i prìncipi dominano e i magistrati regolano la giustizia». Rimane quindi dimostrato, a partire dal moto, che ogni potere viene da Dio.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro III, Capitoli I e II, Si considera e si dimostra che ogni potere viene da Dio, partendo dalla sua natura di ente - Si dimostra la stessa cosa partendo dal moto di ogni natura creata.
• Passiamo ora a trattare del culto divino, al quale re e princìpi debbono applicarsi con tutto l’impegno e la sollecitudine, come al loro debito fine. Ecco perché ne parliamo qui, in quest’ultimo capitolo. Scrive in proposito il magnifico re Salomone nell’Ecclesiaste (XII,13): «La fine di ogni discorso ascoltiamola insieme: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché tutto l’uomo sta qui». E sebbene questo fine, cioè il culto divino e l’ossequio attraverso l’osservanza dei comandamenti, sia necessario per tutti, come è stato già detto, tuttavia al re è necessario in maggior misura, essendovi maggiormente tenuto per le tre qualità che sono in lui, e cioè: perché uomo, perché signore e perché re.
• In quanto uomo, perché creato da Dio in maniera singolare. Infatti le altre creature Dio le creò con il solo comando, ma quando creò l’uomo disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza» (Gen. 1, 26). Perciò San Paolo negli Atti degli Apostoli (XVII, 28) riferisce le parole del poeta Arato: «Noi siamo progenie di Dio». Dunque da questo punto di vista siamo tutti debitori nei confronti della divina maestà; e questo è il primo comandamento della prima tavola. Perciò nel Deuteronomio (VI,4) viene detto al popolo di Israele, e quindi anche a noi, per bocca di Mosè: «Ascolta, Israele: il Signore Dio nostro è il solo Signore»; come a dire che egli è il solo a cui sono dovuti riverenza e onore, in quanto solo da lui siamo stati creati e fatti per una prerogativa singolare. Perciò, considerata la grandezza del beneficio ricevuto, subito Mosè nello stesso punto aggiunge: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze»; volendo così dimostrare che dobbiamo a Dio tutto quello che siamo. E a riconoscimento di questo fu istituito il precetto delle decime, al quale ciascuno è tenuto, non nella stessa quantità numerica, ma in proporzione delle proprie sostanze per il motivo già detto.
• Ma, sebbene tutti siano obbligati a questo, tuttavia il principe lo è di più, anche come persona privata, in quanto partecipa maggiormente della nobiltà della natura umana, a causa della stirpe da cui trae origine e nobiltà, come prova Aristotele nella Retorica. Mosso da questa considerazione Cesare Augusto, cioè Ottaviano, - come narra la storia - non tollerando gli onori divini che gli venivano conferiti dal popolo romano per la bellezza del suo corpo e per la bontà del suo animo, domandò alla Sibilla Tiburtina chi fosse il suo creatore; lo trovò e lo adorò; e proibì con pubblico editto che qualcuno del popolo romano lo adorasse, o lo chiamasse Signore o Dio.
• Ma ancora di più il re è tenuto al culto di Dio in quanto signore, «perché non vi è potestà se non da Dio», come dice San Paolo nel 13° capitolo della Lettera ai Romani; cosicché egli fa le veci di Dio in terra, come abbiamo già detto. Perciò tutto il potere di chi comanda dipende da Dio, essendo quello di un Suo ministro. Ma dove c’è dipendenza nel dominio è necessario il rispetto verso il superiore, perché l’inferiore in sé non è nulla, come accade ai ministri delle curie regali. Perciò nell’Apocalisse ogni volta che si tratta del ministero degli spiriti celesti - che vengono presentati o come seniori, perché più perfezionati nell’agire, o come animali i quali subiscono l’azione più di quanto non agiscano, sotto la potente irradiazione divina -, di essi si aggiunge che «si prosternarono al suo cospetto, e adorarono Dio». E questi sono due atti di latria, cioè del culto divino.
• Ed ecco perché il famoso Nabucodonosor, monarca in Oriente, come è scritto nel Libro di Daniele (IV,22), poiché non aveva riconosciuto che il suo potere proveniva da Dio, nella sua immaginazione fu trasformato in bestia, e gli fu detto: «Sette tempi trascorreranno sopra di te, finché riconosca che l’Altissimo impera sopra il regno degli uomini e lo affida a chiunque vuole».
• Ammonito di ciò, - come narra la storia - Alessandro Magno nell’invadere la Giudea con l’intenzione di distruggere la regione, mentre si avvicinava a Gerusalemme adirato, vide venirsi incontro il Pontefice sommo vestito di bianco insieme ai ministri del tempio; allora si fece mansueto e, sceso da cavallo, lo riverì, quale ministro di Dio; ed entrato nel tempio lo onorò con grandissimi doni, e donò a tutto quel popolo la libertà, per riverenza verso Dio.
• Il re inoltre non solo è tenuto al culto divino come uomo e come signore, ma anche come re, perché i re sono unti con olio consacrato, come risulta chiaro nel caso dei re del popolo di Israele, che venivano unti con olio santo dalle mani dei Profeti: perciò erano anche detti unti del Signore, per eccellenza di virtù e di grazia in unione con Dio, delle quali dovevano essere dotati.
• Per questa unzione essi ottenevano un certo ossequio e un certo conferimento d’onore. Ecco perché Davide, avendo tagliato la clamide del re Saul, si percosse il petto in segno di penitenza, come è scritto nel primo Libro dei Re. Sempre il re Davide, come pianse con lamenti la morte di Saul e di Gionata, così deplorò l’irriverenza degli Aliofili, perché avevano ucciso il re Saul, senza tener conto, come è scritto alla fine del secondo Libro dei Re, che egli era stato unto con l’olio.
• Di questa consacrazione troviamo un altro argomento dalle gesta dei Franchi, sia dall’unzione di Clodoveo, primo cristiano tra i re dei Franchi, fatta da San Remigio, sia dal trasporto dell’olio dal cielo, per mezzo di una colomba; e con quest’olio fu unto il re suddetto; e vengono ancora unti i suoi successori con segni e prodigi e guarigioni di cui essi sono portatori a causa di codesta unzione.
• Inoltre, poi, come dice Sant’Agostino nella Città di Dio, l’unzione era figura del vero re e sacerdote, secondo quanto dice il profeta Daniele (IX): «Quando verrà il Santo dei Santi, cesserà la vostra unzione». Dunque, poiché nell’unzione raffigurano colui che è «Re dei re e Signore dei dominanti», come dice l’Apocalisse (XIX), che è Cristo nostro Signore, i re sono tenuti ad imitarlo, affinché sia rispettata la debita proporzione della figura col figurato, dell’ombra col corpo: e in tale imitazione è incluso anche il vero e perfetto culto verso Dio.
• Risulta dunque chiaro come sia necessario per qualunque signore, ma soprattutto per un re, essere devoto e reverente verso Dio, per la conservazione stessa del proprio stato: e di ciò possiamo trarre un esempio dal primo re di Roma, Romolo, il quale, come la storia tramanda, agli inizi del suo governo nella città di Roma, fabbricò un asilo che chiamò tempio della pace e lo dotò di molti privilegi. Per il dio [ivi adorato] e per rispetto verso di esso il tempio rendeva immune ogni scellerato - di qualunque stato fosse - che ci si rifugiasse. Quale sorte abbiano avuto poi i suoi successori che furono negligenti nel culto divino e quelli che invece furono solerti, lo scrive Valerio Massimo all’inizio della sua opera.
• Che dire poi dei re zelanti del culto divino, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento? Infatti tutti quelli che furono solleciti nel riverire Dio, terminarono felicemente il corso della loro vita; quelli che si comportarono nella maniera opposta, ebbero una fine infelice.
• La storia infatti racconta che in ogni monarchia dagli inizi dei tempi si accompagnarono a vicenda queste tre cose, e precisamente nell’ordine: il culto divino, la sapienza e la potenza secolare. Ora, queste tre cose si ottengono secondo l’ordine suddetto, come si riscontra nel re Salomone, per i suoi meriti. Infatti dopo essere stato proclamato re, mentre scendeva verso Ebron, luogo di preghiera, ottenne la sapienza, e in forza di queste due cose, ottenne il predominio sui re del suo tempo nella potenza regale. Quando invece si allontanò dal vero culto di Dio, ebbe una fine infelice, come risulta dal terzo Libro dei Re.
• Abbiamo così trattato in questo libro precisamente di quelle cose che riguardano il governo di qualsiasi Stato, ma specialmente di quello regale.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo XVI, L’obbligo per il re, come per qualunque altro governante, di attendere al culto divino e qual frutto ne segua.
• C’è poi anche un’altra cosa che riguarda il buon governo di un regno, di una provincia, di una città o di qualsiasi altro dominio: cioè che il capo dello Stato con l’erario comune provveda ai bisogni dei poveri, degli orfani e delle vedove, e assista i forestieri e i pellegrini.
• Infatti, se una natura qualsiasi non viene mai a mancare nelle cose necessarie - come scrive Aristotele nel terzo libro de «Il cielo e il mondo», molto meno dovrà farlo l’arte che imita la natura. Fra tutte le arti, poi, quella di vivere e di governare è più alta e più ampia, come insegna Cicerone nelle «Disputazioni tuscolane». Dunque i re e i prìncipi non devono abbandonare i bisognosi nelle necessità, ma anzi li devono aiutare.
• Inoltre i re e i prìncipi fanno le veci di Dio in terra: per mezzo di essi, quali cause seconde, Dio governa il mondo. Perciò anche il profeta Samuele, essendo stato rifiutato nel suo potere, lamentandosi davanti a Dio, ebbe questa risposta: che il popolo di Israele non aveva disprezzato lui, ma Dio stesso, di cui lui faceva le veci.
• E nel libro dei Proverbi (VIII, 15) sta scritto: «Per me regnano i re, e i legislatori decretano il giusto». Ma Dio si cura in maniera particolare dei poveri, per supplire alle mancanze della loro natura. Perciò la provvidenza divina nei confronti dell’indigente si comporta come un padre nei confronti dei figli menomati: di essi si preoccupa di più perché il loro bisogno è più grande. Per questo il Signore considera come fatto a sé in particolare ciò che viene fatto al povero, come attesta egli stesso, dicendo: «Tutte le volte che avete fatto qualche cosa a uno di questi minimi tra i miei fratelli, l’avete fatta a me» (Matteo, XXV, 40).
• Perciò prìncipi e prelati sono tenuti a supplire a questa indigenza dei poveri in quanto fanno le veci di Dio in terra, come dei padri che il dovere obbliga ad aiutare i sudditi. Perciò, come dice Aristotele nell’Etica, devono avere una cura particolare nei loro confronti, al fine di soccorrerli. Questa sollecitudine ebbe il re macedone Filippo nei confronti di Pizia il quale, prima, come scrive Vegezio nel terzo libro De rè militari, gli era ostile. Sentendo che questi, pur essendo nobile, soffriva nella miseria con le sue tre figlie, chiedendo a coloro che lo informavano di questo se fosse meglio tagliare via la parte malata del corpo, o curarla, lo chiamò famigliarmente a sé, lo rifornì con denaro preso dalle sue ricchezze personali, e da allora in avanti lo ebbe fedelissimo.
• Inoltre ai re e ai prìncipi spettano azioni generali e la cura universale dei sudditi; ma, poiché l’uomo da solo non basta alle proprie azioni, accade necessariamente che essi manchino in molte cose; perché tali azioni, che sono governare il popolo, giudicare, provvedere a ciascuno dei propri sudditi secondo i loro meriti, trascendono le capacità della natura: perciò si dice che il governo delle anime è l’arte delle arti. Ed è davvero difficile che colui che non sa governare se stesso diventi giudice della vita altrui. Perciò il profeta Samuele ordinò a Saul, appena proclamato ed unto re, di aggregarsi alla schiera dei profeti affinchè da lì, profetando con essi mediante l’elevazione della mente, per divina ispirazione fosse istruito sulle cose da fare riguardo al governo del popolo. Cosa che avvenne, come risulta dal Libro dei Re (1,10).
• Perciò è impossibile che i re e i prìncipi non errino, se non si rivolgono a Colui che tutto governa e che di tutto è il Creatore. Infatti nell’Ecclesiastico sta scritto che i re del popolo di Israele, tranne David, Ezechia e Giosia che furono uomini spirituali e illuminati da Dio, furono tutti peccatori davanti a Dio. Ebbene, a queste carenze si rimedia col merito dell’elemosina donde i poveri ricevono sostentamento; come per bocca del profeta Daniele fu detto a un principe pagano, al re di Babilonia Nabucodonosor, che era supremo monarca di tutto l’Oriente: «Riscattati con elemosine dai tuoi peccati, e dalle tue iniquità con beneficenze ai poveri» (Daniele, IV, 24).
• Dunque le elemosine che i prìncipi fanno agli indigenti sono quasi una fideiussione a loro favore presso Dio per il pagamento dei debiti dei peccati, come dice Aristotele della moneta in rapporto alle cose venali. E come la moneta è la misura negli scambi per la vita corporale, così è l’elemosina per la vita spirituale; perciò nell’Ecclesiastico (XVII,18) sta scritto: «L’elemosina dell’uomo è per lui come una borsa ed egli [Dio] tiene conto del favore prestato come della pupilla».
• Da queste cose dunque è chiarito a sufficienza come sia opportuno che il re, e qualsiasi altro signore, nel proprio dominio provveda ai poveri con l’erario comune dello Stato, o del Regno. Da questo deriva il fatto che in ogni provincia, città o castello, dai re, dai prìncipi o dai cittadini furono istituiti degli ospizi per risollevare l’indigenza dei poveri: e non solo presso i cristiani, ma anche presso gli infedeli. Questi istituivano case di ospitalità per aiutare i poveri, e le chiamavano case di Giove, - come risulta dal secondo libro dei Maccabei (Cap. 6, 2)...
• La storia ci racconta anche che Aristotele mandò una lettera ad Alessandro perché si ricordasse della miseria dei poveri, per accrescere la prosperità del suo impero.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo XV, Previdenze a favore dei poveri che il re, o qualunque altro signore, è tenuto a fornire con l’erario pubblico.
• Terminati questi argomenti bisogna trattare della moneta, nel cui uso è regolata la vita dell’uomo, e così, per conseguenza, ogni tipo di governo, e specialmente il regno, per i vari proventi che ricava dalla moneta. Perciò anche il Signore, interrogando i Farisei che cercavano di ingannarlo, disse: «Di chi è quest’immagine e questa iscrizione?». E, avendogli quelli risposto: «Di Cesare», ritorse su di loro la risposta al quesito, dicendo: «Rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare, e a Dio ciò che è di Dio», come se la moneta stessa fosse la causa del pagamento del tributo, come del resto avviene il più delle volte, Quanto poi alla materia della moneta e alla necessità per un re di averne in abbondanza, ne abbiamo già trattato sufficientemente prima. Ma ora ne trattiamo in quanto è una misura per mezzo della quale la sovrabbondanza e la scarsità sono riportate al «mezzo», come dice Aristotele nel quinto libro dell’Etica. La moneta infatti fu trovata per risolvere le liti nel commercio e perché ci fosse una misura negli scambi. E, quantunque vi siano molti tipi di scambio, come sappiamo da Aristotele nel 1° libro della Politica, fra tutti il più pratico è quello per cui si dice che sia stata trovata la moneta.
• Perciò anche l’organizzazione politica di Licurgo - che diede per la prima volta ai Parti e ai Lidi delle leggi in cui era proibita la moneta ed era permesso soltanto il reciproco scambio delle merci - è disapprovata da Aristotele, come appare chiaramente dalle cose già dette. Perciò è proprio lui che nel medesimo libro dell’Etica conclude che la moneta fu istituita per la necessità dello scambio, perché tramite essa il commercio è reso più rapido e nello scambio è tolta materia di litigio. Ed essa l’abbiamo fin dal nostro padre Abramo che visse molto tempo prima di Licurgo e di tutti i filosofi. Perciò di lui è scritto nel Genesi che comperò un campo per la sepoltura dei suoi al prezzo di 400 sicli di moneta corrente e approvata. Ma, quantunque la moneta propria sia necessaria in ogni tipo di regime, lo è specialmente in quello monarchico; e le cause di questa necessità sono di due specie.
• La prima di tali cause si desume dal re, l’altra invece si desume dal popolo che gli è soggetto. Stando alla prima, la moneta propria, ossia quella da lui coniata, è un decoro per il re e il regno (e per ogni altro regime politico), poiché su di essa è rappresentata l’immagine del re, come si è detto sopra di Cesare; perciò in nessuna cosa ci può essere tanta celebrità della sua memoria, per il fatto che niente passa con tanta frequenza per le mani degli uomini che riguardi il re o qualunque signore, quanto la moneta.
• Inoltre la moneta, in quanto è regola e misura delle cose venali, mostra l’eccellenza del re, perché la sua immagine sulla moneta è la regola degli uomini nei loro commerci. Ed è per questo che è chiamata moneta, per il fatto che ammonisce la mente; perché - essendo essa la misura giusta - non ci sia frode fra gli uomini; cosicché - come afferma Sant’Agostino trattando questo argomento -, l’immagine di Cesare sia per l’uomo come l’immagine di Dio. Viene chiamata anche nomisma perché è contrassegnata dai nomi e dall’effigie dei prìncipi, come spiega Sant’Isidoro. Da tutto ciò appare chiaramente che la maestà dei dominanti rifulge per mezzo della moneta: ed è per questo che le città, i prìncipi, o i prelati, chiedono agli imperatori, per la propria gloria, di avere una loro moneta particolare.
• Ancora: la moneta propria è vantaggiosa per chi comanda, perché - come si è detto prima - con essa si calcolano i tributi e ogni altro tipo di tassazione che si debba fare nel popolo, come era già ordinato dalla legge divina riguardo alle oblazioni e a qualunque riscatto in luogo del sacrificio.
• Di più: la sua coniazione per autorità del principe porta a lui vantaggio; perché, come impone il diritto delle genti, nessun altro può coniare sotto quella medesima figura e iscrizione.
• In questa coniazione, però, quantunque gli sia lecito esigere ciò che gli spetta nel battere moneta, ogni principe, o re deve essere giusto, sia nel cambiare, sia nel diminuire il metallo, perché ciò può recare danno al popolo, per il fatto che la moneta è misura delle cose venali, come abbiamo già detto: perciò cambiare la moneta è come cambiare la bilancia, o un qualsiasi peso.
• Quanto poi questo dispiaccia a Dio sta scritto nei Proverbi (XX,10): «Peso e peso, misura e misura, sono entrambi abominevoli presso Dio». E a questo proposito il re degli Aragonesi venne fortemente ripreso dal papa Innocenzo, perché aveva cambiato la moneta, svilendola a danno del popolo. E perciò sciolse il figlio dal giuramento con cui si era obbligato a mantenere la moneta del padre, e gli comandò di ripristinare l’antica moneta.
• Inoltre le leggi concernenti le monete favoriscono i mutui e ogni altro genere di contratti. Infatti esse comandano che i mutui siano pagati e che i contratti siano osservati per ogni misura di quantità e di qualità secondo la moneta del tempo. Si deve dunque concludere che per ciascun re è necessaria una moneta propria.
• Ma anche in rapporto al popolo è necessario che il re abbia moneta propria, come risulta già da quanto è stato detto. In primo luogo perché è la misura più spedita negli scambi. Secondo, perché è più sicura tra i popolani. Infatti sono molti quelli che non conoscono altre monete e, poiché sono ingenui, facilmente potrebbero essere frodati; il che è contro il buon ordine del governo regale. A ciò provvidero gli imperatori romani. Infatti la storia ci dice che al tempo di nostro Signore Gesù Cristo, in segno della soggezione ai Romani c’era una sola moneta in tutto il mondo, sulla quale era rappresentata l’immagine di Cesare, subito riconosciuta dai Farisei interrogati dal Signore Gesù Cristo per svelare la loro malizia. E questa moneta valeva dieci denari usuali, e ognuno doveva pagarla ai gabellieri dei suddetti prìncipi, oppure a coloro che ne facevano le veci nelle province, nelle città, o nei castelli.
• Ancora: una moneta propria è più vantaggiosa. Infatti, quando negli scambi vengono usate monete straniere, è necessario ricorrere all’arte del cambio, poiché tali monete nelle regioni straniere non conservano il valore che hanno nelle proprie; e questo non può accadere senza recare qualche danno. Ciò si riscontra specialmente nelle regioni dei tedeschi ed in quelle circostanti; che perciò sono costretti, quando viaggiano, a portare con sé una grande quantità d’oro e d’argento, e ne vendono la quantità che occorre per l’acquisto delle cose venali.
• Perciò Aristotele nel IV libro della Politica (leggi: Politica, 1. I, e III) distinguendo i vari tipi di ricchezza, ossia l’arte monetaria, la numismatica, lo scambio per usura e l’arte del coniare, soltanto la prima dice naturale, perché ordinata allo scambio delle cose naturali; e questo può farlo la moneta propria e nessun altro, come risulta da quanto è stato già detto. Perciò raccomanda soltanto questa, disprezzando le altre, delle quali si parlerà ancora in seguito.
• Dunque è necessario concludere che in ogni tipo di governo, e specialmente in quello monarchico, per la conservazione del potere è necessario disporre di moneta propria, sia a vantaggio del popolo, sia a vantaggio del re, e a vantaggio di qualunque altro tipo di governo.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo XIII, Come in qualsiasi regno e in qualunque dominio sia necessaria moneta propria; e quanti vantaggi derivino da ciò, e quali danni, se non la si abbia.
• Oltre le cose suddette sono necessarie al rafforzamento del dominio, sia esso regale o politico, le opere difensive, di cui debbono occuparsi i ministri del re, o il re stesso. Un ammaestramento in proposito lo riceviamo dal re Davide il quale, dopo aver preso Gerusalemme, occupò il monte Sion per sua difesa, e qui fabbricò una rocca donde erano condotte gallerie fino al Mello (Mello fu chiamata una valle che divideva Gerusalemme dalla rocca di Sion, ndR); e chiamò sua città la stessa rocca. L’avere nelle singole città e nei singoli castelli una difesa speciale o una rocca dove stia la famiglia reale e gli ufficiali è una regola che i re osservano in ogni luogo. Le ragioni di questa prassi sono molte. • La prima ragione si può desumere dalle funzioni dei prìncipi, perché ad essi è necessario stare in un luogo sicuro, affinché nel reggere, correggere e governare siano più sicuri, e siano coraggiosi nell’amministrare la giustizia. Perciò anche i consoli e i senatori romani scelsero il luogo più sicuro, cioè il Campidoglio; e le storie narrano che, essendo stata tutta la città occupata dai nemici, essi là rimasero illesi. • Ancora di più esige questo una maggiore onorabilità del re e della sua famiglia, per evitare che il contatto frequente coi sudditi abbassi la loro maestà di fronte al popolo ovvero che per uno sguardo incauto là dove si richiede la più grande pudicizia (come si comportavano i vecchi troiani nei confronti di Elena, a quanto afferma il Filosofo nell’Etica) il popolo non incorra nell’indignazione del re. E anche per evitare che il re stesso e i suoi non abbiano occasione di comportarsi disonestamente verso i sudditi; ripetendo la caduta di Davide con la moglie di Uria, scudiere di Gioab, che fu vista da lui mentre si lavava, come è scritto nel secondo libro dei Re. • La seconda ragione si può desumere partendo dal popolo, il quale è più mosso dalle cose sensibili che guidato dalla ragione. Quando la gente vede le magnifiche sontuosità dei re nelle opere di difesa è indotta più facilmente per l’ammirazione all’obbedienza e ad eseguire i comandi del re, come dice il Filosofo nel sesto libro della Politica. Inoltre i sudditi hanno meno ragioni di ribellarsi e di sottomettersi ai nemici, quando ne sono troppo molestati. Infatti quando hanno i ministri e i re presenti alle difese, essi sono stimolati a difendersi con più audacia. Cosi fece Giuda Maccabeo della rocca di Sion che, dopo averla conquistata, fu da lui cinta di mura fortissime e di alte torri per la difesa della patria contro i nemici, come è scritto nel primo libro dei Maccabei. E ugualmente edificò difese fortissime verso Bethsura di fronte all’Idumea. • Inoltre le opere difensive sono necessarie ai prìncipi per conservare le ricchezze, delle quali devono avere abbondanza, come è stato detto sopra, e affinchè possano usarne più liberamente con la loro famiglia, onde anche i ministri diventino più pronti a preparare le cose necessarie; e questo è molto bello e onorevole anche in una casa privata. Infatti è proprio degli atti umani causare grazia e bellezza quando sono posti nell’ordine dovuto, come succede in una cosa proporzionata e simmetrica nelle sue parti: perciò ne deriva per noi la letizia spirituale, la quale da sé produce quasi un’estasi, simile a quella che sembra abbia goduto la regina di Saba alla vista dell’ordine dei servitori della corte di Salomone, come abbiamo mostrato sopra. Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo XI, La necessità che ha il re, come qualsiasi altro signore, di avere difese fortissime nella sua giurisdizione.
• A questo punto bisogna avvertire che si chiama principato dispotico quello basato sul rapporto padrone-servo, da despota che è termine greco. Perciò alcuni signori di quelle regioni sono ancora oggi chiamati despoti: questo tipo di principato lo possiamo ricondurre a quello regale, come emerge dalla sacra Scrittura. • Ma allora sorge una questione, perché il Filosofo nel primo libro della Politica oppone il regime regale al dispotico. Questo però sarà chiarito nel prossimo libro dove si definirà la materia: per ora basti provare ciò che diciamo per mezzo della divina Scrittura. Infatti attraverso il profeta Samuele vennero date al popolo d’Israele leggi per il futuro regno, che implicano servitù. Avendo essi chiesto un re a Samuele, ormai cadente per l’età, anche per il fatto che i suoi figli non dominavano con giustizia secondo il regime politico, come altri giudici di questo popolo avevano fatto, consultato, il Signore rispose:: «Ascolta la voce del popolo in ciò che ti domanda. Opponiti ad essi e predici loro il diritto del re. Prenderà i vostri figli e li porterà sui suoi carri, e li farà aurighi e cavalieri per sé, e araldi per le sue quadrighe; e li porrà come aratori nei suoi campi, e come mietitori delle sue biade, e come fabbri delle sue armi; farà delle vostre figlie delle fochiste, delle produttrici di unguenti e di pane», ed elenca altre condizioni tipiche della servitù, ricordate nel primo libro dei Re; come per dimostrare che il regime politico, ossia quello dei giudici, come era stato anche il suo, era più fruttuoso per il popolo. Noi invece nel capitolo precedente abbiamo dimostrato il contrario. • Per chiarire questo dubbio bisogna sapere che il regime politico è migliore di quello regale da due punti di vista. Prima di tutto se li confrontiamo con lo stato integro della natura umana che si chiama stato di innocenza; in esso non ci sarebbe stato un regime regale, bensì un regime politico, perché allora non sarebbe esistito un potere implicante servitù, ma solo preminenza e sottomissione nell’ordinare e nel governare la moltitudine secondo i meriti di ciascuno; cosicché nel guidare e nell’ubbidire ciascuno sarebbe stato disposto secondo la convenienza della sua natura. Perciò presso uomini sapienti e virtuosi, come furono gli antichi Romani, avvicinandosi essi per imitazione a tale condizione di innocenza, il regime politico può essere migliore. • Ma poiché «i cattivi difficilmente si correggono e il numero degli stolti è infinito», come dice l’Ecclesiaste (1, 15), ora che la natura è corrotta, il regime regale è più fruttuoso, perché bisogna frenare la natura umana, disposta in modo da tendere quasi alla sua dissoluzione. • È quanto è chiamato a compiere la maestà del re. Perciò nei Proverbi (XX, 8) sta scritto: «II re che siede sul trono del giudizio dissipa ogni male col suo sguardo». Dunque la verga della disciplina, che tutti temono, e il rigore della giustizia sono necessari nel governo del mondo, poiché con questi mezzi si governa meglio il popolo e la massa ignorante. Ecco perché l’Apostolo (Rom. XIII, 4) parlando dei reggitori del mondo dice, che «non senza ragione porta la spada... vindice nell’ira contro chi fa il male». E Aristotele nell’Etica insegna che «le pene che sanzionano le leggi sono in un certo qual modo delle medicine». Dunque sotto questo aspetto il dominio regale è superiore. • Inoltre anche la posizione della terra, in rapporto all’influenza delle stelle, differenzia le varie regioni, come è stato detto sopra: perciò vediamo che talune province sono più adatte alla servitù, altre alla libertà. Perciò Giulio, Celso ed Ammonio, che descrivono le gesta dei Franchi e dei Germani, attribuiscono loro costumi e comportamenti che ancor oggi permangono. Anche i cittadini romani, poi, per un certo periodo vissero sotto i re, cioè da Romolo fino a Tarquinio il superbo; e questo periodo durò 264 anni, come dicono le storie. Ugualmente anche gli Ateniesi, dopo la morte del re Codro vissero sotto il governo di magistrati, perché erano posti nella medesima zona climatica. Infatti, considerando che questa regione, per le cause che abbiamo già esposto, sarebbe stata più adatta al regime politico, la ressero fino ai tempi di Giulio Cesare consoli, dittatori e tribuni: periodo che durò 444 anni. E in questo tempo, come è stato detto prima, lo Stato ricavò molti vantaggi da questo tipo di regime. Dunque è evidente in che senso noi da un lato anteponiamo la politica al regno, e dall’altro preferiamo il dominio regale alla politia. [Il termine aristotelico politia corrisponde a quello di democrazia, ma in senso assai diverso da quello correntemente attribuitegli]. Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo IX, Il principato dispotico: in che senso si identifica con quello regale.
• Non solo però è necessario che il re sia ben fornito di ricchezze, ma anche di ministri. Perciò anche il grande re Salomone nel libro prima citato dice di se stesso (11, 7); «Ho posseduto schiavi ed ancelle e una grandissima famiglia».
• È chiaro poi che quanto si possiede rientra nel dominio del possessore; ecco perché incidentalmente dobbiamo qui distinguere vari tipi di dominio. Infatti Aristotele nella sua Politica pone due tipi di principato (ciascuno dei quali ha i suoi ministri, per quanto nel V libro della Politica ne enumeri di più; come sopra abbiamo visto e come in seguito si chiarirà meglio), cioè il principato politico e quello dispotico. Si ha il principato politico quando una regione, una provincia, una città, oppure un castello, sono governati da una o da più persone secondo i propri statuti, come avviene nelle regioni d’Italia e soprattutto a Roma, dove per lo più fin dalla fondazione della città si è governato attraverso senatori e consoli. Il dominio di costoro deve avere una certa affabilità, per il fatto che c’è una continua alternanza di cittadini, ossia di estranei: come riguardo ai Romani è scritto nel libro dei Maccabei (1, 8) là dove si dice che anno per anno affidano a un uomo il compito di comandare su tutta la loro terra. Perciò in un dominio di questo tipo c’è una duplice ragione per cui i sudditi non possono essere rigidamente disciplinati, come invece accade nel dominio di un re.
• La prima ragione si desume dalla parte di chi comanda, poiché il suo governo è temporaneo. Infatti la sua sollecitudine verso i sudditi è diminuita dalla considerazione che il proprio dominio finirà in un tempo tanto breve. Ecco perché i giudici di Israele, che esercitavano il loro giudicato politicamente, nel giudicare furono più moderati dei re che vennero dopo. Perciò Samuele che fu giudice di quel popolo per un certo periodo, volendo dimostrare che il suo governo era stato politico, e non regale, come essi avevano poi scelto, così parla ad essi: «Parlate di me davanti a Dio e al suo Consacrato, se io ho mai preso il bue di qualcuno, o l’asino; se ho calunniato qualcuno; se ho oppresso mai qualcuno; se ho preso mai un dono dalle mani di qualcuno». E questo certamente non lo fanno coloro che hanno il dominio regale, come in seguito sarà chiarito e come il detto profeta preannunciava nel primo libro dei Re.
• Di più: il sistema di governo negli stati dove il dominio è politico, è mercenario; infatti ai capi viene assegnato un compenso. Ma dove ci si prefigge come fine un compenso non si pensa esclusivamente al governo dei sudditi, e così di conseguenza si tempera il rigore della correzione. II Signore infatti dice di costoro (Giovanni, X,12): «Il mercenario è colui che non è pastore» - chi non ha cura delle pecore, perché vi è preposto solo temporaneamente - «vede venire il lupo e fugge». Il mercenario fugge perché è mercenario, perché se per lui il fine del governo è la mercede, pospone i sudditi a se stesso. Per questa ragione gli antichi magistrati romani, come scrive Valerio Massimo, tenevano le cariche dello stato a spese proprie, come M. Curio, Fabrizio e molti altri: questo li rendeva più audaci e solleciti nella cura dello Stato, con più impegno e maggiore rendimento. In essi si verificava l’affermazione di Catone, che Sallustio riferisce nel Catilinario: «La Repubblica, da piccola che era è diventata grande, perché in essi vi fu operosità in patria, un giusto comando fuori, l’animo libero nel deliberare, e non ottenebrato né da colpa, né da capriccio».
• La seconda ragione per cui il dominio politico deve essere moderato ed esercitato con moderazione si desume da parte dei sudditi, essendo la loro disposizione naturale adatta a quel dato regime. Infatti Tolomeo nel Quadripartito prova che le regioni degli uomini sono distinte secondo le varie costellazioni per quanto riguarda il loro regime, essendo - sempre secondo Tolomeo - circoscritto il comando della volontà sul potere delle stelle. Perciò le regioni dei Romani sono da lui poste sotto Marte e quindi sono meno soggiogabili. Per la stessa ragione questo popolo sarebbe da ritenersi non avvezzo a contenersi entro i propri confini e refrattario alla sottomissione, se non quando non possa resistere; e poiché è intollerante dell’arbitrio altrui, di conseguenza è anche diffidente verso chi sta più in alto. Dei magistrati romani nessuno, come è scritto nel libro di Maccabei (1,8), portava il diadema o indossava la porpora: e si accenna pure a un effetto di questa riservatezza, ossia al fatto che tra di essi non c’è né malevolenza né invidia. Dunque essi governavano la repubblica con una certa mitezza d’animo, come la natura dei sudditi di quella regione richiede, e con un atteggiamento umile; poiché, come dice Cicerone nelle Filippiche, «nessuna difesa armata è superiore all’amore e alla benevolenza dei cittadini; è di questa che un governante deve essere munito, non di armi». Come riferisce Sallustio, Catone afferma la stessa cosa degli antichi padri romani.
• Inoltre porta allo stesso risultato, ossia alla spregiudicatezza dei sudditi, sia la speranza di poter togliere il potere ai governanti, sia quello di poter comandare a loro volta a tempo opportuno, rendendo audaci nel rivendicare la libertà, e a non piegarsi ai governanti. Perciò il governo politico deve essere mite.
• Di più: interviene un modo di governare già fissato, perché è basato su leggi comunali o municipali, dalle quali chi governa non può prescindere. Per tale motivo la prudenza di chi comanda, dal momento che non è libera, viene meno, imitando sempre meno quella divina.
• E, quantunque le leggi traggano origine dal diritto naturale, come Cicerone dimostra nel De legibus, e il diritto naturale derivi dal diritto divino, come attesta il profeta Davide: «Il lume del tuo volto è impresso su di noi. Signore», tali leggi sono tuttavia inadeguate per i casi particolari, a cui il legislatore non ha potuto provvedere, non conoscendo i sudditi futuri. Da questo deriva al dominio politico una certa carenza, dal momento che il reggitore politico giudica il popolo soltanto in base alle leggi, cosa cui invece il dominio regale supplisce; poiché, non essendo questo impedito dalle leggi, decreta per mezzo della legge che sta nel cuore del principe. Ecco perché il dominio regale imita maggiormente la provvidenza divina, che ha cura di tutti, come è scritto nel libro della Sapienza. • Abbiamo dunque chiarito come sia il principato politico e il suo modo di governare. Ora dobbiamo esaminare il principato dispotico.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo VIII, I ministri del regno. Distinzione tra dominio politico e dominio dispotico. Mitezza e limiti del dominio politico.
• Ma anche le ricchezze artificiali (oltre a quelle temporali che si chiamano naturali, cfr. Lib. II, Cap. V e VI, ndR), come l’oro, l’argento, altri metalli, e monete coniate con essi, sono necessarie al re per il sostegno del suo governo. Infatti, supposto che per fondare un governo o uno stato sia necessaria per natura una collettività e quindi un re o un’autorità qualsiasi che governi la moltitudine, bisogna arrivare ad un’altra conclusione riguardo a una cosa connessa, cioè al tesoro, ossia all’oro, all’argento e al denaro con essi coniato, senza il quale il re non può esercitare opportunamente e adeguatamente il suo dominio; e questo si può dimostrare per vie molteplici.
• La prima via è evidentemente in rapporto al re come tale. Infatti l’uomo usa l’oro, l’argento o la moneta come strumento per le compravendite. Perciò il Filosofo nel quinto libro dell’Esodo dice che «la moneta è quasi il fideiussore delle future necessità perché contiene tutte le opere, come prezzo di esse». Se dunque di esso ha bisogno chiunque, molto di più ne ha bisogno il re: perché, se al semplice corrisponde il semplice, al maggiore corrisponde il maggiore.
• Secondo, la virtù è proporzionata alla natura, e l’opera lo è alla virtù. Ora, la natura del potere regale, ha una certa universalità, in quanto interessa tutto il popolo soggetto: dunque ne sono universali anche la virtù e l’opera. Se dunque il potere di chi esercita il dominio per sua natura è di indole commutativa, lo sarà anche la virtù e l’operazione. Ma la commutazione non può avvenire senza la moneta, come il fabbro e il carpentiere non possono operare senza i loro strumenti.
• Terzo, sempre sulla stessa linea: secondo il Filosofo (Etica, IV), «la virtù della magnificenza ha per oggetto le grandi spese». Ma le grandi spese si addicono al magnanimo, quale dev’essere il re, come lo stesso Filosofo accenna nel medesimo luogo. Ecco perché nel libro di Ester (I) sta scritto che Assuero, il quale in Oriente dominava su centoventisette province, in un banchetto che offrì ai prìncipi del suo regno faceva servire cibi e bevande come richiedeva la magnificenza di un re. Ma questo non si può fare senza quello strumento della vita che è il denaro, ovvero l’oro o l’argento. Perciò arriviamo alla medesima conclusione di prima: ossia che il re come tale ha bisogno di un tesoro, composto di ricchezze artificiali.
• La seconda via si desume in rapporto al popolo, sia in generale, sia in particolare. Un re deve avere abbondanza dì denaro per provvedere alle necessità della sua casa e dei propri sudditi; perché, come dice il Filosofo nel libro ottavo dell’Etica: «Il re deve comportarsi verso il popolo come il pastore verso le pecore e come il padre verso i figli». Così si comportò il Faraone verso tutto l’Egitto, come è scritto nel Genesi.
• Comprò infatti con l’erario pubblico il frumento che poi fece distribuire, secondo la prudenza di Giuseppe, quando venne la carestia, perché il popolo non morisse di fame. Anche Sallustio riferisce nel Catilinario il pensiero di Catone su come la repubblica aveva giovato ai Romani: con la prosperità dell’erario pubblico che Roma aveva assicurato; e quando questo venne a mancare essa fu ridotta a nulla, come accadde proprio ai tempi di Catone.
• Inoltre qualsiasi regno, città, castello, o comunità è simile al corpo umano, come lo stesso Filosofo insegna, e come si legge nel Policrato. Per questo nello stesso passo l’erario comune del re viene paragonato allo stomaco, di modo che, come nello stomaco i cibi si raccolgono e vanno ad alimentare le membra, così pure anche l’erario del re deve riempirsi di un tesoro di denaro, che viene trasmesso e diffuso secondo le necessità dei sudditi e del regno.
• Lo stesso si dica considerando le cose in particolare. Infatti è cosa turpe, e deroga molto alla riverenza regale dover mutuare dai propri sudditi per le spese del re o del regno. Per di più a causa di questa dipendenza dai mutui i signori sono costretti a permettere che si facciano nel regno delle indebite esazioni da parte dei sudditi, o di chiunque altro; e da questo viene uno snervamento debilitando così le condizioni del regno.
• Si noti inoltre che spesso nei mutui il mutuante patisce scandalo, perché chi prende a prestito riesce difficilmente a restituire il mutuo. Di qui il detto attribuito a Biante, uno dei sette sapienti: «Quando un amico mutua da te denaro, perdi l’amico e il denaro». È dunque necessario che il re accumuli ricchezze artificiali, in rapporto al popolo, sia in generale, sia in particolare, per le ragioni suddette.
• La terza via da seguire in questa dimostrazione procede partendo dalle cose o persone che sono fuori del dominio del re; Queste sono di due generi. In primo luogo ci sono i nemici, contro i quali occorre che l’erario pubblico del re sia sempre pieno. Primo, per le spese della propria famiglia; secondo, per gli stipendi dei comandanti e dei soldati, quando muove l’esercito contro i nemici; terzo, per il restauro e la costruzione delle difese, affinché i nemici non passino i confini del suo regno. In secondo luogo ci sono le cose destinate allo sviluppo del regno; e anche per questo al re è necessario un tesoro. Infatti talvolta accade che le regioni limitrofe siano gravate dalla miseria o dal peso dei debiti, o anche dai nemici; e allora esse ricorrono all’aiuto del regno e questo aiutandole con lo strumento di vita che è l’oro, o l’argento, o qualsiasi moneta, ne ottiene la sottomissione; e così il regno si accresce.
• Da quanto abbiamo detto si deduce dunque che il re ha bisogno di ricchezze artificiali per la conservazione del suo governo, in forza dei tre motivi che abbiamo visto. Per questo anche in Giuditta sta scritto che Oloferne, principe di Nabucodonosor, quando invase le regioni della Siria e della Cilicia con un grande esercito, portò molto oro ed argento dalla casa del re, evidentemente preparato per la spedizione contro i suoi nemici.
• La stessa cosa è scritta di Salomone nel libro prima citato (Eccle. II, 8): «Radunai oro ed argento, e sostanza di re e di province», chiamando qui sostanza i tesori di monete esatti come tributi da lui stesso e da suo padre Davide, come risulta dal secondo e dal terzo libro dei Re. E questo perché, secondo il Filosofo (Etica) i tesori sono strumento della vita umana, come si è detto sopra.
• E questo non contraddice il comando dato da Dio nel Deuteronomio attraverso Mosè riguardo ai re e ai prìncipi del popolo; poiché in esso si comanda al re, di non ammassare immense riserve di oro e d’argento. La proibizione infatti si riferisce all’ostentazione, e al fasto regale, come racconta la storia di Creso, re dei Lidi: il quale per questa ragione andò incontro alla rovina, perché, catturato da Ciro re dei Persiani, fu affisso nudo al patibolo sopra un alto monte. Ma, per le ragioni che abbiamo detto, il denaro è assolutamente necessario per sostentare il regno.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo VII, È necessario che il re abbia abbondanza di ricchezze artificiali, come oro, argento e denaro coniato con essi.
• Scelta la regione, bisogna scegliere un luogo adatto alla fondazione della città; e in esso è evidente che si deve ricercare innanzitutto la salubrità dell’aria. Infatti il presupposto della convivenza civile è la vita naturale, che viene conservata illesa dalla salubrità dell’aria.
• Il luogo più salubre, come dice Vegezio, sarà elevato, non nebbioso, non esposto alla brina, volto verso regioni del cielo né calde né fredde, e infine lontano da paludi. Di solito l’elevatezza del luogo concorre alla salubrità dell’aria, perché il luogo elevato è esposto al soffio dei venti, dai quali è restituita l’aria pura; anche i vapori, che per opera dei raggi solari si alzano dalla terra e dalle acque, si accumulano più nelle convalli e nei luoghi bassi che sulle alture. Perciò nei luoghi alti si trova un’aria più fine. Questa finezza dell’aria, poi, che è preziosissima per una libera e sana respirazione, è impedita dalle nebbie e dalle brine, che di solito abbondano nei luoghi molto umidi: perciò si constata che questi luoghi sono incompatibili con la salubrità. E, poiché nei luoghi paludosi c’è troppa abbondanza di umidità, è necessario che il luogo scelto per costruirvi la città sia lontano dalle paludi. Infatti, quando le brezze mattutine al sorgere del sole si raccolgono in questo luogo e ad esse si aggiungono le nebbie sorte dalle paludi, spargono le esalazioni delle velenose bestie palustri miste alle nebbie, e rendono pestilenziale il luogo.
• Tuttavia se le mura sono costruite in paludi che si trovano presso il mare e volte a settentrione, o quasi, purché le paludi siano più alte del livello del mare, risultano costruite razionalmente. Infatti, scavati attorno i fossati, l’acqua si scaricherà sul litorale e il mare, gonfiato dalla burrasca, riversandosi sulle paludi non permetterà che nascano animali palustri. E se qualche animale vi giungesse dai luoghi elevati, vi muore per la salsedine cui non è abituato.
• Occorre inoltre che il luogo destinato alla città sia temperatamente disposto al freddo e al caldo secondo la prospicienza di zone diverse del cielo. Infatti se le mura, specie se costruite vicino al mare, guarderanno a mezzogiorno non saranno salubri. Poiché questi luoghi di mattina sono freddi, non essendo guardati dal sole; a mezzogiorno invece saranno infuocati, perché troppo esposti al sole. Le mura poi che guardano a occidente appena sorto il sole diventano tiepide, o restano fredde, a mezzogiorno si scaldano; a sera poi, siccome hanno il sole di fronte e hanno calore di continuo, ardono. Se invece guarderanno a oriente, la mattina, per la diretta contrapposizione del sole, saranno temperatamente calde: e il calore non aumenterà molto nel pomeriggio, perché il sole non colpisce direttamente il luogo; a sera poi, essendo i raggi del sole completamente dalla parte opposta, questi luoghi diventano freddi. Uguale, o simile, sarà il clima se il luogo della città guardi ad aquilone; è il contrario di quanto abbiamo detto per il luogo rivolto a mezzogiorno. Ora, l’esperienza insegna che per un uomo è poco salutare passare a un caldo più intenso. Infatti i corpi trasportati da luoghi freddi in luoghi caldi non possono durare, ma si dissolvono, perché il calore, asciugando il vapore, dissolve le virtù naturali; cosicché anche nei luoghi salubri d’estate i corpi contraggono malattie.
• Siccome poi per la salute del corpo si richiede l’uso di cibi adatti, il problema del vitto riporta alla considerazione circa la salubrità del luogo da scegliere per la fondazione di una città, poiché tale salubrità è possibile conoscerla dalla qualità dei prodotti della terra; e questo gli antichi lo indagavano partendo dagli animali nutriti sul luogo. Infatti, poiché è comune agli uomini e agli altri animali nutrirsi con i prodotti della terra, ne consegue che, se le viscere degli animali uccisi sono in buono stato, gli uomini pure in quello stesso luogo possono nutrirsi di cibi salutari. Se invece le membra degli animali uccisi appaiono malate, è ragionevole dedurre che neppure per gli uomini dimorare in quei luoghi deve essere salubre.
• E come si cerca l’aria temperata bisogna poi cercare l’acqua salubre. Infatti la salute dei corpi dipende soprattutto da queste due cose che sono le più usate dagli uomini. E riguardo all’aria è chiaro che aspirandola quotidianamente, la introduciamo fino agli organi vitali; perciò la sua salubrità contribuisce enormemente alla salute dei corpi. Ugualmente, poiché tra le cose che prendiamo come nutrimento l’acqua è quella più usata, tanto nelle bevande come nei cibi, non c’è nulla, all’infuori della purezza delle acque, che più contribuisca alla sanità di un luogo che la salubrità delle acque. C’è poi un altro indizio dal quale si può valutare la salubrità di un luogo: se i visi degli uomini che vi abitano sono ben coloriti, i corpi robusti e le membra ben disposte, se i fanciulli sono molti e vivaci e se vi si trovano molti vecchi. Al contrario, se i visi degli uomini sono macilenti, i corpi deboli, le membra sfinite o malaticce, se i fanciulli sono pochi e malati, e meno ancora i vecchi, non si può dubitare che quel luogo sia mortifero.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo II, Come i re e i prìncipi, per fondare città o castelli, devono scegliere regioni in cui l’aria sia salubre; in che cosa e da quali indizi si riconosce quest’aria.
• Come la buona e onesta vita che qui gli uomini vivono è ordinata alla vita beata che speriamo nel cielo, così qualsiasi bene particolare che l’uomo si procura - ricchezze, guadagno, salute, eloquenza, o erudizione - è ordinato, come a suo fine, al bene della moltitudine.
• Se dunque, come è stato detto, colui che ha la cura del fine ultimo deve comandare su quelli che hanno la cura di ciò che è ordinato al fine, e dirigerli col proprio comando, è chiaro da quanto abbiamo detto, che il re, come deve essere soggetto al potere e al governo espressi dalla funzione sacerdotale, così deve presiedere a tutte le cariche umane e ordinarle col comando del suo governo. Chiunque poi ha l’incombenza di compiere qualcosa che sia ordinata a un’altra, come a fine, deve badare a che la sua opera sia adatta al fine. Il fabbro, per esempio, fabbrica la spada in modo che sia adatta alla battaglia e il costruttore deve disporre la casa in modo che sia adatta per abitazione.
• Ora, il fine della vita onesta che qui viviamo è la beatitudine celeste; perciò rientra nei compiti del re curare la vita onesta della moltitudine, perché concorre al conseguimento della beatitudine celeste, comandando le cose che portano alla beatitudine celeste e proibendo, per quanto è possibile, quelle che le sono contrarie. Quale sia poi la via della vera beatitudine, e quali siano le cose che la ostacolano, si conosce dalla legge divina, il cui insegnamento rientra nel compito dei sacerdoti, secondo quanto dice Malachia (11, 7): «Le labbra del sacerdote custodiranno la scienza e dalla sua bocca cercheranno la legge». E così nel Deuteronomio (XVII, 18) il Signore comanda: «Dopo che il re si sarà seduto sul trono del suo regno scriverà per sé su un volume - il Deuteronomio - di questa legge, secondo l’esemplare del sacerdote della tribù di Levi, e lo avrà con sé, e lo leggerà tutti i giorni della sua vita, affinché impari a temere il Signore suo Dio e a custodire le sue parole e le sue cerimonie prescritte dalla legge».
• Un re quindi ben istruito nella legge divina deve avere questo impegno precipuo: che la moltitudine a lui soggetta viva onestamente. E questo impegno abbraccia tre compiti: in primo luogo instaurare una vita onesta nel popolo; in secondo luogo conservarla; in terzo luogo farla progredire verso il meglio.
• Ora, per il ben vivere di ogni singolo uomo si richiedono due cose: una principale, che è l’operare secondo virtù (la virtù infatti è quella disposizione per cui si vive bene); l’altra, secondaria e quasi strumentale, è la sufficienza dei beni corporali, l’uso dei quali è necessario agli atti della virtù. Si noti però che l’unità dell’uomo singolo è causata dalla natura, mentre l’unità della moltitudine, che si chiama pace, deve essere procurata dalla solerzia di chi governa. Perciò per costituire il ben vivere della collettività si richiedono tre cose. Primo, che la moltitudine sia costituita nell’unità della pace. Secondo, che la moltitudine unita nella pace sia indirizzata a compiere il bene. Come infatti l’uomo non può fare niente di bene quando non sia presupposta l’unità delle sue parti, così la moltitudine degli uomini cui manchi l’unità della pace mentre combatte contro se stessa è impedita di compiere il bene. Terzo, si richiede che ad opera di chi governa ci sia sufficienza delle cose necessarie a ben vivere. Una volta poi che il re ha instaurato la vita onesta nella moltitudine, ne consegue che egli si adoperi per la sua conservazione.
• Ebbene, tre sono le cose che non lasciano durare il bene pubblico. La prima di esse viene dalla natura. Infatti il bene di un popolo non deve essere instaurato solo per un certo tempo limitato, ma in modo tale che sia in un certo senso perpetuo. Ma gli uomini, dal momento che sono mortali, non possono durare in perpetuo; e nella loro vita non hanno sempre lo stesso vigore; perché la vita umana è soggetta a molte variazioni; cosicché gli uomini non sono adatti a compiere gli stessi incarichi nello stesso modo per tutta la vita. Il secondo impedimento alla conservazione del bene pubblico, proveniente dall’interno, consiste nella perversione delle volontà, le quali o sono pigre nel fare quelle cose che lo Stato richiede, o peggio, sono contrarie alla pace della moltitudine, perché, trasgredendo la giustizia, perturbano la pace altrui. Il terzo ostacolo alla conservazione dello Stato è causato poi dall’esterno, quando un’aggressione dei nemici toglie la pace e talvolta distrugge dalle fondamenta il regno, o la città.
• Or dunque per queste tre cose il re deve provvedervi in tre modi. Primo, deve attendere alla successione degli uomini e alla sostituzione di quelli che presiedono ai diversi incarichi. Imitando così il governo divino il quale, per le cose corruttibili che non possono durare sempre, provvede in modo che si succedano per generazione le une alle altre, così da assicurare almeno l’integrità dell’universo. Parimenti il bene del popolo viene conservato dalla cura del re, in quanto questi provvede con sollecitudine che altri succedano al posto di quelli che vengono meno. Secondo, deve provvedere con le sue leggi e i suoi ordini, con castighi e con premi, ad allontanare i sudditi dall’iniquità e ad incitarli ad opere virtuose prendendo esempio da Dio che ha dato agli uomini una legge, retribuendo quelli che la osservano col premio, e quelli che la trasgrediscono con il castigo. Terzo compito del re è la difesa dei sudditi curandone la sicurezza contro i nemici. Infatti non servirebbe a nulla evitare i pericoli interni, se non ci si potesse difendere contro quelli esterni.
• Così dunque per la formazione di una buona collettività spetta al re una terza incombenza, cioè l’essere sollecito del progresso: il quale risulta quando nelle singole cose predette si corregge quanto c’è di disordinato, si suppliscono le deficienze, e si ha cura di perfezionare quanto può essere migliorato. Cosicché l’Apostolo stesso (ai Corinzi) ammonisce i fedeli affinché aspirino a grazie sempre migliori.
• Queste dunque sono le cose pertinenti alla funzione del re; e di esse è necessario trattare una per una con maggior diligenza.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro I, Capitolo XV, Come si richiede che il re disponga i sudditi a vivere secondo virtù per il conseguimento del fine ultimo, così pure si richiede per i fini intermedi. Quali siano le cose che dispongono al ben vivere e quali indispongono. Rimedi che il re deve opporre a questi ostacoli.
• In primo luogo dunque si deve esporre il compito del re a partire dalla fondazione della città o del regno. Infatti, come dice Vegezio, le nazioni più potenti ed i prìncipi famosi non poterono conseguire una gloria più grande del fondare nuove città o, per mezzo di qualche ampliamento, imporre il proprio nome a quelle fondate da altri. Ciò concorda con le parole della Sacra Scrittura. Dice infatti il Savio (Ecclesiastico, XL, 19) che «la fondazione di una città rende duraturo il nome». Infatti oggi si ignorerebbe il nome di Romolo, se non avesse fondato Roma.
• Nella fondazione di una città o di un regno, poi, occorre che il re, se ne ha modo, scelga la regione, la quale deve essere temperata. Dal clima della regione infatti gli abitanti traggono molti vantaggi. In primo luogo dal clima temperato della regione gli uomini ricevono integrità fisica e longevità. Poiché la salute, consistendo in una certa contemperanza di umori, in un luogo temperato si conserverà; il simile infatti è conservato dal suo simile. Se invece ci sarà un eccesso di calore, o di freddo, necessariamente la qualità del corpo si muterà a seconda della qualità dell’aria: perciò, per un istinto naturale, alcuni animali nella stagione fredda si trasferiscono al caldo, e poi di nuovo nella stagione calda tornano al freddo, per conseguire il temperamento del clima dalla contraria disposizione dei luoghi.
• Ancora: siccome l’animale vive per il caldo e per l’umido, se ci sarà un calore intenso presto l’umido naturale si disseccherà e la vita verrà meno; come presto si spegne la lucerna, se il liquido infuso viene rapidamente consumato da una fiamma eccessiva. Perciò si racconta che in alcune caldissime regioni degli Etiopi gli uomini non riescono a vivere oltre i trent’anni. Al contrario nelle regioni con eccesso di freddo l’umido naturale facilmente si congela, e il calore naturale si estingue.
• Inoltre rispetto alle fortune della guerra, dalle quali prende sicurezza ogni società umana, ha un valore grandissimo il clima temperato della regione. Infatti, come riferisce Vegezio, si dice che tutte le nazioni che sono più vicine al sole, disseccate dal calore eccessivo, hanno sì più senno, ma meno sangue, e per questo non hanno costanza e fiducia nel combattere da vicino: poiché coloro che sanno di avere poco sangue temono le ferite.
• Al contrario i popoli settentrionali, lontani dagli ardori del sole, sono meno assennati, però, dato che hanno molto sangue, sono prontissimi alle guerre. Quelli invece che abitano plaghe più temperate hanno la quantità di sangue sufficiente per disprezzare le ferite e la morte; senza che manchi loro la prudenza, che sotto le armi assicura la moderazione, e serve non poco nei consigli di guerra.
• Infine una regione temperata è molto buona per la vita politica. Come infatti dice Aristotele nella sua Politica: «Le genti che abitano nei luoghi freddi sono piene di coraggio, ma mancano maggiormente d’intelligenza e di ingegno; e per questo si mantengono preferibilmente allo stato libero. Non vivono però civilmente e a causa dell’imprudenza non sono capaci di comandare sui vicini. Le genti poi che si trovano nelle regioni calde sono, secondo la loro costituzione, intellettive e dotate d’ingegno, ma non hanno coraggio; perciò sono assoggettate, e rimangono soggette. Invece quelle che abitano nei luoghi intermedi partecipano di entrambi: perciò si mantengono libere e possono sopra tutte vivere civilmente, e sanno comandare sugli altri». Dunque per la fondazione di una città, o di un regno si deve scegliere una regione temperata.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro II, Capitolo I, Come al re spetta fondare città o castelli e come per questo deve scegliere luoghi temperati; e quali sono i vantaggi che da ciò provengono al regno, e, in caso contrario, quali svantaggi.
• Come è giusto che la fondazione di una città o di un regno prenda ispirazione dalla creazione del mondo, così la regola del governo si deve desumere dal governo divino. Tuttavia bisogna prima considerare che governare significa condurre convenientemente ciò che si governa al debito fine. Una nave infatti allora si dice che è governata quando dall’attività del nocchiero è condotta con una buona rotta sana e salva in porto. Se dunque una cosa è ordinata a un fine fuori di sé, come la nave al porto, compito del governatore sarà non solo quello di conservarla sana e salva, ma anche di condurla al suo fine.
• Se poi ci fosse una cosa che non avesse un fine fuori di sé, il compito del governatore sarebbe soltanto quello di conservarla nella sua perfezione sana e salva. Però nessuna cosa si trova in questa condizione, all’infuori di Dio, che è il fine di tutte le cose. Tuttavia attorno a ciò che è ordinato ad un fine estrinseco molti sono chiamati ad adoperarsi in maniera diversa. Infatti l’uno può avere l’incarico di conservare la cosa nel suo essere; l’altro che pervenga a una perfezione più alta, come avviene chiaramente proprio nella nave, dalla quale si desume la nozione di governo. Infatti il carpentiere si occupa del restauro, se nella nave c’è qualcosa di rovinato, mentre il nocchiero ha il compito di condurre la nave in porto. Lo stesso vale per l’uomo. Infatti il medico si occupa di conservare la vita dell’uomo nella sanità; l’economo ha il compito di assicurargli le cose necessarie alla vita; l’insegnante si preoccupa di fargli conoscere la verità e il moralista di farlo vivere secondo ragione. E, se l’uomo non fosse ordinato ad un bene esterno a lui, gli basterebbero le cure che abbiamo detto ora.
• Ma c’è nell’uomo - finché vive la vita mortale - un bene a lui estraneo, e cioè l’ultima beatitudine, che si attende dopo la morte nella fruizione di Dio. Poiché, come dice l’Apostolo (2 Corinzi, V, 6); «Finché siamo nel corpo peregriniamo lontani da Dio», Perciò l’uomo cristiano, cui quella beatitudine fu acquisita dal sangue di Cristo e che per conseguirla ebbe il pegno dello Spirito Santo, ha bisogno di un’altra cura spirituale con la quale sia diretto al porto della salvezza eterna; e questa cura è offerta ai fedeli di Cristo dai ministri della Chiesa.
• Identico poi deve essere il criterio per stabilire il fine di tutta la comunità e di ogni singolo uomo. Se dunque il fine dell’uomo fosse un qualunque bene posto in lui stesso, analogamente il fine ultimo nel governare la comunità sarebbe l’acquisizione di questo bene da parte della comunità stessa e la custodia di esso. E se questo ultimo fine, di un uomo solo o della società per intero, fosse corporale, cioè la vita e la salute del corpo, il governo dovrebbe essere compito del medico. Se invece il fine ultimo fosse l’abbondanza delle ricchezze, spetterebbe a un economo il potere regale sulla moltitudine. Se poi il bene supremo della società fosse il raggiungimento della verità entro i limiti umani, il re avrebbe il compito del maestro. Sembra invece che il fine della moltitudine associata sia il vivere secondo virtù. Infatti gli uomini si associano per vivere bene insieme, cosa che non si potrebbe raggiungere, se ognuno vivesse separatamente. E la buona vita è quella secondo virtù. Dunque la vita virtuosa è il fine della società umana.
• È indizio di questo il fatto che sono parti della moltitudine associata soltanto quelli che stanno in reciproca comunione di vita nel bene. Se infatti gli uomini si associassero soltanto per vivere, gli animali e gli schiavi sarebbero anch’essi parte del consorzio civile. Se invece si associassero per acquistare ricchezze, tutti quelli che commerciano insieme formerebbero un’unica città. Al contrario vediamo che sono contati come un unico popolo soltanto coloro che sono ordinati al ben vivere sotto le stesse leggi e lo stesso governo.
• Ma poiché l’uomo, vivendo secondo virtù, è ordinato a un fine ulteriore che, come abbiamo detto prima, consiste nella fruizione di Dio, è necessario che la moltitudine umana abbia lo stesso fine dell’uomo singolo. Dunque l’ultimo fine della moltitudine associata non è vivere secondo virtù, ma pervenire alla fruizione di Dio attraverso una vita virtuosa. Ora, se a questo fine si potesse pervenire con la sola forza della natura umana, sarebbe necessariamente compito del re condurre gli uomini a questo fine. Infatti riteniamo che si possa chiamare re colui al quale è affidato ciò che è al primo posto nel governo delle cose umane. Un governo poi è tanto più alto, quanto più è ordinato ad un fine ulteriore. Infatti si trova sempre che colui al quale spetta il fine ultimo comanda su coloro che compiono cose ordinate al fine ultimo. Il nocchiero, p. es., cui spetta disporre la navigazione, comanda a chi fabbrica la nave, disponendo come debba fabbricarla perché sia adatta alla navigazione; e il cittadino che usa le armi comanda al fabbro quali armi debba fabbricare. Ma poiché l’uomo non consegue il fine che è fruizione di Dio con le capacità umane, ma per virtù divina, secondo quel detto dell’Apostolo: «Dalla grazia di Dio è la vita eterna», il condurre a quel fine non sarà compito del governo umano, ma di quello divino. Un governo di questo tipo spetta dunque a quel re che non è soltanto uomo, ma anche Dio, cioè a Nostro Signore Gesù Cristo che, rendendo gli uomini figli di Dio, li ha introdotti nella gloria celeste.
• Tale governo a lui affidato non si corromperà; e a causa di esso Cristo nella Scrittura è chiamato non solo sacerdote, ma anche re, come dice Geremia (XXIII, 5): «Regnerà come re e sarà sapiente». Perciò da lui deriva il sacerdozio regale, al punto che tutti i fedeli di Cristo, in quanto sue membra, sono chiamati re e sacerdoti. Perciò il servizio di questo regno, affinché le cose spirituali fossero distinte da quelle terrene, fu affidato, non ai re terreni, ma ai sacerdoti, e in primo luogo al Sommo Sacerdote, successore di Pietro, Vicario di Cristo, ossia al Pontefice Romano, al quale tutti i re del popolo cristiano devono essere soggetti come allo stesso Signore Gesù Cristo. Cosicché a colui cui spetta la cura del fine ultimo devono essere soggetti coloro ai quali spetta la cura dei fini antecedenti; e devono essere diretti dal suo comando.
• Poiché invece il sacerdozio e tutto il culto dei gentili erano per il conseguimento dei beni naturali - che sono tutti ordinati al bene comune della moltitudine, la cura del quale spetta al re - giustamente i sacerdoti dei gentili erano soggetti ai re. Anzi persino nell’antica Legge al popolo fedele erano promessi beni temporali, non dai demoni, ma dal vero Dio; perciò anche nel vecchio Testamento si legge che i sacerdoti erano soggetti ai re. Ma nella nuova Legge c’è un sacerdozio più alto, dal quale gli uomini sono guidati ai beni celesti: perciò nella legge di Cristo i re devono essere soggetti ai sacerdoti.
• Per questo la divina Provvidenza meravigliosamente fece in modo che nella città di Roma, che Dio aveva previsto come futura principale sede del popolo cristiano, a poco a poco si radicasse la consuetudine che i reggitori della città fossero soggetti ai sacerdoti. Come infatti riferisce Valerio Massimo: «La nostra città pensò sempre che tutte le cose fossero da mettere dopo la religione, anche quelle in cui volle ravvisare il decoro della somma maestà. Perciò le potestà non esitarono a servire alle cose sacre, ritenendo che avrebbero avuto un buon governo delle cose umane, se si fossero costantemente e bene asservite alla divina potenza», e poiché doveva avvenire che anche in Gallia prendesse moltissima forza la religione del sacerdozio cristiano, fu permesso da Dio che anche presso i Galli i sacerdoti gentili, che si chiamavano Druidi, determinassero le leggi per tutta la Gallia, come riferisce Giulio Cesare nel suo De Bello Gallico.
Da San Tommaso d’Aquino, De regimine principum ad regem Cypri, Princìpi non negoziabili sulla società e sulla politica, Libro I, Capitolo XIII.
- San Tommaso: la società è retta attraverso la ragione di un solo uomo, il re
- San Tommaso: anche i beni mondani sono più abbondanti per i re che non per i tiranni
- San Tommaso: la memoria del giusto è in benedizione, mentre il nome degli empi marcirà
- San Tommaso: il premio dei buoni governanti è la beatitudine celeste
- San Tommaso: quale sia il vero fine che deve spingere il re a governare
- San Tommaso: quale sia il fine che deve spingere il re a ben governare
- San Tommaso: come il popolo deve comportarsi per evitare che il monarca diventi tiranno
- San Tommaso: la tirannide si produce più spesso nel regime di più persone
- San Tommaso: come il dominio di uno solo è il migliore, se è giusto
- San Tommaso: è più utile che una moltitudine sia governata da uno solo


![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)