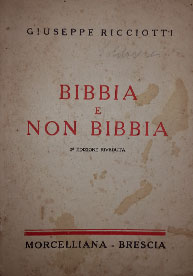Bibbia e non Bibbia, ab. G. Ricciotti, Morcelliana, Brescia, 1935. AIT DOMINUS?, parte 1. Un oratore francese, di gran fama e di vero valore, dimostra in una conferenza del suo quaresimale, dato alle stampe, l’obbligo che un cristiano ha di perdonare ai proprii nemici. Allega passi del Nuovo Testamento e dei Padri: la dimostrazione è regolarissima. Ad un certo punto, quasi ad abundantiam, vuol dimostrare che il perdono ai nemici era praticato talvolta anche nell’antica imperfetta Legge ebraica, e cita a prova il passo: Averte mala inimicis meis: et in veritate tua disperde illos (Salmo 53 [ebr. 54], 7); in questo passo David pregherebbe Dio di distornare dai suoi nemici ogni male, e si limiterebbe a chiederne la dispersione affinché non gli nuocciano ancora. Io consiglio sinceramente il mio lettore - se è cristiano - di praticare il perdono ai proprii nemici; tuttavia altrettanto sinceramente lo invito a fondare il motivo del suo perdono sui precetti di Gesù e della Chiesa, ma non sul passo del Salmo addotto dall’autore francese : giacché, se si regolasse secondo il senso di quelle parole, dovrebbe augurare ai proprii nemici ogni sorta d’accidenti, di quelli spiacevoli. Il nostro oratore, infatti, ha evidentemente interpretato quell’ inimicis meis come un ablativo, quasi volesse dire: «Distorna i mali dai nemici miei»; e invece, disgraziatamente per l’oratore, è un dativo, come appare indubbiamente dal testo ebraico (aveva ragione sant’Agostino affermando la necessità di consultare i testi originali!), il quale ha la preposizione lĕ del dativo. Il senso genuino quindi è: «Distorna i mali ai nemici miei», ossia, Ritorci i mali [da me] sui nemici miei. In conclusione, una prova più avversa alla sua tesi l’oratore non poteva trovarla; e invece la adduce, in buona fede, come dimostrativa. È inutile poi dire che il passo in questione è uno dei tanti casi in cui la Bibbia è un monumento testificativo della superiorità che la nuova Legge cristiana ha sull’antica ebraica. Un cristiano, animato da zelo apostolico, mirerà alla conquista delle anime: è una frase oramai tradizionale. Il vero zelo non cerca i beni temporali, non le soddisfazioni personali anche se legittime, non i trionfi umani anche se meritati: cerca solo il bene delle anime, conquistandole a Cristo; di tutto il resto si disinteressa, come di bene infinitamente minore. A tale disposizione d’animo s’adattano a meraviglia le note parole: Da mihi animas, cetera tolle tibi (Genesi, 14, 21). Ecco il ritratto fedele del cristiano zelante, e il motto che serve da impresa a tutta la sua vita! Ottimamente: e ogni cristiano deve augurarsi che siano molte le persone che scelgano quel passo a motto della propria vita, come in realtà molte sante persone hanno fatto. Con tutto ciò, impiegato in quel senso, il passo è una pura purissima accomodazione. La Bibbia, là, dice tutt’altro; in quel passo anima sta per vita fisica, di uomini o di animali. L’autore biblico ha infatti raccontato in precedenza come Abramo avesse inseguito e sconfitto la retroguardia di cinque re orientali, ricuperando la preda che questi avevano fatta nella regione di Sodoma. Tornando egli con questa preda liberata gli si fa incontro il re dei Sodomiti, e gli recita appunto il passo in questione. Il senso è chiarissimo; il re, per gratitudine verso Abramo, lo invita a spartire con sé la preda del suo regno ricuperata dal valore di lui; la spartizione sarà fatta a forfait: il re si riprenderà gli esseri animati, e Abramo si terrà gli esseri inanimati. Ad esprimere «essere animati» abbiamo nel testo ebraico il termine nephesh, che già conosciamo, usato collettivamente; e se riscontriamo la versione greca dei Settanta troviamo che il termine è stato tradotto con uomini, come riferito certamente agli schiavi e agli altri prigionieri portati via dai vincitori. Tuttavia, a rigore, esso potrebbe riferirsi anche alle bestie depredate (camelli, asini, ecc.). La versione del Pontificio Istituto Biblico traduce il passo in questa maniera: Dammi le vite, e la roba tienla per te; e in nota avverte: «Le vite, le persone, gli uomini» (Il Pentateuco, Milano 1923, p. 23). Si ricordi infine che quelle parole non sono la «lettera di Dio», ma sono riportate in essa come una citazione; ivi cioè non parla Dio, ma parla il re dei Sodomiti: nella stessa guisa che nel passo, Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus (Salmo 13 [ebr. 14], 1), le parole Non est Deus non sono parole di Dio, bensì una citazione delle parole dell’insipiens. Il giogo di Cristo è soave, e il suo fardello è leggiero: l’ha detto Egli stesso. È un giogo greve più in apparenza che in realtà, mentre chi se lo sia caricato addosso con volonterosità, lo porta poi agevolmente. Per dimostrare questa verità un autore ascetico è ricorso al passo: Qui fingis laborem in praecepto (Salmo 93 [ebr. 94], 20); non poteva essere che un autore italiano, il quale - ingannato da quel sistema di tradurre a orecchio che già sopra deprecammo - ha interpretato quel fingis come l’italiano «fingere», «far finta», applicando il passo a Cristo. Cristo, nel precetto della nuova Legge cristiana, mette soltanto una parvenza, una finta, di fatica e travaglio (laboris); ma, in realtà, oltre quella finta non c’è più niente di travaglio, e la nuova Legge è tutta soavità e amore. Considerazioni consolanti. Peccato, soltanto, che il passo citato, invece di parlare di Cristo, parli del giudice empio e prevaricatore! Il verbo fingere non significa il suo omonimo italiano, bensì «formare», come del resto il nostro autore avrebbe potuto ritrovare al vers. 9 dello stesso Salmo: qui finxit oculum, non considerat?, tanto più che in ambedue i versetti anche l’ebraico ha lo stesso verbo. Il salmista dunque parla del giudice iniquo che lo sta a perseguitare, e che forma oppressione (cioè tiranneggia) contro la legge. Così dice il testo ebraico nel nostro passo, e così l’interpretano gli espositori moderni. Una «accomodazione»? Purtroppo sì. Ma ognuno può giudicare da sé quanto sia opportuno e riverente applicare a Cristo ed alla sua dottrina d’amore, ciò che la «lettera di Dio» dice del giudice empio e dei suoi soprusi tirannici; senza parlare poi del fingis interpretato come fai finta, che uno scolaretto di ginnasio avrebbe forse evitato. ...