Bibbia e non Bibbia, ab. G. Ricciotti, Morcelliana, Brescia, 1935. AIT DOMINUS?, parte 3. È un luogo comune degli autori ascetici, allorché raccomandano l’esercizio della meditazione, di ricorrere a quel passò: In meditatione mea exardescet ignis (Salmo 38 [ebr. 39], 4). È superfluo dire che sottoscriviamo volentieri alla raccomandazione; tuttavia qui desideriamo conoscere quale sia il preciso senso della «lettera di Dio» in quel passo. Il salmo è tutto un’amara riflessione sulla «Caducità umana». Con queste parole, molto giustamente, è presentato nella già citata traduzione del Pontificio Istituto Biblico (pag. 103); la quale, riassumendo i primi versetti, così fa parlare il salmista: «Al pensare la caducità della vita umana son quasi tentato a lagnarmi della provvidenza divina, e l’empia parola mi viene alla lingua; ma mi freno (posui ori meo custodiam) e taccio rassegnato, né più sogno di godimenti e piaceri (obmutui, et humiliatus sum, et silui a bonis). Però il mio dolore quanto più represso tanto più s’inasprisce, ecc.». Ecco dunque il senso del nostro passo! Esso va tradotto: S’infiamma il mio cuore nel mio interno, al mio ripensarci s’accende un fuoco! Ma, badiamo bene, è il fuoco a cui ha alluso prima; cioè il fuoco della ribellione contro la Provvidenza divina: fuoco che si riaccende ogni volta che il salmista ripensa alla caducità e miseria umana: fuoco che egli deve fare grandi sforzi a contenere nel suo interno, affinché non gli salga alla lingua in forma di bestemmia contro Dio, ed egli non delinquat in lingua sua (vers. 2). È dunque il senso precisamente opposto a quello della meditazione ascetica, che accende nel cristiano il fuoco dell’amor di Dio. Una «accomodazione»? Chi si vuol prendere la responsabilità di questa accomodazione, s’accomodi. I sensi, e specialmente gli occhi, sono le finestre dell’anima. È una norma comunissima negli scrittori ascetici; ed è anche giustissima, come dimostra sia l’esperienza, sia l’antico principio degli Scolastici, nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu. Quindi, chi vuole esser puro nell’anima, deve esser puro anche nei sensi, e specialmente negli occhi. Ottimamente. Ecco, però, che molti dei suddetti scrittori recano come prova di questa norma il passo di Geremia, 9, 21: Ascendit mors per fenestras nostras. Le finestre dell’uomo sarebbero, naturalmente, gli occhi, e la morte che penetra attraverso esse sarebbe la cattiva visione e dietro ad essa l’assenso e il peccato. No, come prova dimostrativa quel passo non dimostra nulla in proposito, e anche come «accomodazione» non si presta in maniera spontanea. Geremia là parla di tutt’altro: tratta delle guerre e delle conseguenti epidemie che Dio invierà come castigo al protervo popolo ebraico. Per convincersene basta leggere il passo nel suo contesto: Udite, o donne, la parola di Jahvé, accolga il vostro orecchio la parola della sua bocca! Insegnate alle vostre figliuole un lamento e ognuna alla sua compagna una canzone funebre. Ascese invero la morte per le finestre nostre, penetrò dentro alle nostre magioni, togliendo via il fanciullo dalla strada, il giovane da sopra alle piazze! Nella prima quartina il profeta allude alla costumanza delle canzoni funebri, che in occasione di funerali innalzavano le donne addette a quel mestiere (come le praeficae presso i Romani); ma poiché i funerali saranno troppi in quel terribile periodo e le solite donne non basteranno, egli a nome di Dio invita tutte le donne a imparare le nenie funebri. Nella seconda quartina poi è descritto lo squallore funereo che piomberà su tutto il popolo: case e strade saranno piene di cadaveri. In altre parole, le finestre sono le vere finestre delle case, e non gli occhi del corpo; e la morte è la morte fisica che uccide il corpo, e non il peccato che uccide l’anima. E poiché quella morte fisica entrava sia dalle finestre come dalle porte e da qualunque parte, l’appiglio per una «accomodazione» viene a mancare. Un appello quasi di prammatica, per un oratore che predichi un ritiro spirituale, è quello di ripetere il passo: Veni columba mea in foraminibus petrae in caverna maceriae (Cantico dei Cant., 2, 13-14). Applicazione ovvia: è Dio che invita l’anima, cioè la colomba, a venire nella solitudine spirituale, simboleggiata nelle mentovate grotte e spelonche. Eh, un momento! San Girolamo, credo io, sapeva il latino; e come va che qui costruisce il moto a luogo del verbo venire con due ablativi, foraminibus e caverna? Un bambino di seconda ginnasiale sa benissimo che là ci vorrebbero due accusativi; non vi pare? Vogliamo un po’ riscontrare il testo? Non vi spaventate, non il testo ebraico, basta quello latino. Se pigliamo l’edizione del Vercellone, Roma 1861 (che - a quanto mi si dice - è quella di cui si serve la S. Sede per gli atti ufficiali), troviamo il passo col suo contesto in questa forma e con questa punteggiatura. - 13 ... Surge, amica mea, speciosa mea, et veni: 14 Columba mea in foraminibus petrae, in caverna maceriae, ostende mihi faciem tuam, sonet vox tua in auribus meis etc. Ah! ecco dunque: il veni non si riferisce punto ai seguenti foraminibus e caverna (nonostante che il passo sia citato da parecchi autori in questa falsa maniera); col veni finisce un periodo, e con columba mea ne comincia un altro. E per fare questa mirabolante scoperta bastava osservare la punteggiatura della Vulgata! Allora il senso è chiarissimo e regolare, sia nel testo ebraico che nella Vulgata. È lo Sposo che recita la «mattinata» sotto le finestre dello Sposa (En dilectus meus loquitur mihi etc.; vers. 10), invitandola a venire a lui (surge, amica mea, speciosa mea, et veni: vers. 13). Ma perché l’invita a venire a lui? Appunto perché ella è irraggiungibile, ed egli non può arrivare a lei; e qui perciò egli soggiunge il nostro passo, che è opportunissimo nel contesto e va tradotto: O colomba mia [che stai] nei crepacci della rupe, nel nascondiglio del dirupo, lasciami vedere il tuo viso, lasciami ascoltare la tua voce ecc. In conclusione? Semplicissimo. San Girolamo ha tradotto perfettamente, e sono i suaccennati autori che gli fanno commettere errori di grammatica latina, unicamente perché non lo capiscono. E poi, non è lo Sposo che inviti la Sposa a recarsi nella solitudine; ma, al contrario, egli la invita ad uscire da quell’irraggiungibile e solitario rifugio, in cui ella già si trova, per recarsi presso di lui. Questo è l’indubitabile senso della «lettera di Dio» in questo passo. Chi ne vuol fare una «accomodazione» nella maniera detta sopra, faccia pure: sulla propria responsabilità. ...
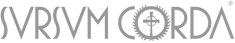
Organizzazione di Volontariato (O.D.V.)
C.da Piancardillo, snc - 85010 Pignola
Provincia di Potenza (ITALIA)
Redazione: editoria@sursumcorda.cloud
Donazioni: paypal@sursumcorda.cloud
Conto Postale n°
Iban:
Intestato a: Sursum Corda
Sursum Corda® - C.F. 01944030764
Prefisso Editore ISBN: 978-88-900747
Codice del Settimanale ISSN: 2499-6254 (Print)
Codice del Sito ISSN: 2499-6912 (Web)
Autorizzazione del Tribunale di Potenza:
Num. R.G. 281/2016 - N. R. Stampa 464
Direttore responsabile: Carlo Di Pietro
Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: 26372/23.03.2016
Settimanale Sursum Corda®: Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% S1/PZ/1726 - Per associarsi cliccare qui
Libri di Sursum Corda®: Poste Italiane SpA - Tariffa ridotta Pieghi di Libri - Autorizzazione n° TRE/SMA/S1/01782/04.2016
Iscrizione al Registro Regionale del Volontariato (settori Sociale e Culturale): 13AU.2017/D.00198 del 30/03/2017
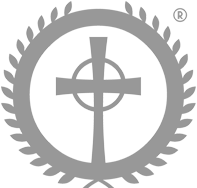



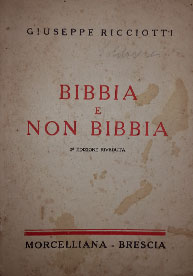










![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)