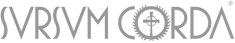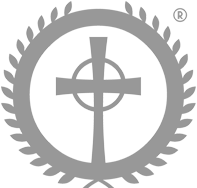Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo il nostro canale Youtube. Vi ricordiamo che è possibile destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Qui maggiori informazioni. Grazie, Dio Vi benedica!
Stimati Associati e gentili Sostenitori, segnaliamo il nostro canale Youtube. Vi ricordiamo che è possibile destinare il 5x1000 alla nostra piccola Associazione. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi (o in allegato ad altri modelli) il nostro codice fiscale - 01944030764 - nell’apposita casellina: «Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale ...». Qui maggiori informazioni. Grazie, Dio Vi benedica!
• Il venerando Abate Ricciotti oggi ci parla del Figliuol prodigo. § 466. Le due parabole precedenti (la pecorella smarrita e ritrovata, la dramma perduta e ritrovata, ndR) hanno mostrato quale sarà il contegno di Dio riguardo al peccatore che si penta e torni a lui; ma quale dovrà essere il contegno dell’uomo non peccatore riguardo al peccatore pentito? A questa nuova domanda risponde, dopo aver confermato il contegno di Dio, la parabola del figliuol prodigo. Letterariamente parlando, questa parabola non può essere definita che come un miracolo. Questo racconto, che nel campo morale è il massimo argomento di speranza per ogni figlio dell’uomo, nel campo letterario sarà sempre il massimo argomento di disperazione per ogni cultore dell’umana parola, come hanno riconosciuto da gran tempo studiosi di ogni tendenza. Nessuno scrittore al mondo ha raggiunto tanta potenza di commozione, in un racconto così breve, così vero, così privo di qualsiasi artificio letterario. La sua semplicità è somma, il disegno è appena lineare: eppure la sua efficacia è maggiore di quella d’altre narrazioni giustamente celebrate per sapienza di costruzione e limpidezza d’eloquio. Ripetere questa parabola con altre parole equivale indubbiamente ad offuscarne la bellezza; tuttavia, per ragioni di chiarezza storica, siamo costretti a questo deturpamento. Un uomo aveva due figli, con i quali viveva agiatamente in campagna curando i suoi vasti terreni e governando la numerosa servitù. Dei figli il maggiore era una vera perla: giovane serio e posato, non badava che alla fattoria, era il braccio destro di suo padre nel dirigere i lavori dei campi, non si prendeva uno svago con i pochi ed assennati amici che aveva. Il figlio minore era tutt’altro: pieno di fumi nel cervello, si sentiva soffocare in quella vita così puntuale e metodica; i lavori dei campi lo annoiavano, il gregge e l’armento lo infastidivano col loro tanfo, la fattoria gli sembrava un carcere dove i carcerieri erano i garzoni sempre pronti a fare la spia d’ogni sua azione al padre. Dai molti e scapati (persone senza senno, ndR) amici che aveva nei dintorni aveva sentito raccontare cose mirabili di grandi città lontane, dove si tenevano banchetti, danze, musiche, feste sbalorditive, dove si incontravano ad ogni passo donne profumate e piacevolissimi amici, invece delle puzzolenti pecoraie e dei lerci bifolchi di suo padre [Segnalazione. La vera e la falsa amicizia (Dottrina cattolica), ndR] . Là era la vera vita! Là lontano egli ripensava accorato nelle sere estive, quando dopo un’oziosa giornata se ne stava sdraiato sul prato della fattoria rassegnandosi a sentir cantare i grilli, e riflettendo con melanconia che i mesi e gli anni volavano via irrimediabilmente e che la sua gioventù sfumava nel vuoto e nella noia. Ma un giorno il giovane non ne poté più e prese la sua risoluzione, conforme a ciò che qualche tempo prima gli era stata suggerito da un amico. Si presentò egli al padre e gli disse senz’altro: «Padre, dammi la parte del patrimonio che (mi) spetta». La richiesta non era irregolare: secondo la Legge ebraica (Deuteronomio, 21, 17), il figlio primogenito aveva diritto a una parte doppia; in questo caso, essendo due figli, al minore spettava un terzo dell’asse ereditario. A quella richiesta, il padre dovette guardare lungamente negli occhi il giovane, ma non disse parola, come il giovane non ardì aggiungere parola a quella della richiesta; l’uno s’allontanò dall’altro in silenzio. In questo scambievole silenzio, che durò più giorni, la spartizione fu fatta; i beni immobili da cedersi furono convertiti in denaro, e non molti giorni dopo, radunata ogni cosa, il figlio più giovane emigrò in una regione lontana. Finalmente cominciava la vera vita! La regione era assai lontana, ignara affatto dei pregiudizi di morale ebraica e anzi seguace di costumanze aborrite dall’ebraismo; il giovane vi entrava provvisto di gran denaro, equivalente alla terza parte di un asse molto considerevole; poteva dunque fare il piacer suo. I suoi antichi sogni cominciavano a diventare realtà, e quell’assetato di godimenti vi si immerse a corpo morto. Il testo dice che egli si dette a vivere sfrenatamente o dissolutamente, sia anche prodigalmente o da scialacquatore; le due maniere, del resto, sono necessariamente congiunte tra loro. I giorni passavano presto e bene, in quella vita; ma vennero anche le conseguenze. Dopo un certo tempo, insieme col tempo, era passato anche il denaro, unica fonte di quei piaceri, giacché per quanto ricolma fosse stata da principio la borsa del giovane, non era poi senza fondo. Ma la febbre del piacere l’aveva subito pervaso ed accecato a tal punto, da non lasciargli vedere che la borsa andava sempre più scemando. Un giorno, poi, rimase affatto vuota. La vita “beata” era finita; ne cominciava un’altra ben diversa.
• § 467. Avendo dunque egli speso tutto, avvenne gran fame in quella regione, ed egli cominciò ad aver bisogno. Il gaudente di ieri è adesso assalito da due parti, all’interno e all’esterno; non solo la sua borsa è vuota, ma nel paese è giunta a un tratto la carestia, una di quelle carestie che mettono in ristrettezze anche chi in tempo ordinario vive senza stenti, ed è superfluo dire che gli amici adulatori di ieri sono scomparsi insieme col denaro dell’adulato e adesso badano soltanto ai casi propri. In tali frangenti e in paese straniero il giovane non ha da sofisticare: o morir di fame, o mettersi a lavorare come capita, anche nel lavoro più umiliante e schifoso. Egli allora andò e s’attaccò a uno dei cittadini di quella regione; e (costui) lo mandò nei suoi campi a pascere i porci. Era dunque una regione non giudaica, altrimenti non vi si sarebbero allevati i porci; questo animale, impuro secondo la Legge ebraica, era così abominato dai Giudei, che evitavano perfino di nominarlo, e un dottore del Talmud poteva sentenziare: «Maledetto l’uomo che alleva porci, e maledetto chi insegna a suo figlio la sapienza greca» (Baba qamma, 82 b Bar.). E così il gaudente di ieri è divenuto porcaio: ma se con ciò ha evitato la morte, non ha evitato la fame che gli rode continuamente le viscere. C’è penuria di tutto; i porci, grufolanti tutta la giornata per i campi sotto la sua sorveglianza, trovano poco o niente, ma almeno la sera, tornati al porcile, ricevono la loro razione di carrube, e bene o male si saziano. Lui no; per lui non c’è nemmeno una sola carruba: il porcaio vale assai meno d’un porco. Ed è un Giudeo! E bramava riempire il suo ventre delle carrube che i porci mangiavano e nessuno glie(le) dava. In queste spaventose condizioni passa parecchio tempo. Durante le soste canicolari (sotto il sole torrido, ndR), quando i porci famelici ed estenuati si sdraiano all’ombra di un albero, anche l’emaciato porcaio si sdraia a fianco loro fra la polvere e il letame; ma il pensiero gli vola ostinatamente alle lontane serate estive, quando sdraiato sul prato della fattoria paterna sentiva cantare i grilli vagando con la mente dietro ai sogni del futuro. Quei rosei sogni si sono adesso pienamente avverati; egli li sente attorno a sé nei porci che grugniscono, addosso a sé nei luridi e fetenti stracci di cui è coperto, dentro di sé nella fame che gli torce le budella. Tornato pertanto in se stesso disse: «Quanti mercenari di mio padre abbondano di pani, e io invece qui muoio di fame!». E che fare? Tornare dal padre? Ma come averne il coraggio, dopo quello che è accaduto? Ebbene, si può tornare a lui non come a padre ma come a padrone; sarà sempre un guadagno immenso vivere a mercede nella fattoria paterna come un garzone qualunque, piuttosto che continuare in quella vita nefanda ch’è una lenta morte. Certo sarà una gran degnazione da parte del padre se dimenticherà l’ingiuria ricevuta e se vorrà accoglierlo - non già come figlio, beninteso - ma solo come umile garzone; ma quell’uomo è così buono che forse acconsentirà a riceverlo! «Sorto, me n’andrò da mio padre e gli dirò: Padre, peccai contro il cielo (= Dio) e innanzi a te! Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio! Fammi come uno dei tuoi mercenari!».
• § 468. Sorretto da questa speranza e raccolte le ultime sue energie, il giovane si mette in viaggio verso la fattoria paterna. Durante il cammino, più volte il cencioso viandante, stremato di forze, dispera di poter giungere alla beata mèta, più volte sopraffatto dal ricordo della sua partenza dispera di esservi accolto almeno come un cane randagio. Ma non c’è altro per lui: il mondo intero adesso si racchiude per lui in quella fattoria. Ed egli, strascinandosi per la strada come meglio può, finalmente vi giunge. È un chiaro pomeriggio. Suo padre sta nei campi a sorvegliare i lavori; ma il suo occhio solerte, che scorre da aratro ad aratro e da garzone a garzone, non ha più la limpidezza di una volta; è velato, mostra le stigmate di una pena antica ma non invecchiata, e di tanto in tanto si fissa là verso l’estremo Orizzonte restando immobile a riguardare chissà quali fantasmi. Mentre però egli stava ancora assai distante, suo padre lo vide e (ne) fu intenerito; e correndo gli cadde sul collo e lo baciò. Un bacio? Anzi molti e molti baci su quel collo pidocchioso e su quella barba inzaccherata? Certo il padre l’ha riconosciuto pur ridotto in quello stato; ma appunto perché l’ha riconosciuto come mai lo bacia? Come mai non chiama invece i garzoni per farlo menar via? Non è egli il figlio che ha rinnegato suo padre? È necessario attirare su ciò l’attenzione del vecchio. Gli disse allora il figlio: «Padre, peccai contro il cielo e innanzi a te! Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio!». È il discorsetto già preparato a memoria, che qui però è accorciato mancando l’implorazione finale: «Fammi come uno dei tuoi mercenari!». Non ha il coraggio il figlio di implorare il posto di servo davanti a quell’effusione di bontà paterna, oppure l’implorazione è impedita da altri baci? Ma a che cosa serve quell’implorazione? Sono parole vane, supremamente inutili; il padre non le avverte nemmeno. Tutto concitato, il vecchio si rivolge ai garzoni accorsi, e: «Presto! Tirate fuori la veste migliore e rivestitelo, e mettetegli un anello alla mano e sandali ai piedi!». E come no? Non è forse il padroncino che rientra? Deve forse un solo istante di più comparire così sfigurato e deturpato, il padroncino? Quando poi egli è rivestito e rimesso a nuovo, bisogna che tutti facciano festa insieme; si abbandonino aratri e zappe, e si prepari un gran banchetto: «E portate il vitello ingrassato, ammazzate(lo), e banchettando facciamo festa! Perché questo figlio mio era morto e tornò in vita, era perduto e fu ritrovato!».
• § 469. A questi fatti non fu presente il figlio maggiore; quella perla di giovane, come al solito, stava al lavoro, e in quel pomeriggio si era recato nei campi più lontani dal casale per certe faccende a cui doveva badare. Ritornò quindi assai tardi, quando il banchetto era inoltrato e quando le copiose libazioni avevano rafforzato le ugole al canto e i piedi alla danza. A sentire tutto quel frastuono, il giovane posato cadde dalle nuvole. Allora, chiamato uno dei garzoni, domandava che cosa fosse ciò. E quello gli disse: «È arrivato tuo fratello, e tuo padre ammazzò il vitello ingrassato perché lo riebbe sano e salvo». Ma naturalmente il garzone non si fermò qui, e cominciò ad informare l’interrogante su tutto il resto, descrivendo cioè come il fratello fosse arrivato in uno stato tale che l’ultimo cane rognoso della fattoria a petto a lui sembrava il sommo sacerdote di Gerusalemme. Il figlio maggiore ne rimase accorato. Dunque, per quel giovinastro che era il danno e la vergogna della famiglia, il padre faceva tanta baldoria? Ma era impazzito anche il padre? Se però il vecchio era rimbecillito, il suo unico degno figlio, che era stato sempre con la testa a posto, non aveva nessuna intenzione di imitarlo. Si adirò allora e non voleva entrare. Ma suo padre, uscito fuori, si raccomandava a lui. Quello però rispondendo, disse al padre: «Ecco! Da tanti anni ti faccio da servo, e giammai trasgredii un tuo comando, e a me giammai desti un capretto affinché con gli amici miei facessi festa! Quando invece venne cotesto tuo figlio, che ha divorato le tue sostanze con le prostitute, ammazzasti per lui il vitello ingrassato!». Il (padre) allora gli disse: «Figlio! Tu sempre stai con me, e tutte le cose mie sono tue. Ma far festa e rallegrarsi bisognava, perché cotesto tuo fratello era morto e (ri)visse, ed era perduto e fu ritrovato!». Si osservi come il figlio maggiore, parlando del minore al padre, lo chiami cotesto tuo figlio; il padre, invece, parlando dello stesso al figlio maggiore, lo chiama cotesto tuo fratello. Il maggiore ha quasi paura di imbrattarsi la bocca chiamando quello scapestrato suo fratello, e vorrebbe rinnegarlo come tale; il padre gli ricorda che lo scapestrato è suo fratello, e quindi egli lo deve trattare come tale, nella stessa guisa che egli padre lo ha già trattato come figlio. L’insegnamento morale di questa seconda parte della parabola è tutto qui: come il padre è sempre padre, così il fratello sia sempre fratello. È dunque falsa la conclusione decretata da pochi critici, per i quali la seconda parte della parabola - cioè l’episodio del fratello maggiore - sarebbe un’aggiunta fatta tardivamente. Al contrario, la mira generale di tutta la parabola include anche l’insegnamento contenuto in quella seconda parte. Nella prima parte la parabola ha insegnato la misericordia per il peccatore pentito, elargitagli da Dio ch’è suo padre, ma questo insegnamento non è nuovo perché è già stato proposto nelle precedenti parabole della pecora e della dramma perdute; nella seconda parte poi insegna la necessità della misericordia per il peccatore pentito elargitagli anche dall’uomo ch’è suo fratello, e precisamente come conseguenza del perdono del padre e in riconnessione con quel perdono. Questa seconda parte della parabola è dunque veramente la cupola di tutto l’edificio e il suo coronamento supremo. Non si può dire che il fratello maggiore, sdegnato della bontà paterna, simboleggia storicamente i Farisei, sdegnati della bontà di Gesù per i pubblicani e i peccatori. Il simbolo invece ha valore più ampio, e include qualunque figlio del Padre celeste che sia geloso della misericordia di quel Padre verso un altro figlio rinsavito dopo un traviamento.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.

























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)