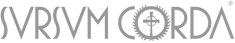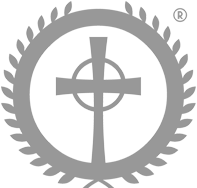Comunicati e Note
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, nel 1974 il noto editore Giovanni Volpe di Roma pubblicava il volumetto «Fatima e la peste del Socialismo» di Mons. Francesco Spadafora. Oggi dedicheremo il nostro approfondimento allo studio di suddetto libro.
• Da anni, si parla del «segreto» di Fatima; delle rivelazioni cioè, comunicate dalla Madonna ai tre piccoli veggenti portoghesi, una dei quali, entrata nel Carmelo, Suor Lucia, è tuttora vivente (le citazioni sono testuali e datate 1974, ndR). Quel messaggio è del 1917! Non c’è bisogno di rievocare quanto avvenne a Fatima: il segno celeste del sole roteante, a conferma della realtà delle visioni e delle comunicazioni celesti. Migliaia e migliaia di uomini accorrono a Fatima, come a Lourdes. Quando (...) Paolo VI, si recò a Fatima — quasi a conferma ufficiale — Suor Lucia era lì ad attenderlo; forse, se ne avesse avuto l’opportunità, l’umile suora avrebbe ancora una volta parlato accoratamente al Pontefice delle sciagure che pesano sull’umanità e dell’esito dell’immane flagello predetto fin dal 1917.
• Quel messaggio non rimase isolato. Suor Lucia il 28 maggio 1958 ne trasmise un altro che lo conferma e lo precisa. Quindi c’è tutta una serie di comunicazioni che riaffermano e specificano nei dettagli i punti essenziali di quel «segreto». Dopo aver richiamato le linee essenziali del messaggio di Fatima, ci proponiamo in questo servizio di dare un saggio, per quanto possibile esatto e criticamente sicuro, delle precisazioni offerte nelle altre rivelazioni, per lo più, finora, inedite e sconosciute. «Il terzo segreto di Fatima » è stato presentato agli italiani dal compianto Giulio A. Schettini nel settimanale «lo Specchio» il 14 aprile 1967. Riferiremo spesso ad litteram il contenuto di quello studio accurato. Nel 1942,il cardinale Schuster, per disposizione di Papa Pio XII, rese note al mondo le prime due parti del segreto. Vi si parlava di guerra, di fame, e di persecuzioni contro la Chiesa. Vi si affermava in particolare: «dalla Russia partiranno le malvagità destinate a corrompere i popoli e a gettare le nazioni le une contro le altre. Ma se si ascolteranno le mie parole (era la Madonna a parlare: invitava gli uomini a pregare, a convertirsi a Dio), la Russia si convertirà e vi sarà pace».
• È a questo punto che si colloca la «terza parte». Si attese con ansia la sua pubblicazione nel 1960, quando il messaggio dalla diocesi di Leira, dov’era custodito, giunse in Vaticano. Era la data scelta. Né allora, né poi, fino ad oggi, l’attesa è stata appagata. Solo un’indiscrezione diplomatica avrebbe permesso di conoscerne il contenuto ad un ristretto ambiente cattolico. Il documento sarebbe stato inviato in copia, per desiderio di Giovanni XXIII, alle Cancellerie di Washington, Mosca e Londra: si riteneva che esso avrebbe potuto giovare alla cessazione degli armamenti nucleari, e più genericamente, ad evitare un conflitto tra le grandi potenze. Nel corso della presa di conoscenza del messaggio o subito dopo, sarebbe avvenuta l’indiscrezione suddetta. Pubblicato in estratto su giornale di Stuttgart, «News Europa» del 15 ottobre 1963, il documento non è stato mai direttamente smentito.
• Eccone il testo, nelle parti essenziali. «Un grande castigo cadrà sull’intero genere umano, non oggi, né domani (era il 13 ottobre 1917: mentre la Vergine parlava a Lucia, Giacinta e Francesco, oltre sessantamila persone potettero assistere al miracolo del sole che impazzì nel cielo di Fatima), ma nella seconda metà del XX° secolo. In nessuna parte del mondo vi è ordine, e Satana regna sui più alti posti, determinando l’andamento delle cose. Egli effettivamente riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa: riuscirà a sedurre gli spiriti dei grandi scienziati che inventano le armi, con le quali sarà possibile distruggere in pochi minuti gran parte dell’umanità. Avrà in potere i potenti che governano i popoli e li aizzerà a fabbricare enormi quantità di quelle armi. E, se l’umanità non saprà opporvisi, correggendosi..., Iddio castigherà il mondo con maggiore severità che non abbia fatto con il diluvio. Se la umanità non si convertirà..., i grandi... periranno insieme ai piccoli e ai deboli. Anche per la Chiesa verrà il tempo delle sue più grandi prove; cardinali si opporranno a cardinali; vescovi a vescovi. Satana marcerà in mezzo alle loro file e a Roma avverranno grandi cambiamenti. Ciò che è putrido cadrà e più non si alzerà. La Chiesa sarà offuscata e il mondo sconvolto dal terrore. Una grande guerra si scatenerà nella seconda metà del XX° secolo. Fuoco e fumo cadranno dal cielo, le acque degli oceani diverranno vapori e la schiuma si innalzerà sconvolgendo e tutto affondando. Milioni e milioni di uomini periranno di ora in ora e coloro che resteranno in vita invidieranno i morti. Sarà angoscia, miseria, rovine in tutti i paesi... I superstiti proclameranno nuovamente Iddio e la sua Gloria, e lo serviranno come un tempo, quando il mondo non era così pervertito».
• Il servizio del compianto G. A. Schettini continua col messaggio del 22 maggio 1958 che Lucia affidò al gesuita P. Agostino Fuentes, e che fu pubblicato dalla rivista mariana «La Immacolata» nel numero di gennaio-febbraio 1959. «La Madonna è molto scontenta perché non si è fatto caso al suo messaggio del 1917. Né dai buoni, né dai cattivi: i buoni vanno per la loro strada senza preoccuparsi e non seguono le norme celestiali; i cattivi nella via larga della perdizione non tengono in alcun conto i castighi minacciati. Il Signore Iddio molto presto castigherà il mondo. Molte nazioni spariranno dalla faccia della terra. Nazioni senza Dio saranno il flagello scelto da Dio per castigare l’umanità, se noi, per mezzo dell’orazione e dei santissimi sacramenti, non otterremo la grazia della loro conversione. Il demonio sta attaccando la battaglia decisiva contro la Madonna, operando la caduta delle anime religiose e sacerdotali. Bisogna dire alle persone che non devono stare a sperare un richiamo alla preghiera e alla penitenza, né dal Sommo Pontefice, né dai Vescovi, né dai Parroci, né dai Superiori generali. È già tempo che ognuno compia opere sante e riformi la sua vita secondo i richiami della Madonna santissima. Il demonio vuole impadronirsi delle anime consacrate, lavora per corromperle, per indurre gli altri alla impenitenza finale: usa tutte le astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa! Ne proviene sterilità alla vita interiore e freddezza nei secolari, circa la rinunzia ai piaceri e la totale immolazione a Dio. È urgente che ci si renda conto della terribile realtà. Non si vuole riempire le anime di paura, ma è solo un richiamo urgente, perché da quando la Vergine Santissima ha dato grande efficacia al santo Rosario, non c’è problema né materiale né spirituale, nazionale o internazionale, che non si possa risolvere con il santo Rosario e con i nostri sacrifici».
• In brevi righe di commento, Schettini scriveva: «Con le apparizioni iniziate il 13 maggio 1917, additando il male che si annidava nell’umanità e quindi i tremendi castighi che Dio avrebbe mandato, la Bianca Signora di Fatima scandì le vicissitudini di questo secolo. Fatima è stato un faro, nell’arco dei cinquanta anni dal 13 maggio 1917 al 13 maggio 1967 (e diciamo: fino ad oggi), per l’ansia di milioni di persone. Di quanti vi hanno creduto e di quanti, pur non credendovi, han riscontrato nel precipitare degli avvenimenti (e nella realizzazione in parte degli eventi predetti) le parole della Madonna. Per gli uni e per gli altri ha rappresentato nella grande confusione dei tempi moderni un punto di riferimento. Vintila Horia scriveva (Adveniat Regnum, 1966, nn. 3-4) che tutto quanto è accaduto dal 1960 (data in cui la terza parte del segreto giunse in Vaticano): cioè, l’atteggiamento di Giovanni XXIII, i mutamenti registrati nella Chiesa, ciò che più tardi si è chiamata “la necessità del dialogo” con l’evidente affannosa preoccupazione di aprire una via per riuscire a toccare il cuore della Russia, si pose in atto in seguito alla lettura di quel messaggio. Se non fosse così, tutti questi mutamenti, tutte queste umiliazioni, questa premura di compiere tutto nel più breve tempo possibile, sarebbero difficili a comprendersi e ad accettarsi. L’ateismo sovietico è certo il punto d’appoggio su cui fa leva l’anticristo. Si può dire — continua Schettini con esattezza — che tutta la profezia di Fatima ruota su questo ammonimento. Contro il progressismo ateo, il messaggio oppone la mistica cristiana: la più umile, la più tradizionale: il Rosario».
• È quel che risulta senza possibilità di equivoci dal testo del messaggio; mentre le varie suggestioni di addossare al messaggio di Fatima le «stranezze» verificatesi nella Chiesa e in Italia dal 1960 in poi, risultano senza fondamento, anzi, vedremo, in netta opposizione alle rivelazioni della Madonna. Per la loro retta interpretazione, e come norma per ben giudicare, tra i numerosi messaggi cui si alludeva all’inizio, le vere profezie di origine soprannaturale, abbiamo un libro sacro, «la profezia»; «la rivelazione» o Apocalisse di san Giovanni, l’evangelista. Questo libro ispirato riprende e svolge l’insegnamento di Gesù nella profezia sulla fine di Gerusalemme (Matteo 24 e passi paralleli): «Nella lotta violenta, sanguinosa e senza quartiere, che il giudaismo condurrà contro la Chiesa, non questa soccomberà, ma il primo». È un monito che vale per tutti i tempi; monito ripreso e svolto da san Giovanni nell’Apocalisse: «La persecuzione accompagnerà sempre la Chiesa che ne uscirà sempre vincitrice e purificata. San Giovanni parte dal nemico allora attuale (siamo circa al 90 d.C., poco prima della persecuzione di Domiziano, che riprenderà le violenze crudeli messe in atto da Nerone [64-67] contro i cristiani): l’impero romano, per predirne la sconfitta, la completa rovina ed assicurare il trionfo della Chiesa, che sola rimarrà vittoriosa. Quello che è necessario per i cristiani è la fedeltà alla loro professione di fede; il vero pericolo non è la violenza dall’esterno, quanto la disunione interna, le beghe interne, la flessione dalla purezza della dottrina e la rilassatezza dei costumi. I fedeli devono comprendere che ogni flagello è mandato da Dio come pena vendicativa per gli empi, medicinale per tutti, e purificatrice per gli eletti. Lotta perenne tra la città di Dio ( per adoperare l’espressione di sant’Agostino ) e la città di Satana. Anche caduto l’impero romano, la lotta contro la città di Dio sarà continuata da altri, ma sempre con lo stesso risultato. Satana infatti è sempre lo stesso; cambiano i suoi luogotenenti o rappresentanti o strumenti umani: così nell’Apocalisse il Dragone (Satana) fa salire dal mare (l’occidente) la Bestia dalle sette teste, cioè, l’impero di Roma, che dominerà l’universo (allora conosciuto) e perseguiterà i santi; e chiama una seconda bestia che sale dalla terra (l’Asia Minore: si ricordi che Giovanni scrisse l’Apocalisse mentre era relegato nell’isola di Patmos); essa ha il compito di persuadere gli uomini ad adorare la prima Bestia: adoperando i sofismi e tutte le menzogne dell’errore. La potenza da sola non riuscirebbe al suo scopo; è la menzogna, l’errore ad ubriacare gli uomini e a renderli schiavi di Satana. Un solo esempio: l’epica lotta secolare e crudele dell’impero ottomano contro la cristianità, contro Roma. La cristianità fu salva; basti ricordare Lepanto e Vienna: battaglie decisive, due splendide vittorie dei cristiani che sotto l’impulso instancabile di due pontefici santi, Pio V e Innocenzo XI, si rivolsero alla Vergine santissima, con la preghiera umile e tradizionale del Rosario. La Chiesa è stata (e sarà) sempre perseguitata dalle forze del male, ma è uscita ed uscirà sempre vittoriosa e purificata: sua arma invincibile è la preghiera, la fedeltà immutata al suo fondatore Gesù e alla dottrina evangelica.
• Il messaggio di Fatima è perfettamente in linea con la rivelazione o Apocalisse di san Giovanni; in linea con le realizzazioni di essa in tutta la storia della Chiesa. Rileviamone i punti essenziali. Messaggio 1917: «Una grande guerra», «un grande castigo cadrà sull’intero genere umano», «si scatenerà nella seconda metà del secolo ventesimo»; cioè dal 1950 in poi; siamo al 1973, il tempo si è ristretto ai prossimi ventisette anni. La descrizione del flagello immane — si pensi che il messaggio è del 1917 —, ormai non ha veli per noi: si tratta dell’atomica: «fuoco e fumo cadranno dal cielo...; milioni e milioni di uomini periranno di ora in ora». Strumento attuale di Satana nel mondo, per la sua lotta contro «la città di Dio», è la Russia. «Satana regna sui più alti posti determinando l’andamento delle cose»... La Russia — lo constatiamo esercita la sua nefasta influenza ed estende ovunque i suoi tentacoli, mediante il marxismo, la dottrina che propina il veleno dell’ateismo e della negazione di ogni valore morale ed umano, sotto le mentite spoglie di una crociata umanitaria contro l’ingiustizia, la miseria e le sofferenze delle classi operaie. Lupo sotto veste d’agnello, rende schiavi i popoli e le nazioni che riesce a rinchiudere nella sua ferrea disciplina; parla sempre di pace e moltiplica i suoi armamenti nucleari, fomenta ovunque nel mondo ed alimenta con mezzi possenti la guerra aperta tra popoli e nazioni. Effetto palese dell’impero di Satana, di cui la Russia è luogo-tenente e docile strumento, è l’odio e la menzogna. Gesù definisce Satana: «omicida e menzognero» (Giovanni 8, 44), fautore di odio e di ogni frode. Il marxismo ha l’uno come oggetto e l’altro come mezzo della sua propaganda: inculca l’odio, si serve della menzogna. Nell’evangelo è detto: «Dio è amore», il marxismo è odio; perciò non c’è in esso posto per Dio. È esattamente l’oppositore di Cristo; l’anticristo per antonomasia. Il suo impero si estende ovunque. Satana è riuscito a penetrare nella stessa gerarchia della Chiesa, a generare grande confusione nella dottrina, rilassamento nei costumi e nella disciplina: «Satana riuscirà ad introdursi fino alla sommità della Chiesa... Cardinali si opporranno a Cardinali; vescovi a vescovi... Satana marcerà in mezzo alle loro fila, ed a Roma avverranno grandi cambiamenti. La Chiesa sarà offuscata...». Ecco perché la «grande guerra» sarà un «castigo» del Signore: il suo esito sarà anche l’esito di questa epica lotta secolare tra la città di Dio (i fedeli che si salveranno con la recita del Rosario) e la «città di Satana», gli empi, la Russia con il suo marxismo. Un castigo per l’infedeltà di tanti cristiani e per il dilagare del peccato nel mondo; mezzo di purificazione per la Chiesa, perché ritorni ad essere «columna et firmamentum veritatis», faro di luce per tutte le genti, depositaria unica della verità.
• Nel 1917 la Vergine offriva alla cristianità la medicina contro l’invadente impero di Satana: la preghiera, il Rosario, lo spirito di sacrificio. Purtroppo, in genere, il mondo ha preferito allearsi col rappresentante di Satana. Più non si riconosce il volto della Chiesa cattolica: triste stato di disunione, di lotta tra gli affossatori del passato, propugnatori di intesa con il marxismo, e i fedeli fermi alla dottrina cattolica, integra, data da Gesù, trasmessaci dagli Apostoli, e che nessuno ha la facoltà di cambiare. I cambiamenti: culto, clero, seminari: cambiamenti che si è arrivati a definire una dissacrazione, una profanazione; una laicizzazione. Le ombre più oscure gravano in tal modo sul futuro della Chiesa cattolica. È dunque adesso palesemente ridicola la giustificazione addotta da quei funesti rami di Azione cattolica al loro fanatico sinistrismo: cioè la profezia di Fatima che la Russia si sarebbe convertita. Non si ottiene la conversione della Russia favorendo la diffusione del marxismo, alleandosi con i marxisti, cioè passando al campo di Satana. Fin dal 1917 la Vergine aveva precisato nel suo messaggio: «Gli uomini devono correggersi. Con umili suppliche devono chiedere perdono dei peccati commessi...». La preghiera e la pratica della vita cristiana; il Rosario: ecco le armi, i mezzi indicati dalla Madonna. Sono esattamente i mezzi che hanno salvato la Chiesa nel passato, contro gli attacchi di Satana: a Lepanto, a Vienna. Ecco perché: «Iddio castigherà il mondo con maggiore severità, che non abbia fatto con il diluvio». I mutamenti nel culto hanno messo in disuso il Rosario, per amore di ecumenismo, cioè per far piacere ai multicolori discendenti di Lutero che san Lorenzo da Brindisi, dottore della Chiesa, ha ben descritto luogotenente e strumento di Satana, per il suo tempo (San Lorenzo da Brindisi, Lutero, in tre volumetti, Ezio Cantagalli, Siena 1932-1933): fautore di odio e nemico della verità. Ecco perché rimane la minaccia dell’immane flagello.
• Messaggio 1958. Gli uomini non hanno fatto caso al messaggio del 1917; è una dolorosa constatazione. Ora (1973) possiamo aggiungere che tutto è peggiorato: nel mondo e nella stessa Chiesa. «Il demonio vuole impadronirsi delle anime consacrate...; adopera tutte le astuzie, suggerendo perfino di aggiornare la vita religiosa! Ne proviene sterilità nella vita interiore e freddezza nei secolari circa la rinunzia ai piaceri e la totale immolazione a Dio». Dunque aggiornamento della vita religiosa, il culto della persona, il clima di dolce vita che si va diffondendo tra i religiosi, nel clero, ed è in atto tra i giovani (non osiamo dirli “seminaristi”) che forse saranno i «presidenti delle assemblee cultuali» di domani, sono suggestione di Satana! Non ci è dunque da aspettarsi altro che il castigo: « Molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra». Strumento di tale flagello: «nazioni senza Dio», cioè la Russia e i suoi accoliti. Unico mezzo per la salvezza: «il santo Rosario e i nostri sacrifici».
• Di particolare interesse, per la molteplicità e la chiarezza, e inoltre per i riferimenti all’Italia, sono le rivelazioni o messaggi che, dal 18 aprile 1938 al venerdì santo del 1961, per ben ventitré anni, trasmise la fondatrice delle Suore Minime della Passione, Suor Elena Aiello. La sua biografia, documentata ed illustrata, è a disposizione del pubblico, edita da Città Nuova Editrice: Suor Elena Aiello, la monaca santa, 1964. Nata a Montalto Uffugo (Cosenza) il 16 aprile 1895, morì a Roma il 19 giugno 1961. Dal 2 marzo 1923 al venerdì santo 1961, ella riviveva la Passione di Gesù, ogni venerdì di quaresima, in particolare ogni venerdì santo nelle tre ore di agonia dalle dodici circa alle quindici, le tre ore cioè intercorse sul Calvario tra la crocifissione e la morte del Redentore.
• Le rivelazioni dal 1923 al 1937, almeno per quanto ne sappia, non sono state raccolte o conservate. II Dr. Guido Palmardita, già prefetto a Cosenza, così scriveva: «Fui presente per due venerdì del marzo 1938, con il Questore, il Maggiore dei Carabinieri e il Prof. Santoro (allora Medico Primario dell’Ospedale Civile), ai fenomeni straordinari: le doloranti ferite delle mani, dei piedi, del costato, il sudore sanguigno, le visioni e la trasformazione immediata alla fine, con la scomparsa del sangue sul volto luminoso e raggiante». Questi fenomeni, ai quali anch’io non rare volte ho assistito, sono descritti ed illustrati criticamente nella suddetta biografia. La stigmatizzata, come Teresa Neumann e P. Pio da Pietralcina, mentre perdeva ogni contatto dei sensi esterni con l’ambiente circostante, di tanto in tanto, a voce alta o comunque comprensibile ai presenti, descriveva le scene della Passione che ella seguiva con i sensi interni e con le facoltà dell’animo, oppure comunicava delle rivelazioni. Luciano Barca a proposito della Neumann scrive: «Teresa legge nel segreto delle coscienze. Sono fatti certi, ormai a tutti noti. Uno dei più clamorosi è l’episodio raccontato da Mons. Schrembs, Vescovo di Cleveland, che fu a Konnersreuth nella primavera del 1928 accompagnato dal suo Cancelliere Mons. Fadden e da alcuni pellegrini. Mons. Schrembs è oriundo bavarese... La visita alla Neumann è stata raccontata da lui stesso... «Mentre mi trovavo nella camera delle visioni con molti altri pellegrini, entrò la madre di Teresa. Mons. A. Mac Fadden sedeva dietro di me. Ad un tratto Teresa, che non poteva aver avvertita l’entrata della madre, disse a voce bassa: “Mamma, questo signore accanto a te (voleva indicare me) è originario di questo paese. Nacque non molto lontano da qui. Tuttavia egli abita ora al di là del mare e svolge una grande attività per la causa di Dio. Egli è chiamato a fare ancora molto. Ho da dire qualche cosa, a lui solo”. I pellegrini raccolti nella stanza incominciarono ad uscire e con loro anche Mons. Mac Fadden. Allora Teresa disse: “Il signore dietro di te, può restare: tanto non capisce il tedesco”. E così Monsignore divenne l’unico testimone auricolare del colloquio confidenzialissimo svoltosi fra Teresa e me. Ella svelò i segreti più profondi della mia anima che solo Iddio ed io conoscevamo. Mi parlò poi del passato e dell’avvenire».
• Lo stesso avveniva durante le «sofferenze» di Suor Elena Aiello e non di rado anche al di fuori di esse. La biografia, dopo aver riportato il brano del Barra prosegue: «Di Elena Aiello si narrano, da parte degli interessati, molti episodi analoghi; alcuni sono a nostra conoscenza. In attesa però che ne siano raccolte le testimonianze giurate, ci siamo limitati a riferire, nel corso di questi appunti, soltanto quei pochi di cui possiamo garantire, di persona, la precisa formulazione e l’oggettiva rispondenza con l’avvenuta realizzazione». La realizzazione di una profezia è intatti il mezzo più sicuro e pratico per discernere il profeta autentico, portavoce di Dio. Suor Elena Aiello ha brillantemente superato questa prova. il 19 marzo 1956, Il Giornale d’Italia pubblicò la lettera messaggio consegnata il 6 maggio 1940 a Roma da Suor Elena Aiello alla sorella del Duce, signora Edvige Mancini Mussolini. La lettera, datata Cosenza 23 aprile 1940, era diretta: «Al Capo del Governo Benito Mussolini». Si può leggere per intero nella biografia suddetta (pp. 178-180). Vi è detto, tra l’altro: «I Governatori dei popoli sono agitati per acquistare nuovi territori. Poveri ciechi!... Non sanno che dove non c’è Dio non vi può essere alcuna vera conquista. Nel loro cuore non vi è che malvagità e non fanno che oltraggiarmi, deridermi, disprezzarmi (è il Signore che parla). Sono demoni di discordia, sovvertitori dei popoli e cercano di travolgere nel terribile flagello anche l’Italia, dove sta Dio in mezzo a tante anime e la sede del mio Vicario, Pastor Angelicus. La Francia, tanto cara al mio cuore, per i suoi molti peccati, presto cadrà in rovina e sarà travolta e devastata come Gerusalemme ingrata. All’Italia, perché sede del mio Vicario, ho mandato Benito Mussolini, per salvarla dall’abisso verso il quale si era avviata, altrimenti sarebbe arrivata in condizioni peggiori della Russia. In tanti pericoli l’ho sempre salvato; adesso deve mantenere l’Italia fuori della guerra... Se farà questo avrà favori straordinari e farò inchinare ogni altra Nazione al suo cospetto. Egli invece ha deciso di dichiarare guerra, ma sappia che se non la impedirà, sarà punito dalla mia Giustizia! Tutto questo mi ha detto il Signore ».
• Ora sappiamo che altre «rivelazioni» Suor Elena fece pervenire a Mussolini tramite la signora Edvige. Lo si può dedurre dalle due lettere che qui riportiamo. In data 15 maggio 1943, Suor Elena scriveva: «Gent.ma Signora Edvige, questo mio lungo silenzio Vi avrà fatto forse pensare che mi sia dimenticata di Voi, mentre invece io Vi ricordo tutti i giorni, nelle mie povere preghiere, seguendo sempre le dolorose vicende della nostra bella Italia. Noi ci troviamo fuori Cosenza, a causa dei bombardamenti. La barbarie nemica ha sfogato il suo odio, sganciando bombe sulla città di Cosenza, causando devastazione, dolore e morte fra la popolazione civile. Io mi trovavo a letto con le sofferenze: tre bombe sono cadute vicino al nostro Istituto, ma il Signore ci ha salvato nella sua infinita bontà e misericordia. Per tenere lontane le bambine dal pericolo di nuove incursioni, ci siamo rifugiate a Montalto Uffugo mio paese natio, dove ci troviamo certamente a disagio, ma tutto offriamo al Signore per la salvezza dell’Italia. La ragione di questo mio scritto è per rivolgermi nuovamente a Voi, come nel mese di maggio del 1940, quando venni a Roma presentata dalla Baronessa Ruggì, per consegnarvi in iscritto le rivelazioni avute dal Signore riguardo al Duce. Ricordate quando il 6 maggio 1940 dicevamo che il Duce aveva deciso di fare la guerra, mentre il Signore gli faceva sapere nella mia lettera che doveva salvare l’Italia dalla guerra altrimenti sarebbe stato punito dalla Sua divina Giustizia? In tanti pericoli — diceva Gesù — l’ho sempre salvato; anche lui, adesso, deve salvare l’Italia dal flagello della guerra...». Ah, se il Duce avesse dato ascolto alle parole di Gesù, l’Italia non si sarebbe trovata ora in così tristi condizioni!... «Io penso che il cuore del Duce sarà molto rattristato nel vedere l’Italia, da un giardino fiorito, trasformato in un campo deserto, seminato di dolore e di morte. Ma perché continuare questa guerra terribilmente crudele, se Gesù ha detto che per nessuno vi sarà vera vittoria? Perciò, cara Donna Edvige, dite al Duce, a nome mio, che questo è l’ultimo avviso che il Signore gli manda. Potrà ancora salvarsi mettendo tutto nelle mani del Santo Padre. Se non farà questo — diceva il Signore — presto scenderà su di lui la Giustizia Divina. Anche gli altri Governatori che non ascolteranno gli avvisi e le direttive del mio Vicario saranno raggiunti e puniti dalla mia Giustizia. Vi ricordate il 7 luglio dell’anno scorso quando mi dicevate che cosa ne sarebbe stato del Duce ed io Vi risposi che se non si fosse mantenuto unito al Papa sarebbe finito peggio di Napoleone? Ora Vi ripeto le stesse parole: Se il Duce non salverà l’Italia rimettendosi a quanto dirà e farà il Santo Padre, presto cadrà; anche Bruno dal cielo chiede al padre la salvezza dell’Italia e di lui stesso. Il Signore dice spesso che l’Italia sarà salva per il Papa, vittima espiatrice di questo flagello, perciò non vi sarà altra via per la vera pace e per la salvezza dei popoli, fuori di quella che traccerà il Santo Padre. Cara Donna Edvige, riflettete bene come tutto ciò che ha detto il Signore si sia perfettamente avverato. Chi è che ha causato tanta rovina all’Italia? Non è stato forse il Duce per non aver ascoltato le parole di nostro Signore Gesù Cristo? Ora potrà ancora rimediare facendo quanto vuole il Signore. Io non mancherò di pregare».
• In quello stesso anno, 1943, Suor Elena ebbe un altro incontro con la Signora Edvige; questa ne parla nella seguente lettera, scritta da Roma nel 1950. «Rev.ma Madre, sono passati sette anni dal giorno in cui ebbi l’onore e la gioia di essere da Lei ricevuta nel Convento delle Suore di Malta, Via Iberia, Roma. Da quel giorno non ho mai dimenticato quell’ora santa che passai in Sua compagnia. Le chiesi una grazia che poi ottenni: come avrei potuto dimenticare un incontro con una Santa? Non so dirLe, Rev.ma Madre, quante volte nel mio grande strazio di madre e di sorella abbia pensato a Lei e alle Sue parole profetiche che mi scrisse ai primi tempi della guerra. Nell’aprile del 1945, oltre alla perdita di mio fratello, ebbi quella di mio figlio Giuseppe ventunenne e del marito della mia prima figlia i quali furono tutti assassinati al nord di Italia nello stesso giorno. Rev.ma Madre come io abbia potuto sopravvivere a tanto dolore non lo so, lo saprà il buon Dio dal momento che mi tiene in vita. Come non bastasse tutto questo, la mia vita è un continuo susseguirsi di guai e di preoccupazioni, ora è la volta di una mia figlia ammalta di nome Maria Teresa madre di due bambini, la quale oltre ad essere ammalata si trova in condizioni finanziarie poco buone. Suo marito dovrebbe vincere una causa che gli potrebbe fruttare da vivere discretamente, ma se non ci sarà l’aiuto del nostro Signore e dei Santi sarà difficile gli sia resa giustizia. Ho pure mio figlio Paolo l’unico maschio rimastomi, che nella seconda quindicina di ottobre dovrebbe sostenere gli ultimi due esami per poi laurearsi. Questo mio figlio è stato sei anni fuori corso per i grandi patimenti e sofferenze avute durante e dopo la guerra, quindi anche lo studio ora gli riesce più faticoso. Rev.ma Madre, nelle condizioni in cui si trovano questi miei poveri figli tanto bisognosi di aiuto, mi rivolgo a Lei a mani giunte supplicandoLa di spandere su di essi le sue grazie e le sue benedizioni. Fiduciosa di essere esaudita Le invio devoti saluti unitamente alle Sue Consorelle e con un abbraccio nel Signore mi creda sempre la sua aff.ma Edvige Mancini Mussolini. Roma, Anno Santo 1950».
• L’accenno all’aprile 1945 tocca «i fasti della resistenza e della liberazione»; dovrebbe far riflettere e rinsavire tanti forsennati e sciocchi ripetitori. Seppellire nell’oblio, se non deplorare e condannare, le nefandezze e tante atrocità, dovrebbe essere il dovere di un popolo civile, il trionfo almeno del buon senso, se non del sentimento cristiano. Nel 1942 Suor Elena in una lettera preannunziava con esattezza la circostanza che avrebbe segnato la conclusione della guerra: «Ci sarà un fuoco mai visto e allora finirà la guerra». Quando gli Americani sganciarono la bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, compresi cosa significasse quel «fuoco mai visto» e rilevai la rispondenza tra predizione e realizzazione.
• Un fatto straordinario, tuttora constatabile, è inoltre intervenuto quasi ad autentificare la natura soprannaturale dei fenomeni mistici e a dare quindi il suggello alle rivelazioni profetiche della «monaca santa»: il pannello di masonite sito accanto al suo letto, esattamente nel riquadro rispondente ai cuscini, ha essudato sangue, dal 29 settembre 1960 al giugno 1961; e tuttora vi è visibilissimo il sangue aggrumato che delinea l’effigie di un Cristo sofferente. Su quel riquadro durante i fenomeni mistici erano schizzate dal volto della stigmatizzata alcune gocce di sangue. Da quelle gocce disseccate ad un dato momento si vide scorrere il sangue. Ebbe così inizio questo fenomeno assolutamente inspiegabile. Era il 29 settembre 1955, festa di san Michele Arcangelo, protettore dell’Ordine dei Minimi: Suor Elena gli aveva rivolto fervide preghiere invocandone la protezione e la assistenza. Il fenomeno si è ripetuto ordinariamente in rispondenza a solennità che celebrano le sofferenze del Redentore e della Vergine sua Madre. Il legno venne energicamente lavato, ma il fenomeno è ricominciato; la fotografia riprende nitidamente l’effigie, che nonostante tutto vi permane; mentre l’analisi chimica ha rilevato trattarsi precisamente di sangue e di sangue umano. La biografia conclude riportando un messaggio dell’8 dicembre 1956, il solo, quasi esempio, da essa riferito: «Vengono, con spontaneità, in mente le lacrime della Madonna di Siracusa. Non siamo noi i giudici di fatti che umanamente non si spiegano, basti averli controllati e averne constatato l’esistenza. È naturale che ci si chieda il significato di un tale fenomeno... Forse la risposta è offerta da un povero e semplice foglio di carta che ho qui tra le mani... Eccone le frasi più salienti: Gli uomini offendono troppo Dio. Il mondo è tutto sconvolto perché è diventato peggiore che ai tempi del diluvio. Il materialismo avanza e continua la sua marcia segnata di sangue, di lotte fratricide... Tutte le nazioni saranno punite perché molti sono i peccati che, come una marea di fango, hanno ricoperto la terra. Le forze del male sono preparate a scatenarsi in ogni parte del mondo, con aspra violenza. Tremendo sarà lo sconvolgimento per quello che avverrà. Già da tempo, ho avvisato gli uomini, in tanti modi. I Governatori dei popoli avvertono il pericolo gravissimo; ma non vogliono riconoscere che, per evitare il flagello, è necessario far ritornare la società ad una vita veramente cristiana. Il tempo non è lontano e tutto il mondo sarà sconvolto. Molto sangue sarà versato: di giusti, di innocenti, di santi sacerdoti, e la Chiesa soffrirà molto. L’odio arriverà al colmo. L’Italia sarà umiliata, purificata nel sangue, e dovrà molto soffrire, perché molti sono i peccati in questa nazione prediletta, sede del Vicario di Cristo. Non puoi immaginare quello che accadrà! Si svilupperà una grande rivoluzione e le vie saranno arrossate di sangue. Il Papa soffrirà molto e tutto questo soffrire sarà per lui come un’agonia che abbrevierà il suo pellegrinaggio terreno. Il suo Successore guiderà la nave nella tempesta. Ma non tarderà la punizione degli empi. Quel giorno sarà spaventoso, nel modo più orribile: la terra tremerà e scuoterà tutta l’umanità. I malvagi periranno nei tremendi rigori della giustizia di Dio. Lanciate un messaggio per avvisare subito, possibilmente, tutti gli uomini della terra, perché ritornino a Dio con preghiere e penitenze».
• Prosegue: «Il messaggio, chè come tale si presenta, è dell’8 dicembre 1956. È normale — continua la biografia — la connessione tra delitto e castigo; normale il riferimento alla divina Giustizia, per le ricorrenti sciagure umane; normale il riconoscimento della lotta perenne tra la città di Dio e la città di Satana, con la periodica, ma effimera prevalenza delle forze del male. Lascio al lettore le considerazioni, sul giudizio amaro circa lo stato religioso e morale dei nostri tempi (e l’autore scriveva nel 1963-64!), sull’avanzare del materialismo ateo e sul suo vero volto, sui suoi scopi: alla Ungheria recente, si abbini la Spagna 1936, dove il terrore rosso, con le sue stragi di sacerdoti e Suore, si preparò e prevalse all’ombra di un governo “cattolico”, presidente Gil Robles! Il sangue scorrente dal pannello di legno, l’effigie su di esso delineatasi, erano certo un segno, una testimonianza dati dall’alto a conferma della vita e dell’Opera di Suor Elena Aiello. E un ammonimento per noi. Il messaggio e il pannello fan parte di una serie di fatti e comunicazioni debitamente controllati: il materiale che si è riusciti a raccogliere con paziente ricerca ci permetterà di illustrare nei particolari gli accenni contenuti nel messaggio riportato e lo stesso segreto di Fatima». Prosegue ...
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, Angelo Brucculeri S.J. - «Moralità della guerra», per La Civiltà Cattolica, Roma, 1953 - ci ricorda la sentenza di Cicerone che, con la sua fastosa eloquenza, illustra il principio su cui si regge la sana concezione del diritto di guerra: «È questa una legge non scritta, ma naturale, che noi non abbiamo imparato, ricevuta o letta; ad essa non siamo stati istruiti, ma fatti; non addestrati ma impregnati; e dice questa legge che se noi ci trovassimo nella necessità di salvare la nostra vita da agguati, dalla violenza o dalle armi di briganti o di nemici, potremmo difenderla con ogni mezzo onesto. E questa la ragione ha insegnato ai colti, il bisogno ai barbari, la consuetudine ai popoli e la stessa natura agli animali: l’allontanare dalla loro vita con qualunque mezzo ogni violenza, dalla testa, dal corpo, dalla vita».
• Se è diritto dell’individuo, con le dovute riserve, vim vi repellere, anche l’individuo collettivo, la società politica, deve avere lo stesso diritto di attendere alla propria conservazione e tutelarla, se necessario, con la forza. Ma non solo è permessa la guerra, allorché si subisce, per dir così, a causa d’una ingiustificata aggressione; ma anche allorché si tratta di riparare un essenziale diritto disconosciuto e violato, o di recuperare dei beni iniquamente usurpati, o di punire dei gravi crimini perpetrati a proprio danno. In altri termini, non solo è legittima la guerra difensiva, ma anche quella offensiva. Lo Stato, infatti, ha la sua ragione di essere per il bene comune, ossia ha per suo specifico compito la tutela e la promozione di tutto quel complesso di condizioni che assicurano la prosperità materiale e morale della collettività nell’ordine temporale.
• Orbene questa meta non si può raggiungere con la sola resistenza contro le invasioni della disonesta violenza, ma domanda altresì la riparazione d’ogni altro essenziale diritto che venga ostinatamente violato da nazioni ostili (Francisci de Vitoria, Relectiones theologicae, XII, Lione 1557, De iure belli, I, p. 383). Contro quest’atteggiamento del lecito appello alle armi da parte del potere politico si sollevano delle obiezioni.
• Abbiamo già mostrato nei numeri precedenti (244 e 245) la fallacia di alcune di esse, tratte da qualche testo scritturale o dalla storia. Ora, prima di procedere più oltre, vogliamo rapidamente esaminarne qualche altra che parrebbe fondarsi sulla ragione. Non è lecito, protestano soprattutto i pacifisti estremi, che per ovviare ai mali si ricorra ad un mezzo che serve a moltiplicarli. Servirsi delle stragi di tanti innocenti per il trionfo della giustizia, significa ammettere l’immorale principio del fine che giustifica i mezzi. Nessun dubbio che questo principio machiavellico debba assolutamente ripudiarsi; ma esso, nel nostro caso, è un fuori di luogo. Chi, con la forza e nelle dovute condizioni, difende o restaura il diritto, questi non compie un gesto in se stesso disonesto. Se egli colpisce degli innocenti, ciò avviene indirettamente, casualmente, praeter intentionem agentis. Come non operano immoralmente gli agenti della polizia, che per far capitolare un pugno di masnadieri annidati in un castello, lo assediano, o se è necessario, lo abbattono, sebbene vengano colpiti gli innocenti che vi si possono trovare; così anche gli eserciti d’uno Stato che difendono una giusta causa non perpetrano un delitto, se la loro azione risulti in grave danno degli innocenti.
• È un principio, che non può revocarsi in dubbio, che è sempre lecito, allorché si ha un’adeguata ragione giustificatrice, porre una causa dalla quale possano seguire due effetti paralleli : benefico l’uno e l’altro malefico, purché non si abbia altro di mira che il buon effetto. Se il diritto non potesse adoperare la forza, sia pure col danno inevitabile degli incolpevoli, si spianerebbe la via al trionfo dei tristi, al disordine, all’anarchia; donde gravissimi danni per la società, non esclusi gli innocenti, che si vorrebbero sottrarre ai mali della guerra. Inoltre, diremo col Del Munnynck, «nel mondo materiale il male non consiste nella distruzione di un qualsiasi essere - ne distruggiamo tanti degli esseri per la nostra conservazione - ma nella distruzione che provoca una diminuzione del valore totale. L’iconoclasta che brucia le opere d’arte per riscaldare il suo pasto, è ignobile e criminale, perché distrugge il valore spirituale della bellezza per il piacere sensibile di mangiare la pietanza calda. Ma lo scultore che abbatte un albero per trarne un capolavoro, fa bene, perché l’albero non vive che a causa della materia, e la statua, concretizzando il pensiero dell’artista, ci farà vivere con lo spirito. La distruzione di cause materiali che non hanno altro intento che procurare la giustizia, non è un male, perché il regno della giustizia, che è un diritto divino, costituisce per l’umanità e il regno di Dio, un valore infinitamente superiore alla vita materiale di individui effimeri. Resistendo con la forza all’ingiustizia, non facciamo il male, ed è perfettamente assurdo gettare in faccia agli Stati, difensori con la guerra della giustizia, l’ingiuria abominevole, di giustificare i mezzi col fine» [Opinions catholiques sur la limitation et la réduction des armements, Juvisy 1932, pp. 12-13. (Extrait des Documents de la Vie intellectuelle)].
• La guerra, dunque, può essere permessa ed avere un suo valore etico; ma quali ne sono le condizioni? San Tommaso, come accennammo innanzi, ne ammette tre soltanto (Summ. theol. II-II, q. 40, a. 1), altri arrivano fino a dieci (Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, op. cit. nei precedenti numeri, pp. 103-104). Noi le riduciamo a cinque: Auctoritas principis, iusta causa, intentio recta, iustus modus, ultima ratio. Su ciascuna di esse c’intratterremo brevemente.
• Auctoritas principis. La prima condizione è inerente al carattere pubblico della guerra. Solo il potere sovrano ha diritto di dichiarare lo stato di guerra come di sospenderlo con la conclusione della pace. «L’ordine naturale che vuole la pace fra gli uomini, scrive Sant’Agostino, richiede che il potere di intimare e condurre a termine la guerra, appartenga al principe; mentre i militari hanno il dovere di eseguire gli ordini, che sono loro imposti nell’interesse della pace e della salvezza di tutti» (Contra Faustum, lib. XXII, cap. 75: Migne, P. L. 42, 448). Nel medio evo, dato il regime feudale, potevano sorgere dei dubbi sull’autorità cui spettava il diritto di guerra. Di fatto all’imperatore cui era devoluto questo diritto o a quei monarchi, come i re di Francia e d’Inghilterra, che nelle proprie nazioni esercitavano la piena sovranità. Ma a ragione osserva il Taparelli: «Non è sempre necessario che l’autorità sia onninamente indipendente; basta che sia tale che, mancandole ogni ricorso, non possa se non colle armi sostenere il proprio diritto; il che può succedere sì per non curanza, sì per impotenza della suprema autorità ordinatrice nell’aggregazione di molte società uguali. Queste guerre dunque fra società non totalmente indipendenti sono proprie di un incivilimento appena abbozzato, e debbono cessare a proporzione che la civiltà progredisce» (Saggio teoretico di dritto naturale, n. 1322).Oggi, con la formazione dei grandi Stati, non presenta alcuna difficoltà la determinazione del soggetto internazionale dotato della capacità giuridica di intraprendere la guerra e concludere a suo tempo la pace. Nello Stato federale (come negli Stati Uniti) gli Stati membri non hanno questa capacità, ma la Federazione soltanto può avere rapporti bellici con altri Stati. Nelle Confederazioni invece (come quella della Germania del 1815) gli Stati membri conservavano la piena autonomia anche sul diritto di guerra. L’evoluzione del diritto internazionale, dopo la guerra mondiale del 1914, si volse a moderare la sovranità statale intorno all’esercizio del diritto di guerra. Così i membri della Società delle nazioni si sottoposero a serie limitazioni circa l’uso di questo diritto (Cfr Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, op. cit. nei precedenti numeri, p. 61 e ss).
• Iusta causa. Non è una causa sufficiente per legittimare una guerra il progressivo sviluppo di un popolo (anche se confinante) considerato quale non lontano pericolo di predominio. La guerra insomma preventiva, non è lecita, benché il Montesquieu pensi di poterla giustificare (Esprit des lois, lib. 10, cap. 2). Le ragioni sono ovvie. Primieramente perché l’ordine internazionale sarebbe di continuo in pericolo di frantumarsi, giacché variano frequentemente i rapporti di forza e di potere fra gli Stati. Si apre inoltre la via ad abusi e ad arbìtri d’ogni sorta. Soprattutto la guerra preventiva è illecita, perché il pericolo che d’ordinario crea una nazione progrediente è probabile, ma questa probabilità è un titolo incerto, che viene colliso dal titolo, non dubbio ma evidentissimo, che obbliga i popoli alla mutua benevolenza (Taparelli D’Azeglio, Saggio teoretico di dritto naturale, n. 1339). «Se la causa della guerra, scrive il Grazio, è d’altronde giusta, sarà anche da saggio e prudente intraprenderla, se avrà per risultato d’indebolire un vicino potente. Ma che la possibilità d’una violenza dia diritto alla violenza, ripugna ciò all’equità e alla giustizia. Tuttavia la vita umana non si svolge mai nella piena sicurezza. Dalla divina Provvidenza adversus incertos metus et ab innoxia precautione (cautele politiche, economiche, militari) non a vi praesidium petendum est» (De iure belli ac pacis, lib. I, cap. I, XVII). «Soltanto una minaccia manifesta ed imminente, insegna il Codice di morale internazionale di Malines, come politica sistematicamente aggressiva, concentrazione insolita di truppe ecc., può autorizzare lo Stato, che per tutto ciò si stima leso nella sua sicurezza, di esigere la cessazione dei sospetti procedimenti e, in caso di rifiuto, di imporla con la forza» (Codice di Morale Internazionale, Roma s.a., n. 152). Non è pure una giusta causa il prestigio del sovrano, perché non il bene particolare del singolo ma il bene della comunità può giustificare l’attività bellica, come qualsiasi altra attività dello Stato. Come non sarebbe una giusta causa il semplice motivo di espansione territoriale, giacché non è lecita la conquista dell’utile proprio col danno degli altri. Le guerre mosse dalla cupidigia, dice Sant’Agostino, quid aliud sunt quam grande latrocinium? (De Civitate Dei, lib. IV, cap. 1: Migne, P.L. 41, 117). E nemmeno è una giusta causa il mutuo e tacito consenso delle parti belligeranti, che convengono di affidare alla sorte delle armi la soluzione del loro litigio. « I due belligeranti, diremo col p. Yves de la Brière, sarebbero così d’accordo per ammettere che la questione si troverebbe normalmente sciolta a vantaggio del vincitore e che le nuove situazioni sarebbero validamente giustificate per il diritto di guerra e di vittoria» (Le droit de juste guerre, op. cit., pp. 78-79).
• Questa teoria è meritamente respinta, 1) Perché, se nel caso la guerra non viola la giustizia commutativa (il vinto ha in antecedenza rinunziato alla riparazione dei torti) viola l’ordine e lede il bene comune della società statale ed internazionale. 2) Include il supposto che la guerra sia mezzo razionale e normale di sciogliere i problemi della giustizia e del diritto. Ora la forza è assolutamente un fuori di luogo, ma la ragione soltanto può affrontare questi problemi. La ragione in tali casi, se si presentano incerti e dubbi e non si vede dove stia il diritto, ricorre ad un espediente che non sia malefico, come l’arbitrato, la composizione amichevole, la sorte e simili mezzi. 3) Contiene l’intrinseca illiceità del duello. Oggi si parla di spazio vitale quale causa di guerra. Se s’intende per diritto allo spazio vitale il diritto alla vita, sebbene legittimo che questo diritto non può essere invocato contro l’identico diritto che altri hanno alla vita ed all’esistenza: può solo valere collidendo col diritto inferiore degli altri. Per esempio il diritto di proprietà è inferiore al diritto alla vita, quindi l’occupazione o l’invasione di una terra disabitata o pressoché disabitata per parte di un popolo che non può più essere contenuto nel proprio territorio a causa della saturazione demografica, è lecita. [Qui ci sarebbero molte precisazioni da fare].
• Per giusta causa si deve intendere la contestazione pervicace e la violazione di un diritto di sommo rilievo, e che intanto non si vuole affatto riparare. Il diritto all’esistenza, alla libertà, al proprio territorio, ai propri beni, al proprio onore possono essere, se lesi, valido motivo di guerra. Col Vitoria ed altri a lui posteriori, si è estesa la sfera dei diritti che possono essere difesi o promossi con la forza. E ciò in base alla concezione di una naturale società universale dei popoli. Così, per esempio, i diritti di commercio e di soggiorno in dati casi potrebbero legittimare il ricorso alle armi. La causa, inoltre, per essere giusta deve proporzionarsi ai gravi mali che si affrontano nella guerra. Si noti che una causa oggettivamente non grave, per la persistenza nel diniego d’ogni riparazione e l’atteggiamento sprezzante dell’offensore possono via via ledere così l’onore nazionale da costituire una causa grave. Questa proporzione è specialmente richiesta nella guerra che non ha un carattere punitivo, ma che ha un semplice scopo di riparare la violazione del diritto senza alcuna colpa morale.
• La causa deve essere certa. Nel dubbio non si può ragionevolmente infliggere agli altri un danno certo, quale è quello che è prodotto dalla guerra. Ci deve anche essere fondata speranza che i vantaggi prevarranno sui danni. «Il giusto belligerante, leggiamo nel Codice di Morale Internazionale, calcolando i legittimi vantaggi, che dalla guerra si attende e i danni d’ogni sorta che immancabilmente ne derivano, deve mettere in conto il grave peso delle sofferenze e delle rovine che il conflitto imporrà alle altre nazioni, a quelle di cui sconta il concorso armato, come alle neutrali che avranno a subire le dolorose ripercussioni della lotta. Questo confronto rivelerà forse una tale disproporzione fra il bene che varrà la vittoria e il prezzo a cui tutta l’umanità dovrà pagarlo, che la carità farà un dovere di rinunziare alla giusta riparazione ch’egli domanda, anziché esporre il mondo ad una spaventosa catastrofe» (Codice di Morale Internazionale, op. cit., art. 160). D’altronde la sproporzione delle forze non crea sempre l’obbligo alla parte più debole di cedere all’ingiustizia del più forte e prepotente. Anche la probabilità d’una disfatta, quando si tratta di difendere i valori superiori, come la fede giurata, la religione e simili, non deve agevolmente esimere dall’eroismo e dal martirio, che attraverso i secoli costituiscono per l’umanità una sorgiva di nobili aspirazioni, un lievito di ascensioni morali, un capitale vistosissimo che fruttifica attraverso i secoli e le generazioni.
• Un problema connesso con la questione della giusta causa della guerra è il problema della colpabilità morale, che, a parere di alcuni, si richiederebbe per giustificare l’uso della forza. È evidente che si può talora violare un diritto, essendo però in buona fede. In questo caso la coscienza è erronea, ma non lascia di esser retta, ossia immune di colpabilità soggettiva. I teologi, i canonisti e i moralisti sono concordi nell’ammettere che per giustificare la guerra, basta la sola colpa giuridica, la violazione oggettiva, materiale, estrinseca del diritto. Se così non fosse, se cioè si richiedesse la colpa morale, la restaurazione dell’ordine e la riparazione dei torti in troppi casi non potrebbero effettuarsi, perché non sarebbe assai spesso possibile accertare la colpabilità morale. In genere i belligeranti credono di non essere affatto colpevoli, e si battono in buona fede. La guerra, dunque, non è essenzialmente punitiva, ma restauratrice dell’ordine obiettivo.
• Ultima ratio. I rapporti degli Stati sono essenzialmente morali e giuridici; la forza non può sostituirsi alla disciplina del diritto se non nel caso estremo, in cui questa sia resa impossibile dal fallimento d’ogni via di pacifico componimento. È sempre ingiusta una guerra, se chi l’intraprende, pur essendo il buon diritto dalla sua parte, non abbia fatto ricorso ai mezzi pacifici di soluzione. «La diplomazia è definita la scienza della costituzione sociale e politica degli Stati e l’arte di conciliarne i diritti, i doveri e gli interessi. È vero purtroppo, che per molti è l’arte di cucire la pelle della volpe con quella del leone, quando questa è troppo corta» Hoijer, La solution pacifique des litiges internationeaux, Parigi 1935, pp. 3-4). Questi mezzi pacifici di soluzione sono: 1) Le negoziazioni dirette fra i contendenti, che si svolgono per via della diplomazia. Se veramente si vuole la pace non è malagevole con la chiarificazione dei propri punti di vista e con le reciproche concessioni di raggiungere l’accordo. 2) I buoni uffici, ossia i passi di una terza potenza che si offre alle parti in conflitto per spianare loro la via alle negoziazioni dirette o a riannodarle se interrotte. 3) La mediazione, che è il procedimento con cui una terza potenza, mediante la persuasione o l’ascendente morale, agevola l’accordo con l’attuazione delle richieste o per via di compromessi (La mediazione può essere singolare o collettiva. Può talora dispiegare una pressione illegittima, perché animata da calcoli interessati). 4) L’arbitrato, che è una forma giudiziaria di risoluzione vera e propria, mentre gli altri modi sono vie che conducono alla soluzione. 5) Le commissioni d’inchiesta internazionale, le quali dovendo fare delle indagini, mentre da una parte, mediante persone imparziali mirano a far luce sui fatti, dall’altra parte guadagnano del tempo che tanto giova a moderare le divampanti passioni. È un’istituzione sorta con la prima conferenza dell’Aia. 6) Potremmo in fine aggiungere la Società delle nazioni e l’O.N.U., le quali, sebbene non abbiano fatto buona prova, erano sorte coll’intento di ostacolare al possibile le guerre fra le nazioni e adoperarsi a mantenere fra loro la concordia e la cooperazione internazionale. PS: Quando le società erano civili, abitualmente i sovrani ricorrevano ai Pontefici per la possibile soluzione delle controversie.
• Intentio recta. Essendo la guerra attività morale, come qualsiasi azione morale deve giustificarsi dal suo oggetto e dalle sue circostanze, fra le quali primeggia quella del fine. «È necessario, scrive San Tommaso, che l’intenzione dei belligeranti sia retta, ossia che abbiano per mèta di fare il bene e schivare il male... e quindi può avvenire che la guerra sia stata giustamente dichiarata dalla competente autorità, ed essere frattanto illecita a causa della perversità degli intenti di coloro che l’intraprendono. Il desiderio di nuocere, la crudeltà nella vendetta, un animo spietato e nemico della pace, il furore nelle rappresaglie, la passione del dominio e sentimenti congeneri, ecco ciò che deve essere meritamente riprovato nella guerra» (Summ. theol., II-II, q. 40, a. 1).
• Notiamo che tanto la recta intentio quanto il modus iustus, non appartengono al ius ad bellum, ma al ius in bello, ossia al diritto che si esercita nella condotta della guerra. In altri termini, l’intenzione può rendere ingiusta la guerra dal punto di vista soggettivo e morale; mentre dal punto di vista oggettivo e giuridico è incriminabile. Così, per esempio, il punire con la guerra una violazione del diritto può accompagnarsi col desiderio di sfogare l’odio e di soddisfare la propria avarizia coi beni del nemico. «La perversa intenzione, scrive il Caietano, rende la guerra riprovevole, così come nel caso della giusta punizione d’un ladrone, la quale diviene riprovevole, se vi si esercita la giustizia ma per odio... Non si dà luogo quindi a restituzione, giacché il ladro o il belligerante vinto subiscono a giusto titolo la condanna, benché nell’intenzione del giustiziere vi sia della malizia, poiché egli nella sua coscienza non ha voluto compiere il giusto in una giusta forma» (Summa Cajetani, Venetiis 1571, p. 26).
• Iustus modus. Nella guerra l’uso della violenza (o meglio: della forza) deve essere diretto a distruggere le forze armate del paese. Tutto ciò che non serve a questo scopo, ma solo allo sfogo dell’odio e della brutalità deve essere omesso. Tutto ciò che non è richiesto per la propria difesa, per la riparazione dei torti, per la rivendicazione del diritto è illecito. C’è chi pensa che la violenza nella guerra non deve aver alcun limite, ma deve tendere all’intensificazione assoluta. Il volere umanizzare la guerra sarebbe un procedimento assurdo, che si risolve nel protrarla a lungo. Queste affermazioni di filosofia bellica non reggono all’analisi. L’uomo, anche quando impugna le armi in difesa della giustizia, non cessa di essere uomo, ossia un essere razionale, sottoposto sempre all’esigenze dell’etica, che importano la conformità con la natura razionale. Perché, dunque, sia retta la condotta della guerra, non bisogna distruggere per distruggere, non bisogna compiere ciò che è intrinsecamente disonesto, come l’uccisione diretta dei cittadini innocenti, la violazione del giuramento, la calunnia. Certamente sarà permessa la rappresaglia, badando alla norma che la violazione del diritto di una parte belligerante non autorizza l’altra parte a violare qualunque diritto e a ricadere nella barbarie (Cfr. Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, op. cit., p. 135).
• In secondo luogo bisogna uniformarsi alle consuetudini e alle convenzioni bilaterali o internazionali che sono state accolte nel diritto delle genti. Fra queste norme vanno segnalate quelle dell’Aia del 1907 per le quali «i belligeranti non hanno una facoltà illimitata nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico. Questa stessa Conferenza del 1907 interdice all’articolo 23 del Regolamento: a) l’adoperare veleni o armi avvelenate; b) l’uccidere o ferire per tradimento gl’individui appartenenti alla nazione o all’armata nemica; c) l’uccidere o ferire un nemico che ha lasciato le armi o si è arreso, a discrezione, non avendo più mezzi per difendersi; d) il dichiarare di non dar quartiere; e) l’impiegare armi, proiettili e materie proprie a causare mali superflui; f) l’usare indebitamente delle bandiere parlamentari, o la bandiera nazionale o l’insegne militari e l’uniforme del nemico, o i segni distintivi della Convenzione di Ginevra (Croce Rossa); g) l’appropriarsi o distruggere delle possessioni nemiche, a meno che non sia ciò imposto da necessità belliche; h) il dichiarare estinti o sospesi o non validi i diritti e le azioni dei nazionali della parte avversaria; i) costringere i nazionali della parte avversaria a prendere parte alle operazioni di guerra dirette contro il proprio paese.
• Rispetto ai prigionieri è prescritto, da questa stessa conferenza, che non possono essere uccisi. Importante è poi la distinzione fra combattenti e non combattenti, sebbene oggi si presti a gravi difficoltà, giacché nella guerra odierna, così eminentemente industriale, pressoché tutta la popolazione attiva prende parte alla guerra, né può dirsi del tutto inoffensiva. Ad ogni modo essa deve essere, per quanto è possibile, al riparo delle violenze dirette causate dalla guerra. Oramai è permesso al giusto belligerante d’attaccare l’avversario sul punto vivo dell’apparecchio economico: officine militari, ferrovie, porti, fonti di materie prime, ecc. Si ammetterà altresì di esercitare col blocco una graduale pressione che finirà col ridurlo a chiedere la pace. L’arma del blocco non pare che possa vietarsi, giacché essa non diviene micidiale che per la tenacità della popolazione assediata, che si sottopone alle più gravi privazioni piutto-stoché capitolare (Codice di Morale Internazionale, op. cit., art. 172).
• La guerra lungo i secoli ha subito necessariamente una continua evoluzione. Nel paganesimo le guerre avevano sempre un carattere di brutalità che ripugna alla coscienza cristiana. Nessuna limitazione alla violenza, nessuna norma che temperasse la ferocia di uccidere, anche senza una esigenza militare. I feriti, i prigionieri, i cittadini non combattenti potevano essere sgozzati o venduti schiavi. Paolo Emilio vende come schiavi centomila epiroti che si erano arresi volontariamente. È ben noto lo sterminio di Cartagine, di Gerusalemme e di tante altre città compiuto dai Romani. Con la strage degli uomini vi era anche la strage delle cose: città, messi, patrimonio zoologico, tutto veniva distrutto. «Con questo diritto di guerra, scrive Fustel de Coulanges, Roma estese la solitudine attorno a sé » (La cité antique, Parigi 1905, p. 244).
• Con l’avvento del cristianesimo e il suo trionfo nella coscienza pubblica anche la guerra subisce delle mitigazioni non lievi. Nel medioevo, per quanto frequenti, le guerre erano assai ristrette nel tempo, e gli effetti assai limitati. I combattenti sono volontari e poco numerosi. L’urto bellico avveniva per lo più nelle frontiere, e la vita della nazione non veniva nel suo complesso profondamente alterata. Con la rivoluzione francese si pone fine alle guerre dinastiche e s’inizia un’evoluzione della guerra che ne accentua sempre più l’asprezza e i danni. Essa infatti assume un carattere nazionale, ed è rivolta alla difesa della patria. L’elemento “morale” costituito dal patriottismo rende la guerra più disastrosa. S’introduce la leva obbligatoria che diviene pressoché generale nelle principali nazioni d’Europa. Oggi, coi progressi enormi della tecnica, le devastazioni, le morti, le distruzioni e tutti i mali inerenti alla guerra si sono centuplicati.
• Oltre al carattere nazionale oggi essa assume il carattere totalitario, giacché assorbe tutte le energie della nazione e la totalità dei suoi membri adulti. «Oggi (disse il generale Pétain nel discorso della sua ammissione all’accademia di Francia) a causa dello sviluppo dei mezzi di trasporto, le risorse nazionali integralmente mobilitate possono affluire con rapidità e rinnovare di continuo le masse armate. I trionfi, dunque, sono passeggeri; lo sfruttamento della vittoria si arresta non appena l’avversario ha potuto condurre in campo nuove forze. Perché il successo sia definitivo, bisogna impedire quest’afflusso di forze ed essiccarne la sorgente. Ormai il fine della guerra appare in tutta la sua ampiezza: esso è divenuto la distruzione non d’una armata, ma d’una nazione» [Paix et Guerre, Parigi s.a., p. 68 (La Vie intellectuelle - Les documents)].
• Al tempo stesso coinvolge per lo più le altre nazioni. La guerra del 1914, come quella del 1939 ne sono la prova. Queste considerazioni hanno indotto alcuni studiosi cattolici moderni a domandarsi: se non debba subire una revisione (ove possibile) la dottrina cristiana della guerra, soprattutto se possa più al presente parlarsi (secondo i più audaci) della sua liceità. Che cosa dobbiamo pensare su ciò? Prima di tutto notiamo che non possono non ammettersi alcune critiche, mosse alla concezione cristiana tradizionale, quale l’abbiamo esposta, intorno alla guerra. Queste critiche fanno capo a tre punti. Primieramente l’invalidità del criterio per giudicare se sia o no lecita la guerra. Questo criterio è la coscienza del sovrano o di coloro che hanno il potere supremo, ossia il giudizio è affidato alla parte interessata. Ma nemo iudex in causa propria. E se ciò è necessario per l’individuo, non è meno necessario per lo Stato in cui convergono interessi e passioni d’una portata incalcolabile. Chi può dubitare dell’accecamento a cui può condurre il patriottismo, l’egoismo accentratore, l’orgoglio ferito, la bramosia di predomio? Dove è mai quel popolo o quel sovrano che abbia mai riconosciuto il suo errore o la sua colpabilità nell’intraprendere una guerra? Vitoria (De iure belli, 21, p. 396) e Suarez (De charitate, disputatio XIII, De bello, sectio VI) hanno rilevato questo inconveniente; perciò il primo suggerisce al principe di consigliarsi coi savi e i dotti; il secondo ammetterebbe la soluzione di un neutrale, quale il Papa.
• In secondo luogo l’incertezza dell’esito, giacché affidarsi alle armi per far trionfare la giustizia, importa affidarsi ad un processo aleatorio, in cui non sempre il giusto e l’onesto trionfa, ma l’ingiusto e colpevole. Che anzi ha più probabilità di trionfo colui che ha violato il diritto, giacché se è stato così audace a violare il diritto, è stato a causa del prepotere delle sue forze che gli assicuravano il trionfo sulle reazioni che avrebbe sollevato il suo gesto criminale. In terzo luogo la precarietà della pace. Essendo il vincitore che l’impone, ossia la parte interessata, non è certo raro il caso che s’impongano ingiuste riparazioni e indebite sanzioni; anche quando il vincitore sia il giusto belligerante. E allora il vinto mal sopporta la pace e cercherà di rifarsi e scuotere il giogo non appena avrà qualche probabilità di vittoria.
• In quarto luogo la relatività che presenta la dottrina in questione, in quanto che una tale dottrina è stata accomodata allo stato inorganico dell’odierna comunità internazionale. La sua giustificazione ha dunque un valore ipotetico e condizionale proprio delle circostanze anarchiche della società umana universale. In uno stadio più evoluto e giuridicamente organizzato della naturale famiglia dei popoli, non potrebbe sussistere. «La comunità internazionale, scrive il p. Yves de la Brière, da molti secoli, somiglia, nei rapporti fra le potenze, ad un grande paese che non possiede né polizia, né tribunali, né sistemi di repressione penale. Per difendersi contro i delinquenti e per toglier loro la libertà di nuocere con nuove stragi e grassazioni non resterebbe altro partito ai gruppi particolari che ad organizzarsi ed armarsi contro le bande dei briganti e degli ingiusti aggressori... Sarebbe quindi la giustizia privata il sistema nel quale - a causa dell’assenza di una tutela organica e generale per la sicurezza comune, - ciascun membro della comunità farebbe del suo meglio per difendere coi suoi mezzi il proprio diritto. Stato di cose rudimentale e turgido di danni ed inconvenienti enormi, che non si giustifica e non si scusa che per la mancanza di guarentigie più razionali, più efficaci e migliori. È l’infanzia dell’arte in materia della protezione della giustizia e di guarentigia sociale per la tutela del diritto. Tale è il caso del sistema della giusta guerra. È conforme alla morale e al diritto a causa della deficienza di migliori garanzie e per evitare l’immunità ad abusi peggiori e più perniciosi. Si ha dunque una giustificazione condizionata, ipotetica, valevole solo per la mancanza di un sistema internazionale con cui sia razionalmente organizzata e protetta la giustizia fra gli Stati» (Le droit de juste guerre, op. cit., pp. 176-177). Ovvero: stando così le cose, la guerra giusta è conforme alla morale e al diritto. Questa l’opinione del p. Yves de la Brière.
• Se quest’atteggiamento moderatamente critico sull’insegnamento tradizionale intorno alla guerra può valutarsi, non tutti certamente consentiranno a quell’altro atteggiamento di pensiero, con cui si afferma che al presente la guerra è sempre illecita. Il 19 ottobre del 1931 alcuni teologi di varie nazioni, in una consultazione tenutasi a Friburgo (Svizzera) vennero alla seguente conclusione: «La guerra moderna non potrebbe essere una procedura legittima. Giacché essa, a causa della sua tecnica e per una tal quale necessità inerente alla sua natura, genera sì grandi rovine materiali, spirituali, individuali, familiari, sociali, religiose, e diviene una tale calamità mondiale, ch’essa cessa di essere un mezzo proporzionato al fine (che solo potrebbe eventualmente giustificare l’impiego della forza) ossia: l’instaurazione d’un ordine più umano e la pace» (Paix et guerre, op. cit., pp. 41-43).
• Secondo questi teologi parrebbe la guerra moderna sempre illecita. Che cosa si deve rispondere? Notiamo anzitutto che cosa pensano alcuni eminenti studiosi su questo problema. Il p. Regout, dopo d’aver citato le conclusioni dei menzionati teologi, scrive: «Se con queste proposizioni si vuole intendere che lo scoppio d’una guerra non può giammai esser lecito ai nostri giorni, anche dopo il fallimento dei mezzi pacifici e nel caso della peggiore delle ingiustizie, non potremmo per nostra parte sottoscrivere ad una tesi così assoluta (e assurda, ndr.)». Anche il Leclercq respinge la tesi assoluta dell’illiceità della guerra moderna: «Nella civiltà presente, egli scrive, è ancora concepibile che uno Stato sia obbligato ad una giusta guerra, fosse pure una guerra di sterminio. I casi d’una giusta guerra possono essere meno numerosi di altre volte, soprattutto i casi di guerra offensiva giusta non si concepiscono che assai difficilmente, ma basta che resti la possibilità d’una qualche guerra giusta, perché lo Stato debba mettersi in condizione di far fronte eventualmente ad essa».
... prosegue la prossima settimana ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci eravamo salutati studiando l'approfondimento di Angelo Brucculeri S.J., «Moralità della guerra», per La Civiltà Cattolica, Roma, 1953. Riprendiamo il nostro percorso formativo dal capitolo secondo: «La necessità della guerra».
• Il primo problema, che s’impone al filosofo intorno alla guerra, è il suo rapporto con l’etica. È sottoposto l’evento bellico a valutazioni morali? Se esso è legato a cause fatali, a forze che sfuggono al dominio dell’uomo, non è possibile trattare di un diritto, di una giustizia, d’una moralità della guerra: essa è essenzialmente amorale, come è amorale la scossa sismica o la lotta delle formiche. Vi è una teoria, la teoria biosociologica, per la quale la prova del sangue fra gli Stati è una necessità di natura; ossia è una legge essenzialmente inerente alla vita sociale, legge del suo sviluppo, condizione sine qua non del suo progresso. Così nella concezione sociale hobbesiana lo stato permanente, la condizione che è normalmente imposta dalla natura all’uomo è il bellum omnium contra omnes; mentre la pace è una convenzione artificiosa, un espediente precario che si procurerà di conquistare a causa dei suoi vantaggi (Th. Hobbes, Leviathan, Londra 1885, pp. 63-65). «Come il soffio dei venti, scrive l’Hegel, preserva l’acqua del mare dalla putrefazione, nella quale la ridurrebbe una quiete durevole, così vi ridurrebbe i popoli una pace stabile e perpetua» (G. Hegel, Rechtsphilosophie, § 3124). Così ha insegnato il filosofo idealista, e il Principe di Bismarch, fedele all’insegnamento di un “tanto maestro”, nel 1891 respingeva una proposta sul disarmo, dicendo che la guerra è una legge di natura: è la lotta per l’esistenza nella sua forma generale, e finché gli uomini non diventino angeli, essa non cesserà. È questa la tesi, già assai in voga, sostenuta dal noto scrittore tedesco di dottrine militari Bernhardi, per il quale la lotta armata è un’esigenza biologica, una legge, che si svolge nel regno vegetale ed animale in un dramma muto ed incosciente, mentre fra gli uomini viene disciplinata ed inquadrata nell’ordine sociale (Von Bernhardi, Notre avenir, Parigi, p. 64). Successivamente Stegemann, nella sua voluminosa opera sulla guerra, sostiene ch’essa «fu nell’antichità il più grande propulsore delle nazioni e il loro naturale processo, al quale era impossibile il sottrarsi» (H. Stegemann, Der Krieg. Sein Wesen und seine Wandlung, già citato su Sursum Corda n° 244, vol. I, p. 3). Questa teoria anche in Italia ha trovato dei seguaci, fra i quali si segnala l’accademico Francesco Coppola. «Ogni popolo, scrive egli, ogni nazione, ogni Stato, per la legge stessa primordiale della propria vita, tende (...) a svilupparsi indefinitamente: ad affrancarsi, se è servo, a consolidarsi ed ingrandirsi, se è debole e piccolo; e, se già è forte e grande, a ingrandirsi ancora e a dominare, e col dominio a plasmare una sempre più larga parte del mondo secondo il proprio genio, la propria cultura, la propria concezione della vita, in una parola, secondo la propria civiltà». Di qui il contrasto, la guerra. «Questo che può chiamarsi il regime della libera guerra è la stessa legge della vita, è il procedimento della natura e della storia» (La pace coatta, Milano 1929, pp. 54-55). Anche Adriano Tilgher non pensava né scriveva diversamente. Nel Popolo di Roma egli così si esprimeva: «È nell’essenza più profonda dello Stato di cercare di ridurre il superiore ad uguale e l’uguale a inferiore; è nell’essenza più profonda dello Stato di tendere sempre ad una maggiore imperialità, e più lo Stato è Stato, più attua questa sua essenza. E se un giorno la guerra scomparisse del tutto dall’orizzonte, anche come semplice possibilità, quel giorno non ci sarebbero più Stati, non ci sarebbe più politica, ma semplice amministrazione» (II Popolo di Roma, 2 gennaio 1938). Questa concezione in fondo è la concezione marxista della lotta, sollevata però dal piano sociale al piano politico, dalle classi alle nazioni. Secondo il Marx le classi, elementi primigeni della società, sono necessariamente antagonistiche, e il loro cozzo fatale è la legge suprema dell’essere sociale, legge che costituisce il dinamismo perenne, il progressivo divenire, l’essenza stessa della società, giacché per il Marx, come per il suo maestro Hegel, l’essere non è che il divenire (Cfr. Doctrine communiste et doctrine catholique par le p. Ducattillon nell’opera collettiva Le communisme et les chrétiens, Parigi 1937, pp. 62-65).
• Per i bellicisti estremi le nazioni non possono sussistere e progredire, se non sono sospinte dall’essenziale loro impulso all’urto continuo, così come le classi del socialismo scientifico. Non sapremmo sottoscrivere a questa tesi per varie ragioni, che ci limitiamo ad indicare sommariamente. Primieramente il piedistallo su cui si regge, ossia il darwinismo sociale, con la legge selettiva della lotta per la vita, struggle for life, non è che una povera ipotesi, che è stata, dopo il suo quarto d’ora d’immeritata celebrità, respinta dalla scienza. Secondo questa teoria, le specie vegetali ed animali e gli stessi loro individui singoli distruggono quelli che sono inferiori nella lotta ed assicurano col sopravvento dei forti il progresso. Lo stesso avverrebbe mediante la guerra fra le nazioni: la guerra, giustiziera impeccabile, darebbe il primato a quelle che sono più dotate di forza e per questo stesso nel pieno diritto di dominare le sorelle minori. Tutta questa costruzione è in gran parte prodotto di fantasia, giacché la realtà ci attesta che le specie e gli individui anche più deboli spesso sopravvivono, mentre dispaiono talora i più forti. In ogni caso vi è fra il mondo animale e quello umano una frattura invalicabile, una differenza essenziale ed è l’elemento razionale che ci vieta di equiparare l’uomo al bruto, quasiché fossero l’uno e l’altro della stessa natura specifica. Non è possibile d’altronde, a rigore di logica, dedurre la necessità della guerra, ossia di una data lotta, per la semplice ragione che la vita sia una lotta. Dalla necessità dell’alimento per la vita, non si può sempre dedurre la necessità di un qualche determinato alimento. D’altronde la storia ci offre col fenomeno bellico anche l’inverso fenomeno del solidarismo fra i popoli, solidarismo la cui universalità e rispondenza alle esigenze sociali ha una ben netta e chiara significazione della sua natura profondamente umana. Di più, se la guerra fosse una necessità biologica delle collettività politiche, generatrice del progresso civile, essa dovrebbe stare alla base di qualcuno degli avvenimenti che hanno dato un gran balzo in avanti alla civiltà. Si sa che questa s’inizia non appena l’uomo, rinunziando al suo vagabondaggio, si fissa sulla terra per coltivarla. La civiltà sorge con l’aratro e la spiga in mano. Orbene, la scoperta degli strumenti agricoli e della cultura del suolo non è dovuta a Marte (alla guerra, ndr.). E così le altre grandi scoperte decisive per l’incivilimento, come l’alfabeto, la stampa, la pila elettrica, le Americhe e mille altre non hanno nulla a vedere, né direttamente né indirettamente, con gli scontri sanguinosi. Infine una legge biologica, qual è quella della guerra, dovrebbe riscontrarsi in uno stato cronico pressoché in tutti i popoli. Ma ciò non si è mai dimostrato, mentre si hanno prove in contrario. Se dobbiamo credere all’autore dell’opera Origine e sviluppo delle idee morali, al Westermarck, fra non poche tribù selvagge s’ignorano del tutto le costumanze guerresche. Tali sarebbero varie popolazioni della Groenlandia, dell’Australia, i Weddas del Ceylon e non poche altre (Westermarck, Origine et développement des idées morales, Parigi, tomo III, p. 342).
• Se dai primitivi passiamo alle comunità civilizzate, le guerre, ad esclusione dell’epoca moderna, sono state per lo più ad effetti limitati e ristrette a nuclei di combattenti. Le guerre di masse gigantesche sono piuttosto recenti, perché solo con gli odierni progressi tecnici delle comunicazioni e dei trasporti, si possono spostare moltitudini di uomini e quantità enormi di materiali ed armi di guerra. Gli scontri degli eserciti un tempo, se facciamo eccezione delle invasioni barbariche, si limitavano ai confini, e non veniva di punto in bianco sconvolta la vita sociale. Luigi XIV, che per vari decenni visse pressoché sempre in guerra, poteva benissimo attendere con la sua folla cortigianesca ai giochi e ai festeggiamenti continui, in cui sperperava la più gran parte del tesoro pubblico. Le guerre che paralizzano da cima a fondo l’organismo nazionale, le guerre di sterminio un tempo erano piuttosto rare. In base a queste e simili riflessioni, allo sguardo d’uno storico obiettivo la guerra appare piuttosto un fatto anormale, che l’umanità cerca sempre più di limitare, e di rendere, quand’è moralmente inevitabile, meno brutale. Di quel diritto consuetudinario, consacrato successivamente ed ampliato dal diritto positivo internazionale, con cui si vuole disciplinare l’impiego delle forze armate.
• Secondo il Bergson la guerra è naturale per la sua origine. «L’origine della guerra è la proprietà individuale o collettiva, e siccome l’umanità è predestinata alla proprietà per la sua stessa struttura, la guerra è naturale. L’istinto guerriero è sì forte che è il primo a manifestarsi, allorché si gratta la civiltà per trovare la natura. Si sa quanto i fanciulli amano di battersi» (Les deux sources de la morale et de la religion, Parigi 1934, p. 307). Può ben dirsi naturale la guerra, come potrebbe dirsi naturale, per esempio il furto, nel senso che risponde a qualche istinto della natura (corrotta, ndr.). Per l’appunto il furto risponde benissimo all’istinto del minimo sforzo, come la guerra risponde all’istinto della lotta. Ma l’istinto dell’uomo non costituisce, come nell’animale, la natura completa ed indomabile. Il fanciullo è portato di continuo a battersi, perché prevale in esso la natura inferiore, la parte animalesca; ma via via che la ragione si sviluppa, nell’età matura il suo istinto lottatore si modera, ossia si lascia a poco a poco dominare dalla parte superiore o spirituale. Ed è così che crea le leggi, i tribunali e razionalizza la lotta.
• Ma la teoria che accentua all’estremo il determinismo della guerra, è quella che ne fa senz’altro un’esigenza cosmica, una legge fisica. Quei filosofi per i quali Dio, spirito, libertà non hanno che un’esistenza nominale, non possono scorgere nella guerra che una delle tante espressioni del determinismo universale. «La guerra, scrive un cattedratico gallico, è un fenomeno, ma che l’uomo subisce istintivamente, incosciamente, né più né meno come gli animali nelle loro emigrazioni (...) Tutte le influenze cosmiche agiscono più o meno direttamente sull’uomo; ma fra quelle che ci sono note e che sono state oggetto di studio, alcune hanno una funzione preponderante, originale, fondamentale, come quelle che risultano dalle macchie solari, dalle grandi correnti magnetiche terrestri, dalla rotazione quotidiana della terra su se stessa e dal suo giro annuale attorno al sole» (Cfr. A. Eymieu, La Providence et la guerre, Parigi, 1917, p. 284). A queste influenze cosmiche e alle loro fondamentali funzioni, il materialismo è costretto a rivolgersi per spiegare la guerra. A questa stessa spiegazione parrebbe aderire un nostro scrittore, se pigliamo alla lettera una sua dichiarazione al Convegno Volta. «La guerra, ci dice Emilio Bodrero, non è un fatto politico, e tanto meno economico, ma addirittura fatto cosmico, che si produce, quando la sua necessità si scaglia sul genere umano, ed allora nessuno saprebbe impedirlo» (Atti del Convegno di scienze morali e storiche. Tema: L’Europa, Roma 1933, vol. I, p. 357).
• Per chi, come noi, respinge il monismo materialistico, nella guerra giocano degli atti liberi, soggetti quindi ad una valutazione morale. Certamente essa scaturisce bene spesso da una concatenazione di fatti che la rendono inevitabile, ma anche in questo caso non si tratta evidentemente di necessità fisica, ed in ogni modo rimane sempre, nelle sue cause, un fatto del tutto volontario, libero, turgido delle più gravi responsabilità. È questa la sola teoria che risponde al buon senso e che, per lo meno implicitamente o praticamente, è ammessa anche dagli stessi che la negano. Giacché quando costoro si appigliano alla difesa di una delle parti belligeranti e parlano del suo buon diritto e mettono in ballo la giustizia, che significato possono avere i sostantivi di diritto e di giustizia, se la guerra non differisce punto dall’urto dei flutti in tempesta o dall’incrocio delle stelle filanti nel cielo o dalla spinta istintiva di stormi d’uccelli che emigrano in date stagioni? Ma se per alcuni la guerra ha la stessa fatalità di una legge fisica o d’una imposizione dell’istinto, per altri invece la guerra è soltanto una necessità morale, ossia è una delle conseguenze ineliminabili e funeste delle passioni umane che a causa della colpa originale dell’uomo si sono disciolte dalla disciplina razionale. C’è in questo atteggiamento di pensiero qualche particella di verità, ma che non è sufficiente a convalidare l’inevitabilità del folle gioco di Marte. Che sia esso uno fra i germogli più velenosi dell’originario peccato umano, è questa una verità su cui s’impernia in buona parte il sistema dogmatico della Chiesa. Ma ciò non può affatto significare che la guerra non possa essere trionfalmente combattuta, in periodi almeno e fra popoli di una superiore cultura e d’una elevata coscienza giuridica. Anche la peste, la fame, la schiavitù, la pirateria sono in definitiva, per la concezione cristiana, sequela della colpa di Adamo, e possono essere in date condizioni storiche insopprimibili; ma non sono per se stesse, sempre, assolutamente inevitabili.
• Ciò che è inevitabile nel clima prodotto dalla prevaricazione originaria è il disordine, è il dolore in genere con qualche male singolarmente determinato, qual è la morte: ma non è già inevitabile una peculiare manifestazione del disordine o della sofferenza. L’uomo, checché faccia, non potrà mai sottrarsi al dolore; ma armato di scienza può sfuggire, come è già avvenuto, a questo o a quel dolore speciale. Alla stessa guisa la lotta fra gli aggregati politici è fatale, ma non per questo è fatale ogni specifica e concreta estrinsecazione di lotta (Cfr Stratmann, Weltkirche und Weltfriede, op. cit., p. 71). Quella, per esempio, cruenta può, a parere di studiosi egregi, eliminarsi, quale strumento giuridicamente lecito, nell’ambito, s’intende, più o meno vasto di popoli di una più vivace sensibilità morale e giuridica. In una società di Stati in cui per convenzione si eliminasse la guerra, rimarrebbe la possibilità della guerra di difesa, nell’ipotesi che uno Stato — mancando alla convenzione — aggredisse un altro Stato. Rimarrebbe inoltre la guerra di questa collettività statale contro uno degli Stati membri che venisse meno ai suoi doveri. Si noti però che in quest’ultimo caso la guerra sarebbe piuttosto una misura di polizia in grande stile. Nel primo caso la guerra di difesa sarebbe un procedimento giuridicamente lecito e formerebbe l’unica eccezione all’eliminazione della guerra in una società giuridicamente organizzata di nazioni. Come la rissa è dal punto di vista giuridico illecita nell’ambito dello Stato, eccetto nel caso in cui ci si debba difendere da un’aggressione immediata, — così la guerra diventerebbe illecita — e con la stessa eccezione— nella cerchia di una comunità di Stati giuridicamente organizzata. Ma si dirà che la storia si oppone alle nostre affermazioni ottimiste. Se s’interroga il passato, esso parrebbe attestarci che, dacché mondo è mondo, la guerra non è stata mai sloggiata dalla terra; essa sta di continuo sulla ribalta storica, dalla quale non scompare che per brevissimi periodi che hanno nome di pace, ed in realtà non sono che delle soste, delle tregue che preparano nuovi scontri sanguinosi, o meglio, sono anch’esse delle guerre in incubazione.
• Giovanni Bloch si è dato, da buon tedesco, la briga di rovistare negli angoli anche più riposti del passato, per conoscere quale proporzione vi sia tra gli anni di pace e quelli funestati dalla guerra. Mancando le statistiche dei singoli Stati, il paziente scrittore ha fatto del suo meglio per darci qualche ragguaglio complessivo sull’insieme del mondo. Egli calcola che dal 1496 a. C. al 1861 d. C., quindi nello spazio di 3357 anni, soltanto 227 anni scorsero in pace; il resto, vale a dire 3130 anni, è immerso nella guerra (Cit. dallo Stratmann, in Weltkirche und Weltfriede, cit., p. 70). La storia è dunque una guerra continua. Un parere non molto diverso professa un nostro scrittore. «Quanti millenni, si domanda egli, dobbiamo dare alla storia conosciuta dal genere umano? Diciamo dieci, diciamo sette. Ebbene, sono tutti pieni di guerre, sotto ogni cielo, per ogni popolo e stirpe» (Corradini, nel Giornale d’Italia, 7 settembre 1926). Questi attestati non possono accogliersi senza riserve non lievi. Uno sguardo complessivo sullo sterminato orizzonte di alcuni millenni storici facilmente induce in errori di prospettiva. Come osservando la via lattea si ha l’illusione di trovarla tempestata di astri, che parrebbero serrati gli uni agli altri, mentre in realtà sono separati da grandi distanze; così gli avvenimenti guerreschi mentre appaiono riempire da cima a fondo tutta la trama della storia, in realtà si dilungano più nel tempo che nello spazio, sulla totalità dei secoli ma non in quella dei popoli, giacché questi non danzano al tempo stesso la macabra danza di Marte. Se, ora non è molto, due piccole repubbliche d’America misero in moto alcune migliaia di soldati per questioni di confine, non pare che gli altri diciannove Stati transatlantici — come gli Stati degli altri continenti — si siano abbandonati allo stesso giuoco della guerra.
• La storia, ridotta alle sue dovute proporzioni, non è una ragione decisiva dell’assoluta necessità della guerra. Non vogliamo qui omettere che per alcuni la necessità morale della guerra è semplicemente ipotetica; se cioè si vogliono esercitare le virtù eroiche e dare un grande slancio in avanti al meccanismo sociale, fa bisogno la prova delle armi. Senza la guerra le nazioni si chiudono come molluschi nella propria conchiglia e non sanno altro che vegetare. Il Sombart, rinomato economista e sociologo tedesco, nel Convegno Volta, tenuto a Roma nel 1932, dichiarava che «l’avvenire è pregno di molte guerre fra gli Stati... Ma (aggiungeva) non è da rimpiangere questa sorte riservata ai nostri figli e ai nostri nepoti. Soltanto la pace nasconde dei pericoli, nella guerra invece si esercitano le nostre migliori virtù» (Atti del Convegno di scienze morali e storiche. Tema: L’Europa, cit., p. 421).
• La guerra, noi rispondiamo, può talora risolversi in un gran colpo di frusta, con cui l’uomo si sveglia dal lungo torpore, riacquista il senso obliterato della realtà e riaccende l’animo ad egregie cose. Sui solchi inaffiati di sangue non sboccia qua e là il fiore dell’eroismo? Ma sarebbe un procedimento assai fallace quello di voler determinare il valore etico della lotta armata, senza darsi pensiero del rovescio della medaglia. Tutta l’epopea della guerra, soprattutto della guerra moderna, si dissolve in sonora retorica, se si considerano i disastri e le devastazioni non soltanto di carattere materiale, ma soprattutto d’indole morale che da essa fatalmente fluiscono. «L’uomo (è definito da San Tommaso dietro le tracce di Aristotele), si sit separatum a lege et iustitia pessimum animalium, perché egli è armato non solo d’istinto, ma anche d’intelligenza, con cui eleva al massimo il potenziale esplosivo delle sue passioni» (Summ. theol., I-II, q. 95, a. 1). Appunto nello stato di guerra, l’uomo sospinto dalla violenza, dall’odio, dal panico della sconfitta e dall’orgoglio della vittoria è indotto a calpestare ogni senso di giustizia, ogni dovere d’umanità. Anche quando sono deposte le armi, le reazioni psicologiche dell’immane sforzo bellico, si manifestano nelle masse con la corsa al piacere e lo sfrenamento degli istinti peggiori. Il periodo, a cui abbiamo assistito, dopo la prima e dopo la seconda guerra mondiale, non è stato forse funestato da una profonda depressione morale della coscienza privata e pubblica, da un manifesto slittamento del costume? «Se la guerra, scrive il Folliet, permette ad alcuni di superarsi, essa fornisce alle masse le occasioni di deprimersi. La massa non va contro la corrente, ma piuttosto la segue, sia a causa della mollezza, sia a causa dell’odio e dell’invidia» (Morale internazionale, Parigi 1935, p. 60). Quanto poi al progresso che può collegarsi alle lotte cruente, è solo il progresso tecnico che sotto l’assillo della guerra riceve enorme impulso, ma non certo il progresso nella sua ampia sfera, ossia il progresso umano, che si estende in tutte le direzioni, dominate dal progresso morale, che è l’anima dell’incivilimento. Questo progresso solo nei periodi di pace trova le condizioni per attuarsi. Tutto sommato la guerra non è affatto inevitabile, perché non è una legge, ossia un effetto del peculiare determinismo biologico, né del determinismo generale del cosmo, e se talora ha una necessità morale, è solo in date condizioni storiche, in dati periodi della civiltà. Se quelle condizioni si modificano, se quei periodi si superano, anche date forme di violenza, di predominio, di sfruttamento spariscono o danno luogo a nuove forme.
• Le nazioni lotteranno sempre fra loro, giacché vi è sempre qualche divergenza d’interessi e di idee; ma la forma cruenta della loro lotta, che non è il mezzo unico, né, molto meno, certo, per il trionfo del diritto, potrà essere sostituita da forme razionalizzate e degne dell’uomo col crearsi di nuovi quadri politici. Ci si dirà che tutto ciò non è che un’utopia, perché, fra l’altro, cozza col problema demografico. Col progredire della popolazione di alcune nazioni — peggio ancora se l’aumento si avvera indistintamente in tutte — è impossibile che non si venga all’extrema ratio delle armi. «L’Europa, scrive il Bergson, è eccessivamente popolata, ben tosto lo sarà tutto l’orbe; se non si razionalizza la produzione dell’uomo, come si è cominciato a fare col lavoro, si avrà la guerra. Niente è così dannoso quanto abbandonarsi all’istinto. La mitologia antica l’aveva ben compreso, associando la dea dell’amore col dio della guerra. Lasciate fare a Venere, essa vi condurrà a Marte» (Les deux sources de la morale et de la religion, cit., p. 313). A questa obiezione, che spira d’un’aria prettamente malthusiana, rispondiamo coll’osservare anzitutto come le previsioni che più o meno presto la terra rigurgiterà di abitanti, sono ipotetiche: ossia suppongono che rimangano identiche le condizioni di ambiente e non si trovino nuovi e più redditizi metodi di coltivazione e di allevamento; soprattutto si suppone che la terra al presente coltivata sia pressappoco tutta la terra coltivabile, ciò che non è vero (...) Inoltre giocano purtroppo nella storia delle forze limitatrici della popolazione, come le passioni umane, particolarmente l’egoismo, che arresta o diminuisce all’estremo la prolificazione. Se stiamo non nell’astratto, ma nel concreto, se osserviamo che Venere non è l’unica passione dell’uomo, potremmo affermare che Venere più che ai conflitti delle armi porta al regresso demografico ed allo spopolamento. Intere civiltà sono disparse sotto i colpi del vizio, nessuna per ora a causa della sovrappopolazione. Ancora è ben lontano, ad eccezione di qualche popolo, il limite relativo di saturazione demografica, tanto più poi il limite assoluto. Anche oggi ha il suo valore il suggerimento biblico Replete terram et subiicite eam (Gen., I, 28).
• L’uomo si può moltiplicare e riempire la terra, purché la riduca al suo pieno potere. Se l’uomo cercherà di dominare sempre più la terra con l’emigrazione, con la colonizzazione, con la bonifica, con la generale applicazione delle scoperte tecniche, con l’organizzazione della distribuzione, non avrà a temere della sovrappopolazione, almeno per molto tempo ancora. Se i miliardi che s’impiegano negli armamenti o nelle guerre, fossero impiegati in opere produttive, nella conquista di tanta parte del suolo incolto, nel miglioramento delle culture agricole, nel valorizzare un gran numero di risorse, che pur giacciono sterili nella terra e nel cielo, nel favorire nuove invenzioni e progressi, l’umanità potrebbe procedere innanzi per molto tempo ancora senza alcuna preoccupazione malthusiana. (Cfr A. Brucculeri, Sul problema di Malthus, Roma 1928).
• Se la guerra non è una fatalità sottratta alla libertà dell’uomo, come abbiamo dimostrato nel capo precedente; se essa dunque ha un necessario rapporto con l’etica, qual è questo rapporto? Per alcuni è un rapporto di assoluta opposizione: la guerra è in se stessa sempre ingiusta, intrinsecamente inconciliabile con la norma etica. Per alcune sette ereticali come i manichei, i viclefiti, i quaccheri, come per i seguaci del pacifismo estremo, l’urto bellico è sempre illecito, perché essenzialmente immorale. Di qui la comoda teoria della non resistenza al male (Sulle concezioni del pacifismo V. Barthélemy de Light, Mobilitation contre la guerre, Parigi 1934. Dello stesso autore: La paix creatrice, due volumi, Parigi 1935). Per altri, invece, per gli idolatri della forza, la guerra è in se stessa moralmente bella e sacrosanta. «Voi, dite, scrive il Nietzsche, che la buona causa santifica persino la guerra. Ed io vi dico: la buona guerra santifica ogni causa. La guerra e il coraggio hanno operato cose più grandi che non l’amore del prossimo» (Così parlò Zarathustra, Parte prima: I discorsi di Zarathustra. Della guerra e dei guerrieri). Non mancano coloro che hanno addirittura divinizzato la guerra sotto i suoi vari aspetti, non escluso il furore belluino con cui si scaglia il soldato contro il nemico. II De Maistre, nel settimo intrattenimento delle Soirées de Saint-Pétersburg, scrive con solennità stilistica: «La guerra è divina in se stessa, perché è una legge del mondo. La guerra è divina per le sue conseguenze supernaturali (...) La guerra è divina nella gloria del mistero che la circonda (...) La guerra è divina per la maniera con cui si intima». Un po’ prima scrive: «L’uomo, invaso tosto d’un furore divino, estraneo all’odio ed alla collera, s’avanza sul campo della battaglia senza nemmeno sapere ciò ch’egli stesso vuole, né ciò ch’egli fa». Continuando l’apoteosi della guerra, aggiunge: «Se si getta uno sguardo sulla funzione che esercita nella guerra la moralità, bisogna pur consentire che in nessun’altra maniera, come nella guerra, si fa sentire sull’uomo la mano di Dio» (tomo II, Aversa 1821, pp. 23, 26, 31). Sul valore di questa divinizzazione della guerra fatta dal grande savoiardo si legga lo studio del p. Yves de la Brière nel volume: Église et paix, Parigi 1932, ovvero nel volume Le droit de juste guerre, Parigi 1938.
• Il cattolicesimo respinge queste due teorie e, pur abborrendo ogni e qualsiasi guerra, sostiene una tesi mediana: la guerra non è per la sua intima essenza un male morale, non ha una necessaria ripugnanza con la razionale natura umana, in date condizioni può ben comporsi con la norma etica. Le prove di ciò sono varie e decisive. Alcune si hanno nei libri sacri, sia dell’Antico come del Nuovo Testamento. Nel Genesi si parla della guerra del popolo eletto, e si plaude ad Abramo e si benedice Dio, quo protegente, i nemici sono caduti in mano di Abramo (Gen., XIV, 19-20). Dio stesso aveva ordinato a Mosè, a Giosuè, a Gedeone, a Sansone, a Davide, ai Maccabei e ad altri personaggi biblici di fare la guerra. Anche il Nuovo Testamento, sebbene esso promulghi una legge di amore ed insista, più che non si faccia nell’Antico Testamento, sull’attributo divino della bontà e della misericordia, in definitiva non si scosta, sul problema della moralità della guerra, dalla concezione ammessa nei più antichi testi sacri. Senza dubbio, alcuni passi evangelici parrebbero opporsi alla tesi della liceità della guerra. Ricordiamo i principali: Converte (disse Gesù Cristo a San Pietro) gladium tuum in locum suum: omnis enim qui acceperit gladium, gladio peribit (Mt., XXVI, 52) - Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. In base a queste parole Tertulliano pensa che Gesù Cristo abbia voluto disarmare tutti i soldati (De idololatria, XIX). Anche più recentemente critici piuttosto superficiali non hanno trovato in Gesù Cristo che un pacifista assoluto, Leone Tolstoi osa insegnare: «Il soldato può essere e deve essere il soldato di Cristo; egli sarà tale non già ubbidendo ai capi che lo preparano all’assassinio (...) ma solo se nel nome di Cristo, egli respingerà la condizione empia e vergognosa di soldato; sarà guerriero di Cristo se combatterà non il nemico esterno ma quello interno, che inganna lui e i suoi fratelli, e lo combatterà non con la spada, il pugno o i denti, ma con la ragione e la dolcezza; se subirà tutte le sofferenze ed anche la morte, anziché fare il soldato, ossia l’uomo pronto ad uccidere tutti quelli che gli saranno indicati dai suoi capi» (L. Tolstoi, Appel aux dirigeants, Parigi 1902, p. 100). E tra noi (l’eresiarca) Murri, atteggiandosi a critico autentico del Vangelo, trovò in esso la condanna assoluta della guerra, «che è la più evidente manifestazione, e quindi la più riprovevole (...) del regno di Satana in opposizione al regno di Dio (...) Uccidere essendo cristiani, avvicinarsi alla mensa dell’amore alla vigilia di una carneficina da compiere, ecco ciò che nessuna potenza di Chiesa riuscirà mai a fare accettare dal critico sereno del pensiero autentico di Gesù» (La croce e la spada, Firenze, p. 71).
• Eppure, con buona pace degli antichi e nuovi critici, il pensiero di Gesù Cristo nella sua interezza non ha il contenuto antibellicista che gli si vuole attribuire. Gesù Cristo infatti parla della spada che si brandisce per privata autorità (Cfr. S. Agostino, Contra Faustum, XXII, 70-74; Migne, P.L., 42, 444-447). «Non è senza ragione, dice San Paolo, che il principe porta la spada, giacché egli è il ministro di Dio, per eseguirne le vendette contro coloro che fanno il male» (Rom. XIII, 4). Ego autem vobis dico non resistere malo (Mt., V, 39). In questo detto ed in altri consimili, dice San Tommaso (Summ. theol., II-II, q. 40, a. 1), si parla di disposizioni d’animo; all’uopo si deve esser pronti a rinunziare alla propria difesa; nel fatto bisogna talora difendersi. È certo che lo stesso Gesù Cristo che disse di offrire la guancia a chi ci percuote nell’altra, si difese contro il soldato che lo aveva schiaffeggiato di fronte ad Anna. Anche San Paolo si difese quando fu battuto per ordine del capo dei sacerdoti. Va poi notato che questi speciali consigli del Redentore riguardano la santificazione degli individui, non furono rivolti alla società. — Nel Vangelo, va rilevato, il Battista fa delle raccomandazioni ai soldati, ma non riprova la loro professione militare (Lc., III, 14). Due centurioni, benché uomini di spada sono lodati come esemplari cristiani (Mt., VIII; Act., X). In genere Gesù Cristo appare nel Vangelo ossequente al potere costituito e alle pubbliche istituzioni. Non si può affatto dimostrare che egli condanni il diritto di spada, quasi fosse l’impiego delle armi per se stesso immorale (Cfr Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, cit., p. 12).
• Un’altra prova non meno convincente di quella scritturale, è quella fondata sul diritto di natura, diritto che con tanta leggerezza oggi si nega o si confonde con la sua degenerazione del giusnaturalismo; diritto frattanto, che è stato riconosciuto dalla legislazione romana fino ad ammettere la sua prevalenza sullo stesso diritto positivo. Nel Digesto infatti si proclama questo principio: Nec enim naturalis ratio auctoritate senatus commutari potuit. È proprio questo diritto di natura che propugna con l’adesione della coscienza universale il principio che è permesso, e talora doveroso, rigettare l’ingiusto aggressore con la forza, servato tamen moderamine inculpatae tutelae. Cicerone doveva con la sua fastosa eloquenza illustrare questo principio, su cui si regge la sana concezione del diritto di guerra. « È questa una legge non scritta, ma naturale, che noi non abbiamo imparato, ricevuta o letta; ad essa non siamo stati istruiti, ma fatti; non addestrati ma impregnati; e dice questa legge che se noi ci trovassimo nella necessità di salvare la nostra vita da agguati, dalla violenza o dalle armi di briganti o di nemici, potremmo difenderla con ogni mezzo onesto. E questa la ragione ha insegnato ai colti, il bisogno ai barbari, la consuetudine ai popoli e la stessa natura agli animali (...)».
... prosegue la prossima settimana ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, i recenti drammatici sviluppi della guerra in Ucraina - dove, va ricordato, dal 2014 si consumano atti sanguinosi nell’indifferenza dei principali media occidentali - ci portano a riflettere, con l’equilibrio che contraddistingue il pensiero cristiano, sul concetto di guerra e sulle tante differenze, per l’appunto, fra la cieca violenza e uso legittimo della forza. Al bisogno utilizzeremo l’approfondimento di Angelo Brucculeri S.J., «Moralità della guerra», per La Civiltà Cattolica, Roma, 1953.
• La guerra è uno tra i fenomeni sociali che ha avuto nella storia il maggiore rilievo. Gli storiografi, soprattutto gli antichi, si sono preoccupati di prospettare, pressoché esclusivamente, gli eventi bellici, lasciando spesso nell’ombra le vicende non meno e talora più importanti della vita dei popoli. Dal punto di vista sociologico la guerra è una delle più caratteristiche manifestazioni della lotta, che è inerente alla vita; lotta che non ha certo la significazione darwinistica della selezione e del trionfo degli individui e delle razze più riccamente dotate dalla natura, ma che importa una funzione vitale, con cui l’organismo individuale o collettivo mira a disfarsi degli antagonismi che ne pregiudicano lo sviluppo e a conquistare dei beni assimilabili e in qualche modo proficui. Un organismo qualsivoglia, sia l’insetto del prato o il leone del deserto, sorregge la sua esistenza attraverso la distruzione e l’appropriazione di altri esseri, ciò che avviene sovente con la lotta. Anche l’uomo, come qualsiasi altro essere vivente, è un lottatore, e la sua vita è necessariamente un’arena e la sua naturale professione una tal quale milizia. Pur sotto questo aspetto «Militia est vita hominis super terram» (Iob 7, 1).
• Ma tra il mondo semplicemente animale e quello umano corre un divario d’estrema importanza. Nel primo le forme concrete della lotta sono fatalmente rigide, sempre identiche; nel secondo si modificano, e mentre alcune decadono altre risorgono; nel primo domina la fatalità dell’istinto, nel secondo la mobilità inventiva e creatrice dell’intelligenza. L’uomo, scrive lo Stratmann, può dirsi con maggiore diritto essere per natura un lavoratore anziché un lottatore. Che non sia, prima d’ogni altro, fatto per la lotta, si scorge dalla sua debolezza fisica. Non ha artigli, corna, zanne, ma uno strumento acconcio al lavoro, ossia la mano (Weltkirche und Weltfriede, Ausburg 1924, p. 71). Il Nietzsche e lo Spengler sono di ben diverso parere e definiscono l’uomo: «Un animale di rapina». (O. Spengler, Anni decisivi, Milano 1934, p. 35).
• Dal punto di vista giuridico la guerra è un istituto universalmente ammesso quale mezzo estremo e risolutivo dei conflitti che sorgono fra gli Stati. Il Vattel la definisce: «Lo stato in cui si persegue con la forza il proprio diritto» (M. De Vattel, Le droit des gens, Parigi 1820, tomo 2, p. 124); definizione non integra, giacché nell’accezione odierna la guerra ha un carattere pubblico, sicché la classificazione degli antichi internazionalisti, di guerre private e guerre pubbliche, è del tutto separata nel diritto moderno. Il Suárez con maggior precisione così definisce la guerra: un conflitto esterno, contrario alla pace esteriore, allora propriamente si dice guerra, quando avviene tra due prìncipi o due Stati; se invece avviene tra il prìncipe e lo Stato si dice rivolta; se tra privati si dice rissa o duello: concetti tra i quali la differenza sembra più di forma che di sostanza (De charitate, Disput. XIII, De bello, Tomo XI dell’edizione veneziana del 1742, p. 406). Il Codice di morale internazionale, edito dall’Union internationale d’études sociales, sulle tracce del Taparelli, definisce la guerra: «Una lotta armata fra società uguali e sovrane per far prevalere ciò ch’esse considerano come il loro diritto o il loro interesse» (Codice di morale internazionale, Roma 1944, art. 137. Cfr Taparelli, Saggio teoretico di dritto naturale, n. 1319). Assai più semplice è la definizione del Clausewitz, il famoso maestro di strategia: «La guerra è azione di forza per costringere il nemico a compiere il nostro volere» (Cfr H. Stegemann, Der Krieg. Sein Wesen und seine Wandlung, Stoccarda Berlino 1939, p. 4. Per le varie definizioni della guerra nelle varie epoche si veda il Digesto Italiano, alla voce Guerra).
• La guerra può essere classificata in diversi modi. Se ci si fonda sulle cause precipue da cui scaturisce, si danno guerre religiose, dinastiche, nazionali, economiche. Le prime due specie si ricollegano ad ambienti storici ormai sorpassati, mentre le altre due posteriori prevalgono al presente. Queste e simili distinzioni sono precise solo in astratto: in concreto vari interessi influiscono al tempo stesso e in grado diverso nel causare i contrasti armati. Così le guerre religiose che seguirono lo scoppio della riforma protestantica, coinvolgevano gravi interessi politici ed economici. Dal punto di vista morale si distinguono le guerre giuste e le guerre ingiuste, legittime ed illegittime. Col prevalere del positivismo giuridico si è espulso dal diritto internazionale il concetto della legittimità o della liceità della guerra, come concetto del tutto inutile; giacché si è voluto limitare la scienza del diritto internazionale al come debba farsi la guerra, ma non chiedersi quando gli Stati siano autorizzati ad intraprenderla. Ma in tempi assai recenti sono sorte, contro la dominante tendenza positivistica, delle forti correnti che hanno rievocato e giustificato la nozione del lecito e dell’illecito giuridico anche nell’ambito del diritto internazionale (Cfr Oppenheim, International Law, Londra 1928, vol. 1). «Non si può ammettere, scrive il prof. Diena, che il concetto della legittimità della guerra sia del tutto estraneo al diritto internazionale, il quale, a tale riguardo, sia pure incompiutamente e frammentariamente, fornisce determinate norme. Così non vi è dubbio che la guerra è illecita, se uno Stato la imprende infrangendo gli obblighi assunti con la stipulazione di un trattato di conciliazione o d’arbitrato o di regolamento giudiziario, oppure con un patto di non aggressione, oppure ancora con la partecipazione ad un trattato diretto a riconoscere, ed eventualmente a garantire, la neutralità di un dato Stato. Parimenti sarebbe giuridicamente illegittima una guerra che mirasse ad ottenere una riparazione per un fatto che non sussiste, o non è imputabile allo Stato contro il quale la guerra è diretta; come pure una guerra fatta per indurre uno Stato — sulla base di un trattato — ad una determinata prestazione o all’astensione da una data azione, mentre il trattato rettamente interpretato non fornisce alcun valido fondamento alla pretesa della parte che imprende la guerra» (G. Diena, Diritto internazionale, Parte prima, Diritto internazionale pubblico, 3a ed., Milano 1930, p. 590).
• Una distinzione di non minore importanza, che suole farsi delle guerre, è quella di guerre difensive e guerre offensive. Il preciso significato di queste due attribuzioni non è sempre identico fra i vari studiosi. Per lo più si adotta un criterio estrinseco per designare la differenza che corre fra la guerra difensiva e quella offensiva. La prima si attua da chi piglia le armi per resistere ad un’invasione; la seconda da chi inizia per il primo gli attacchi contro un altro Stato. «In un certo senso, diremo col Regout, ogni guerra può dirsi — dato l’intento di mantenere dei diritti — guerra difensiva; ma l’abuso che si è fatto, e si fa tuttora, di un simile qualificativo, mette nella necessità d’impiegarlo soltanto allorché si tratta di resistenza ad un’aggressione armata, di difesa contro coloro i quali hanno effettivamente creato lo stato di guerra; e l’essenziale del concetto di aggressione, o di attacco, consisterà nell’irruzione in territorio nemico o nella preparazione o cooperazione diretta allo stesso scopo» (R. Regout, La doctrine de la guerre juste, Parigi 1935, p. 309).
• Oltre le chiacchiere da bar e/o fra sedicenti esperti, è noto quanto sia malagevole determinare la figura dell’aggressore. Il Protocollo di Londra, del 3 e 4 luglio 1933, si accinse a definire con precisione l’aggressore, rendendo un buon servizio allo sviluppo del diritto. Questo protocollo venne inserito in due trattati: il primo fra l’Unione Sovietica, la Polonia, la Romania, la Turchia, l’Estonia, la Lettonia, la Persia e l’Afghanistan; il secondo fra l’Unione Sovietica, la Turchia, la Romania, la Cecoslovacchia e la Iugoslavia. Nell’art. 2 è così definito l’aggressore: «Sarà riconosciuto quale aggressore in un conflitto internazionale, sotto riserva di accordi in vigore fra le parti in conflitto, lo Stato che avrà compiuto una delle azioni seguenti: 1) Dichiarazione di guerra ad un altro Stato; 2) Invasione con le forze armate — anche senza dichiarazione di guerra — nel territorio di un altro Stato; 3) Attacco con forze armate, navali, aeree — anche senza dichiarazione di guerra — contro il territorio, le navi, gli aeroporti di un altro Stato; 4) Blocco navale delle coste, o dei porti di un altro Stato; 5) Appoggio dato dallo Stato a bande armate, che dal di loro territorio avranno invaso il territorio d’un altro Stato, ovvero rifiuto, malgrado la domanda dello Stato invaso, di prendere sul proprio territorio tutte le misure in suo potere per privare le dette bande d’ogni aiuto e protezione». Non è il caso di soffermarci sulle altre specie di guerra, giacché non presentano speciali difficoltà; come le guerre coloniali, le guerre preventive, le guerre d’intervento, le guerre ad effetti limitati e le guerre di sterminio. Oggi si parla anche della guerra totale, e non senza ragione; giacché la guerra moderna, non solo non si combatte più fra nuclei ben limitati di soldatesche, ma — se si tratta di grandi potenze — domanda milioni e milioni di militi, assorbe tutte le energie del paese, mobilita in un modo o in un altro tutta la popolazione adulta, e a causa dell’arma aerea trasforma tutto il territorio dei belligeranti in zona di guerra ed espone al pericolo della vita non soltanto i combattenti delle trincee, ma tutti indistintamente i cittadini. Queste brevi nozioni preliminari ci sono apparse opportune prima di esporre il concetto cristiano della guerra, che vuol essere l’oggetto di questo studio.
• L’evoluzione del concetto cristiano di guerra. L’elaborazione d’una dottrina sulla guerra consona alle premesse evangeliche s’inizia dopo il trionfo di Costantino, allorché la Chiesa poté liberamente svolgere la sua azione nel pieno giorno della pubblicità. I padri, i dottori, i teologi, i canonisti contribuirono in diverse epoche ad enucleare dapprima e poi a svolgere, ad integrare, a sistemare la concezione cristiana del diritto di guerra (Cfr A. Harnack, Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in drei ersten Jahrhunderten, Tubinga 1905. — A. Vanderpol, La doctrine scolastique du droit de guerre, Parigi 1919. — R. Regout S.J., La doctrine de la guerre juste, Parigi !935- — Yves de la Brière, Le droit de juste guerre, Parigi 1938). Noi non faremo la storia di questa dottrina, ma indicheremo soltanto i principali formulatori di essa. La fonte originaria e più cospicua del cristiano insegnamento della guerra è Sant’Agostino (354-430). Tutta la tradizione medievale, come quella dei pensatori cattolici posteriori, si fonda e si sviluppa sui principii che il gran genio di Tagaste aveva posto a base delle sue considerazioni sulla moralità della guerra. Della quale egli parla qua e là in molti suoi scritti: come nelle lettere al tribuno Marcellino, al suo intimo Publicola, al conte Bonifazio, al conte Dario (Rispettivamente nei nn. 38, 47, 189, 229 della collezione pubblicata nel Migne). Ne tratta anche nelle opere: Contro Faustum manichaeum, De libero arbitrio, Quaestiones in Heptateuchum; soprattutto nell’opera monumentale De Civitate Dei, in maniera speciale nel libro XIX (Anche prima di Sant’Agostino, Sant’Ambrogio nell’opera De Officiis aveva fatto qualche cenno sulla difesa del diritto di guerra e sulla difesa del prossimo, vittima di qualche ingiustizia).
• In queste opere si ha una visione, sia pure schematica, della cristiana concezione della guerra. Secondo i postulati di Sant’Agostino, la guerra ha questi caratteri: 1) Carattere pubblico. «L’ordine naturale tra gli uomini adatto alla pace postula che il potere e la decisione di dichiarare la guerra appartenga al principe» (Contro Faustum, lib. XXII, 74 : Migne, P.L. 42, 448); 2) Carattere necessario, indicato soprattutto nella lettera al conte Bonifazio. «La volontà deve volere la pace, sicché solo la necessità spinga alla guerra... Solo la necessità porti ad uccidere un nemico in combattimento, e non la volontà» (Ad Bonifacium, 6. — De Civit. Dei, IV, 15 e XIX, 7. Rispettivamente nella P.L. 33, 856; 41, 124; 41, 634); 3) Carattere provvidenziale. La guerra apporta dei mali gravissimi, ma che Dio permette per scopi morali e in definitiva per la santificazione e la salute delle anime. Quando la disfatta tocca al giusto, anche allora si può giustificare la Divina Provvidenza. «Ogni vittoria, anche quando tocca ai cattivi, per divina disposizione umilia i vinti o in emendazione o in punizione delle loro colpe» (De Civit. Dei, XIX, 15: Migne, P.L. 41, 643); 4) Carattere punitivo, in quanto importa un castigo dei colpevoli. «Una guerra si dice giusta quando ripara un torto» (In Pent. VI, 10: Migne, P.L. 34, 781). Non pare però che per Sant’Agostino questo carattere sia assoluto, giacché per lui, come vedremo, sarebbe anche causa di giusta guerra mantenere e difendere l’ordine obiettivo, anche nei casi in cui non ha nulla da vedere la punizione (Cfr Regout, La doctrine de la guerre juste, cit. pp. 43-44); 5) Carattere strumentale, poiché la guerra è un mezzo per raggiungere la pace. «Si fa la guerra per arrivare alla pace» (Epist. 189, 6: Migne, P.L. 33, 856). «A scopo di pace si fanno le guerre anche da quanti s’adoperano ad esercitare la loro bellicosità comandando e combattendo» (De Civit. Dei, XIX, 12: Migne, P.L. 41, 657); 6) Carattere ingrato, giacché, anche quando è un’imposizione della giustizia, anche quando è doveroso, trae seco dei mali. Per questo Sant’Agostino ha orrore dei ludi di Marte (sacrifici in onore del “dio” della guerra). Anche la stessa giustizia che induce a pigliare le armi l’affligge, al pensiero che dietro la giustizia vi è l’iniquità del nemico, la quale ha reso necessario l’intervento armato. «L’iniquità, dice egli, non può non addolorare l’uomo, anche se non sia apportatrice di guerra» (Ibidem, XIX, 7: Migne, P.L. 41, 634).
• Dobbiamo altresì rilevare che non sfugge al Vescovo d’Ippona come anche l’impresa bellica, per quanto giusta, non debba prescindere da considerazioni d’indole universale, ossia non deve obliare che vi è un bene che interessa tutta la grande famiglia del genere umano. Le esigenze di questa più vasta comunità umana devono avere il loro peso nella condotta dei belligeranti, fino a prevalere talora contro gli egoismi delle particolari sovranità territoriali. Sant’Agostino, giustificando la guerra degli ebrei contro gli amorrei, fa questa osservazione: «Si deve notare in quali condizioni si facevano quelle giuste guerre: si negava quel libero e sicuro passaggio (nel paese) che il diritto naturale civile esigeva che fosse permesso» (Quaest. in Heptateuchum, IV, 44: Migne, P.L. 33-34. 739). Non vogliamo terminare questi appunti sommari sulla visione agostiniana della guerra senza un qualche cenno sulle fonti. Il santo dottore trasse alcuni elementi della sua costruzione da Cicerone, il quale nelle opere: De republica, De legibus, De officiis tratta della legittimità della guerra. Il sommo oratore romano ammette anzitutto il principio fondamentale, senza il quale ogni legge come ogni diritto rimane nel vuoto, il principio di un ordine giuridico naturale e comune a tutti gli uomini e a tutti gli aggregati umani: «Quelli che ammettono che bisogna tener conto dei cittadini e non degli stranieri, distruggono la società umana; la rovina della quale trascina seco la perdita totale d’ogni civiltà, libertà, bontà e giustizia. E chi rovina questi sommi beni dev’essere trattato anche come nemico degli Dei immortali» (De officiis, III, 6). Sul fondamento di un diritto e di una universale società umana, Cicerone insegna che le armi vanno prese quando non c’è altro mezzo per dirimere le divergenze e raggiungere la pace, la quale è il fine a cui è rivolta la guerra. «Si devono intraprendere le guerre per questo motivo, perché si viva in pace senza subire ingiustizie» (De officiis, I, 11). Inoltre per Cicerone la guerra deve fondarsi su d’una giusta causa; ma il suo concetto di giustizia, come avviene presso i giuristi romani, sdrucciola in un vuoto formalismo. La guerra sarebbe anche giusta se si siano osservate le formalità esteriori prescritte dalle leggi e dai riti feciali. Anche il semplice fastigio imperiale legittimerebbe una guerra, ancorché non ci fosse alcuna violazione dei propri diritti. In questo caso però, si deve condurre la guerra con maggiore moderazione. «Ma le guerre intraprese per la gloria del potere, devono essere combattute con minor violenza» [sic!] (Ibidem I, 12).
• Dopo sant’Agostino l’insegnamento cristiano sulla guerra si evolve attraverso non pochi scrittori: come Sant’Isidoro, arcivescovo di Siviglia (560-636); Yves de Chartres (1040-1116), che fu il maggior canonista del suo tempo: il benedettino Graziano, che nel suo Decreto (Concordantia discordantium canonum) apparso nel 1150, raccoglie, integrandolo ed illustrandolo, quanto si era scritto fin allora sul diritto di guerra. Nel secolo XIII San Tommaso d’Aquino (1225-1274) doveva nella sua Somma teologica riassumere, con la sua abituale chiarezza e penetrazione, il pensiero di Sant’Agostino sulla questione della moralità dell’uso delle armi. San Tommaso tratta di questo argomento con una ben ristretta visuale, qual è appunto quella della coscienza individuale di fronte alla guerra. Egli quindi si domanda: «Se il far la guerra sia peccato» (Summa theol., II-II, q. 40 e anche q. 29). Risponde coll’enumerare le tre condizioni che possono giustificare l’impiego della spada, ossia l’autorità del principe, la causa giusta, il retto fine. Nelle obiezioni, ch’egli risolve nello stesso articolo consacrato alle menzionate condizioni, accenna agli scopi ultimi della guerra: il bene comune e la pace. Sorvola frattanto su non pochi problemi che riguardano l’argomento in questione. Ci parla dell’autorità del principe, ma non solleva la questione se vi può essere un’autorità superiore, per esempio quella dell’imperatore. Sulla giusta causa della guerra non fa menzione della necessità dell’uso della forza, per non esservi altri mezzi efficaci ad eliminare il conflitto; come anche non parla della proporzione richiesta fra lo sforzo bellico e il fine che si vuole raggiungere. Confinata al punto di vista soggettivo, la trattazione dell’Angelico riesce necessariamente sommaria. In ogni modo fu un grande merito (come è stato ragionevolmente rilevato) che San Tommaso abbia preso in considerazione il problema della guerra, giacché era stato da tempo trascurato. Basta dire che non ne fanno alcun cenno Alberto Magno, Scoto, Bonaventura, soprattutto Pietro Lombardo, che col suo manuale rinomatissimo: Il libro delle sentenze, dominò a lungo le scuole teologiche del medioevo (Cfr B. de Solages, La genèse et l’orientation de la guerre juste, in Bulletin de littérature ecclésiastique, aprile-giugno 1940). [Sebbene San Tommaso torni a parlare della guerra, in termini maggiormente approfonditi, nel De Regimine ed altrove].
• Bisogna pervenire al secolo XVI per avere una trattazione ampia e sistematica sul diritto di guerra alla luce della morale cristiana. È il domenicano de Vitoria (+ 1546), professore di Salamanca, che ci dà siffatta trattazione nelle sue Relectiones theologicae, e precisamente nei trattati: De Indis e De iure belli. Ciò che nel Vitoria ha uno sviluppo della maggiore importanza, e che costituisce un progresso gigantesco della cristiana dottrina della guerra e della pace è la netta e solenne affermazione della comunità internazionale; comunità internazionale che trascende ed include la stessa cristianità, la quale forma alla sua volta una comunità più ristretta. Per il grande domenicano la comunità internazionale non deve sfuggire al moralista e al giurista. Per lui una guerra diviene ingiusta se vi è l’utilità d’una parte con danno della comune famiglia dei popoli o della cristianità. «Siccome ciascuno Stato è membro di tutta l’umanità e soprattutto, siccome ogni regione cristiana è parte di tutto lo Stato, se una guerra portasse sì dei vantaggi ad una regione o ad uno Stato ma con danno dell’umanità o della cristianità, stimo che per ciò stesso quella guerra debba dirsi ingiusta» (Relectiones theologicae, XII, Lione 1557. De potestate civili, 13, p. 193).
• Il Suárez (1548-1617) su molti dei problemi del diritto di guerra non aggiunge nulla d’importante alle dottrine del Vitoria e dei suoi predecessori. Però la sua Disputatio de bello, che sarebbe la XIII del suo trattato De charitate, va apprezzata per la precisione filosofica e teologica, e per l’esposizione rigidamente conforme alla didattica scolastica. Mentre il Vitoria sente, dirò così, i problemi dell’ora e dà alle sue lezioni l’importanza vivace dell’ambiente in cui vive, il Suárez invece studia nella chiusa cerchia della scuola i problemi morali e giuridici della guerra, senza mostrare alcun contatto con la realtà storica in cui vive. Un merito però tutto proprio del grande teologo e maestro del Collegio Romano, si è d’aver dato nel suo Trattato De legibus «la formula più esatta (come scrive il p. Yves de la Brière), la più espressiva e sempre attuale del concetto della comunità internazionale, ove si attua la sintesi sociale dell’unità e della diversità umana, e che costituisce la base universale del diritto delle genti... Si dovrà in ciò senz’altro riconoscere la concezione fondamentale, l’annunzio divinatore di tutti gli ulteriori sviluppi della scienza del diritto delle genti, in un’organizzazione sintetica e giuridica delle due essenziali realtà: la comunità umana e la diversità umana» (Yves de la Brière, in Vitoria et Suárez, Contribution de théologiens au droit international moderne, Parigi 1939, pp. 4, 11).
• Ci facciamo un dovere di riprodurre la formula suaresiana nella sua interezza: «Il genere umano, benché sia diviso in popoli e regni diversi, conserva sempre una certa unità, non solo specifica ma anche pressoché politica e morale, che risulta dal precetto naturale dell’amore e carità mutua, precetto che si estende a tutti, anche agli stranieri di qualsiasi sorta. Quindi benché ogni città indipendente, o repubblica o regno, siano comunità perfette e costituite dai propri membri, non di meno, ciascuna di tali comunità è alla sua volta membro in qualche modo di questa collettività, che è il genere umano. Giammai, infatti, queste comunità possono, divise, bastare a se stesse, in guisa da non avere alcun bisogno di scambievole aiuto, di associazione e comunicazione; sia per migliorare le proprie condizioni ed accrescere i vantaggi, sia per qualche morale necessità o indigenza, come l’esperienza ci mostra. Per questa ragione esse hanno bisogno di un qualche diritto che le diriga e ben disciplini in questo genere di comunicazione e di associazione. E benché ciò in buona parte avvenga spontaneamente per impulso naturale, non però sufficientemente e direttamente in ogni cosa. Per questo si sono introdotti certi diritti con le consuetudini di tali nazioni. Poiché come in una città o provincia la consuetudine introduce il diritto, così nella collettività del genere umano le costumanze hanno introdotto il diritto delle genti» (De legibus, lib. II, cap. XIX, 9). Questa luminosa dottrina del Suárez sull’unità morale dei popoli, che li sospinge verso la loro unità giuridica; questa dottrina che ha qualche vestigio in Cicerone ed in Sant’Agostino, che rifulge in pieno nel Vitoria, che si organizza poderosa nel Taparelli, ha avuto la sua più solenne e autorevole consacrazione nella prima enciclica del beato padre Pio XII, nella Summi Pontificatus del 20 ottobre 1939.
• Dopo il Vitoria e il Suárez s’incontrano molti altri giuristi di valore, come il Vásquez, il Bánez, il Bellarmino, il Lessio, il Molina e non pochi altri, i quali si muovono sulle linee tracciate dai grandi loro predecessori. Nei tempi più recenti va sopra ogni altro indicato il p. Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), che col Curci fu il fondatore della Civiltà Cattolica. Il Taparelli nel suo Saggio teoretico di diritto naturale, alla dissertazione sesta condensa in armonica unità gli insegnamenti tradizionali del diritto di guerra, sfrondandolo al tempo stesso delle prolisse questioni e degli speciosi avvolgimenti che erano in voga nell’età anteriori. Pregevolissimo è poi lo studio che il Taparelli inserì nella stessa sesta dissertazione sull’Etnarchia, in cui presenta l’organizzata comunità dei popoli, quale termine su cui si appunta il progresso politico delle nazioni (Cfr. A. Brucculeri, Un precursore della Società delle nazioni, Roma 1926 - R. Jacquin, L’ordre international d’après Taparelli D’Azeglio nell’opera: Vitoria et Suárez, Contribution des théologiens au droit international moderne, cit.).
• Il concetto cristiano del diritto di guerra lungo il corso dei secoli si è ampliato e schiarito, ma non ha, come parrebbe ad alcuni, subito delle involuzioni. Secondo il Salvioli (II concetto di guerra giusta negli scrittori anteriori a Grozio, Napoli 1918), lo Stratmann (Weltkirche und Weltfriede, cit.), il Vanderpol (La doctrine scolastique du droit de guerre, cit.) ed altri la concezione medievale della giusta guerra conteneva come elemento essenziale la colpabilità morale di una delle parti belligeranti. Nel secolo XVI e giù di lì i moralisti e i canonisti cattolici rigettano questo elemento e non lo considerano più come fondamento del diritto di guerra. Vitoria e Molina sono i due principali rappresentanti di questo nuovo indirizzo. Questa dottrina non è messa in alcuna evidenza da Sant’Agostino. Per lui chi fa il torto è per questo stesso anche moralmente colpevole; quindi egli insiste sul carattere punitivo della guerra, senza proporsi espressamente il problema dell’aspetto esclusivamente oggettivo della colpabilità. Ad ogni modo per Sant’Agostino, come ben nota il Regout, «la guerra non ha il solo scopo di vendicare l’ordine morale (funzione punitiva), ma anche di tutelare, mantenere e raddrizzare l’ordine oggettivo, e più direttamente di proteggere e restaurare i diritti particolari minacciati o violati. Nella guerra difensiva questo ultimo obiettivo si impone assolutamente. Ma nella guerra offensiva il mantenimento dei propri diritti è il fine primordiale. Si consideri, per esempio, come Sant’Agostino cita fra le giuste cause di ricorso alla guerra “il rifiuto di restituire ciò che è stato ingiustamente tolto”, e che gran valore egli attribuisce all’ordo che dispone ogni cosa al suo luogo, sua cuique loca tribuens dispositio » (La doctrine de la guerre juste, cit., p. 44).
• Anche sulla dottrina di San Tommaso possono farsi considerazioni congeneri a queste fatte su Sant’Agostino. Per San Tommaso la giusta guerra suppone una colpa morale, perché secondo una sua teoria generale, il falso giudizio può riportarsi, almeno in causa, ad una colpa morale (De malo, q. 3, a. 7). Perciò considera le eresie come colpevoli (Cfr Summa theol., II-II, q. 10 e 11). Egli, quindi, non si propone mai se la giusta causa della guerra possa essere una semplice colpa giuridica, una materiale violazione del diritto. Non possiamo adunque ammettere che gli scrittori posteriori, come per es. Vitoria e Molina, si siano opposti a San Tommaso sostenendo la teoria che la guerra è giusta anche per riparare un torto obiettivamente ingiusto. Certamente alcuni principii di San Tommaso favoriscono la tesi del Vitoria e del Molina. Così la definizione della giustizia ius suum unicuique tribuere, prescinde dalla colpa morale di chi ha violato la giustizia. Se si dovesse includere la colpabilità morale, non sempre si dovrebbe dare a ciascuno il suo.
• Il Vitoria afferma anch’esso che la guerra offensiva è guerra di sanzione, suppone quindi una colpabilità morale; ma sarebbe mutilare il suo pensiero il credere che questa colpabilità si richieda sempre ed assolutamente. Per lo Stratmann il Vitoria considererebbe la colpa materiale come insufficiente a giustificare la guerra (Weltkirche und Weltfriede, cit., p. 103). Ora ciò non risponde a verità. Notiamo infatti che il Vitoria ammette come giusta causa di guerra la recuperatio dei beni propri, sia o non sia colpevole chi detiene tali beni o li abbia rapiti. Così in un luogo egli scrive che mentre il privato non può riprendere i suoi beni, se è trascorso del tempo, l’autorità pubblica può farlo (De iure belli, ed. cit., 5, p. 386). Qui il repetere res si considera lecito per se stesso, senza alcun riguardo all’idea di punire, e quindi all’idea della colpabilità soggettiva del nemico. Il singolo, dice Vitoria, può impossessarsi di ciò che gli è dovuto dal debitore (Ibidem, 17, p. 392). Qui è evidente che è esclusa la punizione, perché il privato non può punire. Ora se questo principio vitoriano del repetere res, senz’altra ragione punitiva, è ammesso per il privato, con più ragione è ammesso per l’autorità pubblica. Anche il rivendicare un proprio territorio nel Vitoria è considerato come motivo di giusta guerra indipendentemente dallo scopo punitivo e quindi dalla colpa morale (Ibidem, 27, p. 399). D’altronde vi sono nel Vitoria dei testi decisivi, in cui si considera lecita la guerra, anche se si sappia che il nemico è in buona fede. Nel De Indis il Vitoria ammette che gli spagnoli hanno (in forza del diritto di natura) la facoltà di viaggiare, commerciare e soggiornare come tutti gli stranieri fra gli indiani. Se si oppongono gli indiani, possono gli spagnoli fortificarsi e difendersi e guerreggiare. Su di che il Vitoria fa queste osservazioni: «I barbari sono per natura timidi e poco intelligenti... e quindi se spinti dal timore si riuniscono per scacciare o uccidere gli spagnoli, allora a questi sarebbe lecito il difendersi, servato tamen moderamine inculpatae tutelae, ma non sarebbe loro permesso di esercitare altri diritti di guerra; cosicché raggiunta la vittoria e la sicurezza, non potrebbero ucciderli o spogliarli dei beni ed occupare le città, perché in illo casu sunt innocentes et merito timent ut supponimus» (De Indis, 6, p. 359). Come è chiaro, qui appare lecita la guerra, nonostante la riconosciuta buona fede del nemico. Non meno convincente è il seguente testo che è prossimo al precedente. Non est inconveniens quod, cum ex una parte est ius et ex altera ignorantia invincibilis, quod sit bellum iustum ex utraque. E qui il Vitoria adduce l’esempio dei francesi che terrebbero in buona fede la Borgogna; mentre di fatto l’imperatore ha un diritto certo su tale territorio. Può dunque l’imperatore combattere per avere quella provincia che i francesi possono difendere... Ciò va ben considerato, perché sono diversi i diritti di guerra contro gli uomini veramente colpevoli rispetto agli uomini innocenti o ignoranti (De Indis, 6, pp. 359-369, Lione 1557, p. 359).
• Anche questa stessa dottrina che è professata nel trattato De Indis, si trova pure nel De iure belli. Basta segnalare quel luogo in cui il Vitoria fa la questione se possono essere innocenti i soldati che combattono. Egli afferma che non solo i soldati ma anche i sovrani stessi possono essere senza colpa alcuna; come quando hanno fatto una diligente inchiesta ed hanno seguito il consiglio di savie e dotte persone (De iure belli, 59, p. 424). Indi aggiunge: «Ma siccome nessuno dev’essere punito se innocente, in tal caso, benché sia lecito al vincitore tornare in possesso di quanto gli era stato tolto e fare anche dei danni di guerra, tuttavia, siccome non è lecito dopo una vittoria uccidere chicchessia, così non è lecito occupare o estorcere oltre al dovuto dei beni temporali, perché ciò non si potrebbe se non a titolo di punizione, la quale non può essere inflitta a chi è senza colpa» (Et cum nemo debeat sine culpa puniri, in tali casu, quamvis liceat victori recuperare res ablatas et forte impensam belli; tamen, sicut non licet, parta victoria, quemcumque interficere, ita nec ultra iustam satisfactionem occupare nec exigere in rebus temporalibus, quia omnia alia fieri non possunt nisi nomine poenae, quae in innocentes cadere non debent. De iure belli, 59, p. 424.). Com’è chiaro, qui si suppone la cognizione che si combattono degli innocenti. Questa tesi è accolta anche dal Vásquez e soprattutto dal Molina (Cfr. Regout, La doctrine de la guerre juste, cit., pp. 235, 252).
... prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, la scorsa settimana concludevamo accennando - con l’opuscolo SOS «Fuori della Chiesa non c’è salvezza», Giovanni Re - che Dio vuole seriamente e sinceramente l’eterna salvezza di tutti ed a tutti concede i mezzi necessari per giungere alla felicità. Dio, inoltre, non comanda delle cose impossibili. I detrattori vogliono il contrario, dunque le loro conseguenze sono semplicemente e assolutamente false, contrarie agli insegnamenti più elementari della ragione e della fede. Che siano false lo proveremo subito, ma intanto notiamo: se le deduzioni ricavate con rigore logico da un principio sono false, è falso il principio stesso. Nel caso nostro dunque è falso che «chi è veramente in buona fede non si possa salvare». Posto questo, dimostriamo che le conseguenze tratte da questo principio sono false.
• Falsità della prima conseguenza. Prima di tutto è certo che Dio vuole con volontà sincera e seria salvare tutti gli uomini. Come potrebbe avere chiamato all’esistenza tante creature ragionevoli, che portano in sé l’impronta sublime delle Sue divine perfezioni e possiedono un raggio della Sua luce, senza provvederle abbondantemente con generosa e divina bontà e larghezza dei mezzi necessari per raggiungere lo scopo finale, ad esse da Lui assegnato, l’appagamento delle loro più intime e naturali aspirazioni di felicita ? Gesù dice nel Vangelo (Matt., VI, 26 ss.) che egli pensa agli uccellini dell’aria: non conoscono essi il tempo della semina né l’epoca della messe, sono incapaci di prevedere l’avvenire e di provvedersi a tempo, ma il loro Creatore pensa anche per essi al necessario nutrimento. Egli riveste i fiori del campo con tale grazia ed eleganza di tinte e di forme, che nessun re su questa terra vestì mai con tanto splendore. Non può davvero dimenticare e abbandonare a se stesso l’uomo, costituito da Lui signore e re della natura creata irragionevole, arricchito dei Suoi doni soprannaturali più preziosi e destinato alla vita immortale del Cielo. Dio è padre; è il padre nostro per eccellenza, che sta nei cieli, che prova per le Sue creature, specialmente per l’uomo, capolavoro della Sua potenza creatrice, quei sentimenti di amore e di tenerezza che prova un padre terreno, ma elevati al più alto grado. «Tu hai pietà hai tutti, perché tutto puoi... Tu ami tutti gli esseri e nulla aborri di quanto hai fatto» (Sap., XI, 23-24).
• Gesù redentore di tutti. Il segno più evidente del Suo amore e della Sua volontà di salvarli tutti è il dono immensamente prezioso, trascendente ogni nostro concetto e desiderio, che Dio ha fatto al mondo. «Sì, Dio tanto ha amato il mondo, che ha dato il suo Figliuolo unigenito, affinché chiunque in Lui crede non perisca, ma abbia la vita eterna» (Giov., III, 16). E il Figlio di Dio è disceso, dal cielo, «e il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi» (Giov. I, 14); è apparso in mezzo agli uomini come Maestro e Redentore. Gesù è «la vera luce, che illumina ogni uomo che viene nel mondo» (Giov., I, 9). Queste parole non devono restringersi soltanto ad una parte del genere umano, cioè ai credenti, ma debbono estendersi anche agl’infedeli, e intendersi nel loro senso generale, comprendente tutti i singoli uomini in qualsiasi condizione di vita si possano trovare. Gesù è Redentore: per tutti e singoli gli uomini ha assunto la natura umana, ha offerto se stesso come vittima di espiazione e di salvezza al Padre, ha voluto sostenere i più dolorosi tormenti, la morte stessa, versando tutto il Suo preziosissimo Sangue sopra un infame patibolo, come il più vile rifiuto dell’umanità in un abisso senza confini di sofferenze e di umiliazioni. «Egli è la vittima di Propiziazione per i nostri Peccati: e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo» (I Giov., II, 2). «Per tutti è morto il Cristo» (II Cor., V, 15), esclama l’Apostolo San Paolo. E lo stesso Apostolo scrive nella prima lettera a Timoteo (I Tim., II, 4; 5, 10): «Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti si salvino e giungano al conoscimento della verità... È salvatore di tutti gli uomini e specialmente dei credenti».
• A tutti dà i mezzi necessari. Sarebbe per lo meno assurdo pretendere che Dio vuole con volontà seria e operosa la salvezza di tutti gli uomini, se poi non concedesse loro, nelle condizioni particolari di esistenza in cui di fatto si trovano, gli aiuti necessari e sufficienti della Sua grazia perché possano, con la loro libera cooperazione, giungere a salvezza. Sono due fattori, starei per dire, ugualmente necessari, la grazia salvifica di Dio e la libera collaborazione della volontà dell’uomo. Perché, se è vero, secondo l’espressione di Sant’Agostino, che qui creavit te sine te, non salvabit te sine te, è tanto più vero che, privo dell’aiuto divino, da sé l’uomo non può fare nulla per ottenere la salvezza. «Senza di me, voi non Potete far nulla» (Giov., XV, 5). Sarebbe veramente irrisorio il modo di agire di un ricco signore, il quale promettesse ad un povero, bisognoso delle cose più necessarie alla vita, di aiutarlo generosamente nelle sue estreme necessità; e poi si contentasse di dargli solo delle buone parole o degli aiuti, non soltanto ipotetici, ma impossibili ad aversi. Non si potrebbe e si dovrebbe dire altrettanto di Dio, se, protestandosi Egli solennemente di volere la salvezza di tutti, non mettesse alla loro libera disposizione gli aiuti convenienti per raggiungere in realtà la felicità eterna? «A tutti gli uomini, così l’Autore del libro della vocazione delle Genti (L. II, c. 21), la multiforme e ineffabile bontà di Dio ha sempre provveduto e provvede in tale modo, che e nessuno di coloro, che vanno perduti, possa portare come scusa che gli è stato negato il lume della verità, e nessuno possa gloriarsi della sua giustizia».
• È evidente che non uno solo, di coloro che si perdono, potrà davanti al tribunale supremo ed inappellabile di Dio scusarsi, affermando di non aver avuto dalla bontà divina gli aiuti necessari, anzi abbondanti, per potersi salvare, se l’avesse voluto; ma dovrà battersi dolorosamente il petto dicendo il mea culpa. Uno dei motivi, per cui alla fine di questo mondo visibile, si terranno le universali assise del genere umano è appunto questo, perché si possa da tutti constatare che se uno si è perduto eternamente non ne può attribuire la colpa a Dio, come se non avesse ricevuto i mezzi necessari per la salvezza, ma unicamente a se stesso, che non ha corrisposto alla grazia divina sino al termine della vita. Bisogna dunque ammettere che Dio vuole, con volontà sincera ed operosa, la salvezza di tutti gli uomini; è una verità luminosa, come appare da quanto ora abbiamo detto.
• Falsità della seconda conseguenza. Parimenti è certo che Dio non può imporre agli uomini delle leggi e dei precetti impossibili. Condizione prima ed essenziale di una legge giusta è che sia ragionevole, ordinata al bene generale: dev’essere quindi adattata e proporzionata alle comuni possibilità fisiche e morali dei sudditi. Una legge impossibile ad osservarsi non è legge, perché è contraria al concetto stesso di legge. Se il legislatore volesse punire il trasgressore di una pretesa legge siffatta, questi potrebbe con tutta ragione, a capo alto, opporsi e protestare, dicendo che una simile punizione è ingiusta, perché egli era nell’impossibilità di osservarla. Non ci può essere dubbio su questo punto. Dunque Iddio, che è la sapienza, la giustizia e la bontà stessa, non può imporre agli uomini dei precetti per essi impossibili. Ne viene di conseguenza che ogni uomo adulto, in qualsiasi condizione particolare di fatto in cui si può trovare, deve poter compiere, con gli aiuti divini, quanto Dio esige da lui, finché egli per sua colpa non si metta nell’impossibilità morale di poterlo fare. Bisogna dunque conchiudere necessariamente che tutti, anche coloro i quali ignorano invincibilmente la Chiesa, si possono salvare, purché siano uomini di buona fede e di buona volontà, che osservano fedelmente quanto loro viene intimato dalla voce della coscienza onesta e corrispondono e cooperano sinceramente alla grazia. Dio, che vuole la salvezza di tutti, alla cui onnipotenza non mancano i mezzi più efficaci, saprà rimediare alle conseguenze di un’ignoranza non colpevole e fare in modo che possano ottenere la grazia e la salvezza eterna.
• La dottrina della Chiesa. Anche questa è dottrina chiaramente insegnata dalla Chiesa, per mezzo dei Padri e dei Dottori e dei Sommi Pontefici in molti documenti. Segnaliamo tre casi speciali, da cui risulta abbastanza preciso e limpido l’insegnamento della Chiesa.
• Un imperatore. Il Primo caso, che più di qualche volta si verificò, è quello di un catecumeno, il quale studiava e imparava la religione cattolica e si preparava ad entrare nella Chiesa, sospirando il giorno in cui vi sarebbe ammesso, e fu sorpreso dalla morte, senza essere stato visibilmente ricevuto nel seno della Chiesa stessa, per mezzo del battesimo sacramentale. Abbiamo nella storia della Chiesa, nella vita di Sant’Ambrogio, un caso celebre a questo proposito. Il 15 di maggio del 392 il giovane imperatore di Occidente, Valentiniano, a Lione, dove si era recato da breve tempo, fu trovato morto strangolato nel suo letto. Valentiniano non aveva che 20 anni e per le sue magnifiche doti di mente e di cuore faceva presagire che sarebbe stato un grande imperatore. Si era messo sotto la direzione del vescovo di Milano, Ambrogio, che lo amava come figliuolo, e lo guidava con i suoi sapienti consigli per le vie della giustizia e della virtù. Fu perfidamente attirato a Lione nelle Gallie dal conte Arbogasto, che comandava gli eserciti e avrebbe voluto avere la direzione dell’Impero. Dopo qualche tempo, avendo Valentiniano tentato di togliergli il comando, venne in discordia con Arbogasto, che, secondo la voce comune, gli fece togliere la vita. In Italia ed in Gallia nessuno si ingannò, e sotto voce da tutti si indicava l’assassino. Il corpo di Valentiniano fu trasportato a Milano fra il dolore e la commozione universale dei popoli, che amavano il loro giovane imperatore. Valentiniano era morto senza battesimo: egli non era che catecumeno, e sotto la guida di Ambrogio si preparava ad entrare solennemente nella Chiesa, ricevendo il sacramento del battesimo. Sant’Ambrogio rimase per qualche tempo chiuso in un doloroso silenzio per una morte così immatura, e non lo ruppe che dopo due mesi per pronunziare l’orazione funebre di Valentiniano, che gli sgorgò dal cuore, tutta pervasa e vibrante di affettuoso dolore, di coraggio e di dottrina (De obitu Valentiniani, 38, 41, 51-53). Il vescovo, rivolto alle due vergini sorelle di Valentiniano, Giusta e Grata, diceva loro per confortarle: «Il suo esempio è la più ricca eredità che vi abbia lasciato...» e le invitava a unirsi e vivere con lui in comunione di fede, spirituale ed invisibile, sotto lo sguardo di Dio. «Abiti nei vostri cuori, viva dentro di voi, vi stia del continuo sotto gli occhi, nelle labbra, in tutti i pensieri e discorsi. Non avete nulla da temere per lui, dov’egli sia: dimenticatene i mali, ricordatene le virtù... Voi vi rattristate perché il vostro fratello è morto senza battesimo. Ma, ditemi, che altro è in mano nostra se non la volontà e la domanda? Ora egli da tempo e desiderò di essere iniziato, prima di venire in Italia, e mi significò di voler essere battezzato subito dopo da me... Non avrà egli la grazia desiderata e richiesta? Certamente l’ebbe, perché la domandò...». E dopo aver paragonato il catecumeno, che desidera e domanda il battesimo, al martire catecumeno, al quale la morte sopportata per amore di Cristo apre la porta del cielo, così conclude: «Che se i martiri sono stati battezzati nel loro sangue, anch’egli è stato purificato dalla sua pietà e dal suo desiderio». Il voto fervido del battesimo, che include in sé un atto di perfetto amore di Dio, secondo il grande Dottore, aveva purificato dalla colpa il cuore di Valentiniano e gli aveva ottenuto la grazia della giustificazione.
• Un eretico. Secondo caso: Un eretico per nascita, che vive nella sua setta, separato dalla Chiesa Cattolica, e osserva i precetti della legge naturale e della sua religione, oggettivamente falsa, senza aver alcun dubbio fondato intorno alla sua falsità e alla verità della religione cattolica. Egli non dubita positivamente che la sua religione possa essere falsa e che vi sia un’altra religione, con la quale Dio vuole e deve essere onorato. Caso molto frequente, perché anche in mezzo ai protestanti e agli scismatici si trova un gran numero di persone, che vivono una vita onesta, conforme ai dettami della coscienza, e cercano di praticare fedelmente la loro religione, senza dubitare menomamente della sua falsità. Anche costoro, secondo la dottrina della Chiesa, possono appartenere ad essa e giungere alla salvezza. Ecco che cosa insegna a questo proposito Sant’Agostino: «Vi sono degli uomini, che giacciono nell’eresia o nella superstizione del paganesimo. Anche là Dio conosce coloro che gli appartengono; poiché nell’ineffabile prescienza di Dio, molti, che sembrano essere fuori della Chiesa, le appartengono e molti, che sembrano essere dentro la Chiesa, ne sono fuori. È di queste anime, che in una maniera invisibile ed occulta sono nella Chiesa, che si forma il giardino chiuso, la fonte suggellata, la sorgente d’acqua viva, il Paradiso pieno di frutti, dei quali parlano le Sacre Scritture» (De baptismo contra Donat., L. V, 38). E altrove il Santo Dottore afferma chiaramente che si può essere nell’errore, senza conoscerlo come tale, specialmente per coloro, che in esso sono nati e che ricevono con attenta sollecitudine la verità, pronti a lasciare l’errore. «Questi tali, dice Sant’Agostino, non sunt inter haereticos deputandi, non devono essere annoverati tra gli eretici» (Epist. 43, c. 1, n. 1). E per conseguenza bisogna dire che sono membri in qualche modo della Chiesa e possono ottenere la felicità del cielo. Resta bene inteso che questa appartenenza è personale, pur permanendo essi, senza propria colpa, nelle sette di perdizione o false religioni, che sono certamente vie di dannazione e perdizione.
• Un pagano infedele. Cotesta soluzione consolante viene ancora maggiormente accentuata e sviluppata nei Dottori del Medio Evo, quando si propongono un terzo caso, il caso di un infedele, totalmente privo della conoscenza di Gesù Cristo e della verità della Sua religione. Un barbaro, un selvaggio delle foreste vergini del Brasile o delle tribù primitive dell’Africa o delle immense regioni della Cina o del Tibet o di qualsiasi altra nazione, che non ha neppure la più lontana idea della Chiesa Cattolica, e vive secondo quanto gli detta la sua onesta coscienza e gli comanda la sua religione. Già Sant’Agostino, a proposito della salvezza degli infedeli, parlando del santo Giobbe aveva scritto: «Io non ne dubito punto: Dio con l’esempio di Giobbe ha voluto mostrarci che vi potevano essere in tutte le nazioni pagane degli uomini viventi secondo la Sua volontà, amati da Lui ed appartenenti alla Gerusalemme spirituale» (De civitate Dei, L. XVIII, c 47). San Giustino, nella sua prima apologia, mostra che la ragione umana è una fiaccola accesa dal Verbo di Dio, lume increato, sorgente di ogni luce per le intelligenze, e ne trae questa conclusione: «Tutti coloro, che hanno vissuto e vivono secondo ragione, sono cristiani: essi non hanno nulla da temere». Ascoltiamo quanto insegna per riguardo al caso proposto il Dottore angelico, San Tommaso d’Aquino: «Appartiene alla Provvidenza, purché non sia impedita, il provvedere quanto è necessario per la salvezza. Quindi se un infedele, un selvaggio, anche cresciuto nelle foreste, segue i dettami della ragione naturale nel fare il bene e fuggire il male, bisogna tenere per certo che Dio gli rivelerà con una ispirazione interiore quanto si deve credere, oppure gli manderà chi lo istruisca, come inviò una volta Pietro al centurione Cornelio» (De veritate, quaest. 14, a. 11, ad 1). L’insegnamento di San Tommaso, così conforme alla volontà salvifica universale di Dio, fu poi sempre ripetuto in modo esplicito dai Teologi seguenti e applicato agli infedeli, che ignorano invincibilmente la rivelazione cristiana. Questo avvenne particolarmente quando, dopo la scoperta delle Indie e dell’America, la loro attenzione fu richiamata sopra la sorte e le condizioni di tanti infedeli per riguardo alla salvezza eterna.
• E vicino a noi? Il Sommo Pontefice Pio IX nella sua allocuzione concistoriale del 9 dicembre 1854, mentre per una parte riprova solennemente l’indifferentismo di coloro, che si immaginano falsamente che fuori della Chiesa si può ottenere la salvezza, per l’altra parte dichiara espressamente che coloro i quali ignorano invincibilmente la vera religione, non contraggono per questo nessuna colpevolezza davanti a Dio, e che Dio solo può tracciare i limiti esatti di questa ignoranza, secondo la molteplice varietà dei popoli, dell’ambiente e dei caratteri (Denzinger Bannwart, 1647). Questo insegnamento è ripetuto e svolto più ampiamente con termini ancora più precisi e più chiari dallo stesso Pio IX nella sua lettera ai vescovi d’Italia del 10 agosto 1863 (Denzinger Bannwart, n. 1677). È bene riportare le sue parole: «È noto a noi e a voi che coloro, i quali si trovano in uno stato di ignoranza invincibile per riguardo della nostra santissima religione, e che, osservando con diligenza la legge naturale e i suoi precetti, scritti nei cuori di tutti, pronti ad ubbidire a Dio, menano una vita onesta e retta, possono, con l’aiuto efficace della luce e della grazia divina, conseguire la vita eterna. Poiché Dio, che vede pienamente e scruta e conosce le menti e gli animi e i pensieri e le condizioni di tutti, per la sua somma bontà e clemenza, non permette che sia punito con gli eterni supplizi, chi non è reo di grave colpa volontaria».
• Concludiamo: il secondo principio. È dunque certissimo: Tutti gli uomini di buona fede e di buona volontà si possono salvare. È questo l’insegnamento autentico della Chiesa. Ci si potrebbe domandare se in concreto esista, nei casi individuali, questa buona fede e buona volontà. La risposta bisogna ricavarla da molti dati e circostanze di fatto. «Il problema della responsabilità o colpevolezza morale essendo necessariamente una questione individuale, non si può applicare a tutte le intelligenze, a tutti i tempi, a tutte le regioni, a tutti gli ambienti, una misura uniforme. Ma si deve cercare di dare un giudizio particolare per ogni caso individuale, tenendo conto dello stato abituale della coscienza di ciascuno e delle cause interne ed esterne, che possono turbarla o falsarla, e tenendo anche conto della facilità o delle difficoltà particolari, che ogni individuo può incontrare per l’acquisto della conoscenza religiosa, che è obbligato ad avere. Bisognerà quindi guardarsi da ogni generalizzazione temeraria riguardante una regione, un popolo o tutta una categoria di persone, come dice Pio IX nell’allocuzione, che abbiamo poco innanzi citata. Già il celebre teologo Francesco Suarez (De fide, Disp. XVII, sect. 2, n. 6 ss.), parlando in un tempo e in una nazione, dove la fede cattolica regnava sovrana, pensava che anche in un tale ambiente potevano esservi di fatto degli eretici o degli infedeli, viventi all’infuori di ogni influenza cristiana, senza provare alcun dubbio intorno alla verità della loro religione» (Dictionnaire de Théologie catholique, T. IV, col 2167).
• Consolanti speranze. Perché non si potrà parimenti dire che in mezzo all’immensa massa di uomini, lontani dalla vera religione, non vi siano molti uomini di buona fede e di buona volontà? Dio ha i suoi servi fedeli dappertutto e in ogni tempo. L’Autore dell’Opuscolo riferisce che ebbe occasione d’intrattenersi con due missionari tornati per qualche tempo in Europa dopo essere stati lungo tempo tra gli Indiani, professori in una scuola superiore cattolica. Conoscevano a perfezione le condizioni, il loro stato d’animo. Interrogati se fossero molti gli indiani in buona fede e in buona coscienza, risposero che su tale questione non vi poteva essere dubbio alcuno, specialmente per la massa del popolo, in modo particolare delle campagne. È certo anche che molti di costoro, che non appartengono alla Chiesa cattolica, specialmente infedeli, per ragione dell’ambiente in cui vivono, si trovano spesso in uno stato di profonda ignoranza, di barbarie e di abbrutimento, di pregiudizi inveterati ed hanno perciò la coscienza ottusa e indurita e spesso a stento sanno distinguere il bene dal male nelle cose più importanti. Di alcuni in casi particolare si può, con tutta probabilità, asserire che siano quasi ancora in uno stato d’infanzia. Lo stato d’infanzia molte volte può essere tale che coloro i quali si trovano in cotesta condizione né sono capaci di peccare mortalmente, né di fare un atto di fede in Dio esistente e rimuneratore e un atto di carità o di contrizione perfetta. Costoro devono quindi considerarsi come i bambini, che muoiono privi di battesimo, prima di avere l’uso di ragione. Avendo solo il peccato originale, contratto con la stessa generazione, secondo la comune sentenza dei Teologi, essi, dopo morte, non hanno nulla da soffrire, anzi godono quella felicità, che si godrebbe nello stato di pura natura. Per essi, come asserisce San Tommaso d’Aquino, anche in simile condizione, sarà sempre meglio aver avuto l’esistenza che non essere mai esistiti. Praticamente essi vanno al Limbo eterno.
• Come si conciliano i due principii: Fuori della Chiesa non c’è salvezza, e: Tutti gli uomini di buona fede si possono salvare. Le due verità ora dimostrate non possono evidentemente essere incompatibili, benché a primo aspetto sembri molto difficile il poterle conciliare. In che modo? Ecco la risposta. Alla Chiesa cattolica, che è l’unica arca di salvezza, si può appartenere anche senza un legame visibile. È la teoria già abbozzata dai Padri e Dottori della Chiesa, svolta poi ampiamente da Teologi. Bisogna distinguere il corpo e l’anima della Chiesa (il collettivo umano e il Corpo mistico). Per ben comprenderla è assai utile compendiare in breve sintesi l’opera redentrice di Gesù Cristo. Il Verbo eterno è disceso dal cielo per redimere l’umanità, che nel suo capo Adamo col peccato aveva rovesciato il primitivo disegno di amore di Dio, e redintegrarla in quei beni soprannaturali, che il Signore le aveva concessi. Gesù, vero Dio e vero uomo, capo e rappresentante del genere umano, secondo Adamo, con la Sua morte e risurrezione ha vinto tutti i Suoi nemici, ha redento l’uomo, lo ha pacificato con Dio, ridonandogli la vita soprannaturale della grazia. Egli è capo dell’umanità redenta; è il centro a cui tutto deve convergere; è la sorgente inesauribile della grazia meritataci col Suo Sangue; e solo da Lui noi possiamo e dobbiamo ricevere la vita della grazia, a cui Dio ci ha chiamato nel Suo eterno disegno di ammirabile bontà. Ora Gesù, dovendo salire al cielo ha fondato la Chiesa affidandole la missione, da lui ricevuta dal Padre, di reggere, di istruire, di santificare e salvare gli uomini.
• La Chiesa è Gesù vivente. La Chiesa è il capolavoro di Gesù Cristo. Secondo la sua più giusta e profonda concezione, come si è sopra accennato, è la continuazione e il prolungamento di Gesù Cristo in terra, perché alla Sua Chiesa Gesù ha dato i Suoi divini poteri. È talmente unita con Gesù Cristo e possiede i tesori della Sua grazia, che noi possiamo dire che la Chiesa è Gesù Cristo vivente attraverso i secoli. San Paolo ce la presenta sotto la magnifica immagine di un edificio, fondato sugli Apostoli, del quale Gesù Cristo è la pietra angolare (Efes., II, 19-22). «Sopra di lui tutto l’intero edificio si innalza ben connesso in tempio santo di Dio». «O celeste città di Gerusalemme, dice la Liturgia (Inno della Dedicazione della Chiesa a vespro), beata visione di pace, che fabbricata di pietre viventi ti elevi sublime sino agli astri».
• ... è il suo corpo mistico. Un’altra immagine ritorna spesso nelle lettere dell’Apostolo Paolo, ancora più espressiva, perché ci fa approfondire le relazioni intime di vita intercedenti fra Gesù Cristo e i fedeli: la Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo: Gesù ne è il capo e i fedeli sono i membri viventi di questo corpo morale. Come nel corpo umano il capo è la parte più eminente e il centro della vita; così Gesù nel corpo della Chiesa ha ogni primato su tutte le cose, di dignità, di autorità e di vita divina. Da Lui solo deriva la vita della grazia, che per mezzo dei sacramenti, del sacrificio, della preghiera si diffonde in tutto il corpo, e che produce la figliolanza e l’amicizia di Dio, il diritto alla sua eredità ed apre le porte del cielo. Per poter raggiungere la vita della grazia e raggiungere la vita della gloria è necessario assolutamente appartenere al corpo mistico di Gesù Cristo.
• Corpo ed anima della Chiesa. Ma nella Chiesa bisogna distinguere, come dissi, il corpo visibile e l’anima. Il corpo della Chiesa è la società visibile dei fedeli, che hanno ricevuto il sacramento del battesimo e sono in comunione con la legittima gerarchia, professano esternamente la fede cattolica e partecipano ai sacramenti. L’anima della Chiesa è la società invisibile di tutte le anime in stato di grazia, abbiano o no ricevuto il battesimo sacramentale, siano o no congiunte visibilmente con la gerarchia ecclesiastica. Quanti possiedono in qualsiasi modo la grazia e la figliolanza di Dio appartengono all’anima della Chiesa, a Gesù Cristo, da cui solo ricevono la vita soprannaturale.
• Condizione normale di salvezza. La condizione normale ordinaria, stabilita da Gesù Cristo, per salvarsi, è che si appartenga e al corpo e all’anima della Chiesa: «Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvato». Colui pertanto che non possiede la grazia, benché sia membro della società visibile, che è la Chiesa, se muore in tale stato, non si può salvare. Finché egli non rinunzia alla propria fede e non fa pubblica professione di apostasia, finché non altera scientemente e ostinatamente i dogmi sacri, che bisogna credere, o finché non si ribella apertamente contro l’autorità legittima, alla quale ogni cristiano deve ubbidire, rimane ancora la fede. Rimangono ancora i vincoli esterni, che lo congiungono al corpo della Chiesa, alla Chiesa visibile, all’edificio di Gesù Cristo. Ma non c’è il vincolo intimo, essenziale della grazia, che l’unisce all’anima della Chiesa. Non è ancora un tralcio totalmente staccato dall’albero della vita, ma è un tralcio secco, non più percorso dalla linfa vitale della grazia. È un tralcio secco, ancora congiunto al tronco, e che può essere nuovamente avvivato dalla grazia di Dio. Non basta quindi per giungere alla felicità del cielo appartenere al corpo visibile della Chiesa; ma è necessario anche appartenere all’anima della Chiesa, per mezzo della grazia santificante. Senza la carità, senza la grazia santificante, dice l’Apostolo San Paolo, anche i doni più straordinari non valgono nulla davanti a Dio. «Quando pure io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho la carità, sono come un bronzo sonante o un cembalo squillante. E se avessi la profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e se avessi tutta la fede fino a trasportare i monti, se non ho la carità, non sono nulla. E se distribuissi ai Poveri tutti i miei averi, e dessi il mio corpo ad essere bruciato, se non ho la carità, tutto ciò non mi serve a niente» (I Cor., 13, 1-3). Quanti cristiani dolorosamente vivono abitualmente privi della grazia di Dio e non appartengono all’anima della Chiesa, e si espongono ad evidente pericolo di perdersi eternamente! «Chi non rimane in me, è gettato via come il tralcio e si dissecca, e raccoltolo lo si butta nel fuoco e brucia» (Giov., 15, 6). Per la stessa ragione colui che ha riconosciuto la verità della Chiesa cattolica, e potendolo fare, ricusa per sua colpa di abbracciarla, ed anche colui, che, dubitando positivamente della verità della sua religione, per sua grave negligenza, non si cura di cercare la verità, non si possono salvare. Essi infatti, unicamente per loro colpa, rifiutano di entrare nella Chiesa visibile e di appartenere al corpo della Chiesa.
• Condizione eccezionale. Condizione essenziale, assolutamente necessaria per potersi salvare, quando per qualsiasi ragione, senza propria colpa, non si può entrare nella Chiesa, è appartenere almeno all’anima della Chiesa. Nessuno si può salvare, se non è amico e figlio di Dio, se non possiede di fatto la grazia santificante. È necessità di mezzo, senza eccezione. Bisogna però dire che non è difficile appartenere all’anima della Chiesa per chi si trova nell’impossibilità di appartenere anche al corpo della Chiesa stessa. Ci vuole innanzi tutto un atto di fede soprannaturale nelle verità strettamente necessarie a credersi per salvarsi, cioè almeno che Dio esiste e che è rimuneratore dei buoni e giusto punitore dei cattivi (Ebrei XI, 6). Questo atto di fede, con l’aiuto della grazia, è accessibile ad ogni adulto, per quanto egli non abbia il mezzo di ascoltare la predicazione viva della divina parola e di conoscere l’obbligo della fede. Chi non sa che questa verità dell’esistenza di Dio rimuneratore si trova, per una straordinaria e benevola provvidenza, nel credo di tutti i popoli, anche più barbari, come un residuo della primitiva tradizione? Chi non sa anche che Dio è un buon padre, che a tutti offre le Sue buone ispirazioni e illustrazioni alla mente e impulsi alla volontà, perché possano credere? Come è assolutamente necessario l’atto di fede soprannaturale nella verità di un Dio rimuneratore, è altrettanto indispensabile un atto di carità o di contrizione perfetta. È l’unico mezzo per ottenere la grazia di Dio per gl’infedeli e per molti protestanti e scismatici. Infatti conoscendo Dio, essere supremo e perfettissimo, essi per un impulso superiore possono anche rivolgersi a Lui con un atto di carità o contrizione perfetta, amandolo sopra ogni cosa, come sommo bene. Con questo atto di carità, che è implicito anche nella contrizione, essi di fatto rinunciano a quanto si oppone all’amicizia di Dio, si dispongono ad unirsi a Lui e così acquistano la Sua grazia e diventano suoi figli. «Colui che mi ama, sarà amato dal Padre mio ed io l’amerò e mi manifesterò a lui... Se uno mi ama... il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e in lui faremo dimora», ha detto Gesù nel discorso della Cena (Giov., XIV, 21-23).
• Battesimo di desiderio. È questo il cosiddetto battesimo di desiderio. Come vi è un battesimo di sangue, perché chi, sacrificando la vita per Gesù Cristo, gli dà il segno supremo di amore, e, anche non avendo ricevuto il battesimo sacramentale, viene con questo stesso giustificato ed ammesso alla felicità del cielo; così vi e un battesimo di desiderio, cioè l’atto di perfetto amore di Dio o di contrizione perfetta. I non cattolici e gli infedeli, con questo atto di carità, acquistano la grazia santificante, appartengono all’anima della Chiesa e contraggono anche una qualche relazione col corpo della Chiesa stessa. Essi infatti, così facendo, protestano a Dio, in maniera esplicita e formale, che sono fermamente decisi di fare quanto Egli comanda per poterlo a-mare e possedere; sono pronti — come dice il Sommo Pontefice Pio IX — ad ubbidire a Dio. E poiché in realtà Dio ha stabilito che per salvarsi è necessario ricevere il sacramento del battesimo e diventare membri della Chiesa visibile, con quell’atto di carità, implicitamente essi si dicono pronti a compiere queste condizioni, appena ne venissero a conoscenza e lo potessero fare. Se dunque un protestante o uno scismatico o un infedele, così disposto, conoscesse che l’unica vera religione, l’unica vera Chiesa è soltanto la Chiesa cattolica romana, immediatamente, in virtù di quella disposizione di ubbidire in tutto a Dio, rinunzierebbe ai suoi errori e abbraccerebbe il cattolicesimo. Per gli uomini, che non penetrano con lo sguardo della mente nei cuori e non possono conoscere le intenzioni, ma giudicano di esse soltanto da segni esterni, il desiderio implicito di farsi cattolico non è la stessa cosa che farsi cattolico in realtà. Ma Dio, che legge nelle menti e nei cuori, vede quel desiderio sincero del battesimo e della Chiesa, che rimane inefficace unicamente per ignoranza non colpevole, e considera quelle anime come appartenenti alla sua Chiesa.
• Risposte al problema iniziale. Possono adunque salvarsi i protestanti e gli scismatici? Non c’è dubbio, se sono in buona fede ed hanno buona volontà. Per gli scismatici e in alcune sette protestanti, il battesimo è valido e i bambini che muoiono prima di perdere l’innocenza battesimale appartengono alla Chiesa ed hanno diritto al Paradiso a titolo di eredità. Gli adulti protestanti, i quali o non avessero ricevuto validamente il battesimo o disgraziatamente, dopo il battesimo, avessero perduto la grazia santificante, possono riacquistarla, come ora si è detto, con un atto di carità o di contrizione perfetta, che certamente per essi è molto più facile che non per gli infedeli. Gli adulti scismatici, che, dopo il battesimo hanno commesso un peccato grave ed hanno così perduto la grazia di Dio, possono riaverla o con la contrizione perfetta od anche, almeno in punto di morte, con la confessione: perché fra gli scismatici (non tutti) le ordinazioni sono valide, vi è il vero sacerdozio, e almeno in pencolo di morte, ogni sacerdote, anche scismatico, può assolvere dai peccati. Anche gli infedeli possono salvarsi, perché, come or ora si è detto, possono fare con la grazia divina un atto di fede soprannaturale nelle verità necessarie a credersi e un atto di carità o di contrizione perfetta e così appartenere all’anima della Chiesa. Dio è largo a tutti delle Sue grazie onnipotenti, delle Sue ispirazioni e impulsi interiori al bene, particolarmente poi nelle ore estreme della vita. Sant’Agostino dice ben a ragione (De vera religione, 46): «Ciò che Dio opera con i singoli uomini, lo conosce Dio operante e quegli stessi, nei quali avviene l’azione divina. Quello poi che Dio opera nel genere umano, ha voluto che fosse ricordato per mezzo della storia e della profezia».
• La conferma dei fatti. Vi sono dei fatti mirabili storicamente certi, dai quali appare con evidenza l’efficacia onnipotente della grazia di Dio, specialmente negli ultimi momenti poco prima della morte. Credo bene di riportare un fatto, che si legge nelle memorie del venerabile P. Giuseppe Anchieta S. J., Apostolo del Brasile, e che conferma mirabilmente quanto ora si è detto (Patrignani, Menologio della Compagnia di Gesù, T. II, s. 50)
• Il Venerabile P. Anchieta. Lo zelo di guadagnare anime a Dio spinse il P. Anchieta ad uscire dalla città e ad avventurarsi in regioni ancora incolte e impervie, abitate dagli indigeni. Un giorno entrò egli da solo in una selva e scoprì da lontano un vecchio, appoggiato ad un alberò. Avvicinatosi a lui, dopo alcune domande, comprese che la divina Provvidenza l’aveva colà guidato per sua salvezza. Trovò che era sempre vissuto secondo i dettami della coscienza onesta, senza aver mai trasgredito in nessun punto la legge naturale, e che col solo lume naturale comprendeva molte verità riguardanti la esistenza di Dio, l’immortalità dell’anima, la bellezza della virtù e simili. Dopo averlo istruito a sufficienza intorno ai misteri principali della fede, raccolse un poco d’acqua piovana dalle foglie di alcuni cardi selvatici e con quella lo battezzò. Allora il buon vecchio, pieno di santa gioia, ringraziò la divina bontà e il Padre Anchieta del beneficio ricevuto, e breve tempo dopo morì tra le braccia del suo benefattore. Dio ha mandato il P. Anchieta, come un angelo visibile del cielo; volle che si verificasse in questo avvenimento mirabile quanto dice San Tommaso, cioè che il Signore interviene, quando sia necessario, in modo anche del tutto eccezionale. Ma anche se non gliel’avesse mandato, non c’è nessun dubbio che Dio avrebbe aiutato quel vecchio a fare un atto di carità o di contrizione perfetta; anzi si può essere certi che già l’avesse fatto. Perché, secondo una dottrina comunemente insegnata dai Teologi, nessuno può evitare per un tempo notevole il peccato mortale, senza la grazia santificante, e quel buon vecchio non aveva mai durante la vita trasgredito la legge naturale.
• ... e il Santo Curato d’Ars. Nella vita del Santo Curato d’Ars si leggono altri due fatti, veramente straordinari, riguardanti non eretici o infedeli, ma persone dominate dall’indifferentismo e dal razionalismo, completamente areligiose. Una pia signora aveva uno sposo lontano da molti e molti anni da ogni idea di religione, e pregava molto per la sua conversione, sempre trepida che un’avanzata malattia di cuore non glielo rapisse improvvisamente. Venerava con amore filiale una devota statua della Madonna, che teneva in casa, e il marito talvolta le recava dei fiori, sapendo a quale scopo erano destinati. Com’essa temeva, improvvisamente la morte lo colpì, senza che potesse ricevere i sacramenti e desse segno alcuno di pentimento. Il dolore della signora fu tanto, che ne ammalò e sembrò impazzire. Dal suo lontano paese si recò ad Ars per cercare un po’ di conforto. E il santo curato, che mai l’aveva veduta né conosciuta, al primo incontro le disse: Signora, non vi ricordate dei mazzi di fiori, che offrivate alla Santa Vergine? Queste parole, che le furono dapprima di meraviglia, formarono la sua consolazione e la rassicurarono per la sorte del marito. Un fatto simile avvenne ad un’altra signora. Recatasi ad Ars nel 1855 o 1856, quasi unicamente per caso o per distrarsi, vi giunse verso le 11 del mattino. Il santo curato, ancora rivestito della cotta, usciva allora dalla chiesa; attraversò la folla, si diresse verso la signora vestita a lutto, che, ad esempio degli altri pellegrini si era inginocchiata, e le sussurrò sommessamente all’orecchio: «Egli è salvo!». La sconosciuta ebbe un sussulto, ma il curato di nuovo le ripeté: «È salvo». Fece essa un atto di incredulità. Allora il santo, scandendo le parole, soggiunse: «Vi dico che è salvo, si trova in Purgatorio e si deve pregare per lui. Tra il parapetto del ponte e l’acqua ha avuto il tempo di fare un atto di contrizione. È la Santa Vergine, che gli ottenne questa grazia; ricordate le devozioni del mese di maggio nella vostra camera, alle quali si è unito qualche volta, benché irreligioso, vostro marito. Questo gli ha meritato il perdono». La parola del santo consolò quella povera signora, che non trovava pace per la tragica morte del marito annegatosi con suicidio volontario. Dio opera divinamente ed è sempre largo delle Sue grazie con tutti gli uomini. Si può dunque avere una fondata speranza che molti non cattolici e infedeli appartengano all’anima della Chiesa e ottengano la salvezza eterna.
• Ricordiamo però che è un beneficio segnalato essere membri viventi della Chiesa Cattolica e potersi valere dei grandi mezzi di grazia, che essa possiede e mette a disposizione dei suoi figli. Avendo avuto dalla bontà misericorde di Dio un dono così prezioso, per debito di riconoscenza, mentre dobbiamo ringraziarlo e mettere a frutto i tesori da Lui ricevuti, dobbiamo anche cooperare attivamente con Gesù Cristo per condurre molte anime al Suo regno visibile, che è la Chiesa cattolica. (L’ecumenismo è un ostacolo irriducibile a condurre le anime alla vera Chiesa). Ecco, pertanto, come si possono e si devono conciliare i due principii sopra esposti: Fuori della Chiesa non c’è salvezza: Tutti gli uomini di buona fede e di buona volontà si possono salvare.
• Conclusione. Da quanto abbiamo sinora detto, fondandoci sopra documenti e testimonianze di primo ordine, evidenti ed inoppugnabili, appare chiaramente quale sia il vero significato del principio: Fuori della Chiesa non c’è salvezza. Dogma di fede definito, che tutti i figli della Chiesa devono credere. E non meno chiaramente appare quanto siano vane e insussistenti e calunniose le accuse lanciate astiosamente contro la Chiesa dai suoi rabbiosi nemici, che gridano alla sua intolleranza e condannano le sue dottrine come disumane, crudeli e mostruose. Prima di essere accusatori implacabili e giudici inesorabili, dovrebbero istruirsi e studiare bene la causa, con lealtà e sincerità, con buona fede, col desiderio di conoscere la verità e non lasciarsi guidare da pregiudizi inveterati e dall’odio velenoso contro il Papato, contro la Chiesa, e contro il Suo divino Fondatore e Capo. Dovrebbero piuttosto rivolgere lo sguardo alle loro sette e conventicole e alle dottrine da esse esplicitamente e pubblicamente proclamate, che hanno ricevuto dai loro fondatori, e che tutti possono leggere facilmente nei loro scritti. E se hanno ancora un po’ di pudore, dovrebbero chiudersi in un assoluto silenzio. Dice il proverbio: Chi ha la casa di vetro, non scagli sassi contro la casa del suo vicino. Perché i dogmi barbari e crudeli non sono insegnati dalla Chiesa di Gesù Cristo, che ne possiede la celeste dottrina, piena di bontà e di amore, ma sono insegnati soprattutto dai corifei del Protestantesimo. È bene riportare almeno qualche citazione.
• Ecco quanto scrive Lutero (De servo arbitrio, Jena, T. III, pp. 199, 176, 274): «Le anime pie, che fanno il bene per guadagnare il regno dei cieli, non vi giungeranno mai: bisogna contarle fra gli empi. La suprema perfezione della fede è credere che Dio è giusto, benché di sua volontà ci renda necessariamente dannevoli. Dio ci deve piacere anche quando condanna degli innocenti». Non meno blasfemo e crudele è quanto scrive Calvino (Inst. chrèt., L. III, c. 2, n. 5; c. 23, n. 6): «Gli uomini non sono nati tutti per lo stesso fine: gli uni sono predestinanti alla vita eterna, gli altri all’eterna dannazione. Questi ultimi non possono in alcun modo salvarsi. Dio li condanna agli eterni supplizi, indipendentemente dai loro sforzi, affinché la sua giustizia sia glorificata dalla loro dannazione». Giansenio nel suo libro Augustinus, fa eco agl’insegnamenti ributtanti e sconfortanti di Lutero e di Calvino e scrive (Proposizioni condannate dal S. P. Innocenzo X): «Vi sono dei comandamenti che i giusti non possono osservare quando vogliono, perché non è data loro la grazia necessaria».
• La Chiesa, a cui Gesù Cristo ha affidato il sacro deposito della sua dottrina, e ne ha ricevuto il carisma di maestra infallibile di verità, ha condannato tutte coteste false e orribili dottrine, come condannerà sempre l’errore sotto qualsiasi forma si possa nascondere e mascherare. Seguendo con umile ossequio e sottomissione i suoi insegnamenti, i suoi figli hanno la certezza e la fortuna invidiabile di camminare sempre fra gli splendori della verità.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, problema gravissimo, veramente assillante è quello della salvezza di tanti uomini, eretici ed infedeli: una moltitudine sterminata, che non appartiene alla Chiesa Cattolica. Gettando lo sguardo sopra una carta geografica, del mondo, bisogna constatare con dolore che le regioni illuminate dal sole benefico della fede sono una piccola verde oasi in mezzo ad un immenso deserto di tante false regioni, ancora immerse nelle più fitte tenebre dell’errore e dell’idolatria. Nonostante il lavoro continuo e logorante e i sacrifici sovrumani di tanti missionari di Gesù Cristo, che si affaticavano con generoso entusiasmo e con vero eroismo per la diffusione del santo Vangelo, vi sono ancora numerose nazioni quasi interamente lontane dalla fede. Molte altre sono quelle nazioni, ex cattoliche, che professano il modernismo, ovvero una sorta di ateismo, più o meno marcato, dietro la nominale etichetta di Cattolicesimo. Ci riferiamo a tutte quelle nazioni che hanno abbracciato il cappio di Giuda: attingendo a quell’infausta ed immonda fonte che fu il “concilio” Vaticano Secondo.
• Ma chi è fuori dalla Chiesa? Perché fuori dalla Chiesa non c’è salvezza? In che senso? Utilizzeremo un prezioso opuscolo SOS di Giovanni Re per approfondire l’argomento. Prima della mostruosa “svolta conciliare”, che di fatto ha prodotto centinaia di milioni di atei e di professanti eresie, Mons. Celso Costantini, Segretario della Congregazione di Propaganda Fide, in una Conferenza tenuta il 21 ottobre 1938, in preparazione alla giornata missionaria mondiale, facendo un bilancio consuntivo dell opera di evangelizzazione all’anno 1938, dichiarava: «Se noi mettiamo insieme i “cristiani” di tutte le confessioni (cattolici, ortodossi, protestanti, ecc.) dobbiamo constatare che, dopo duemila anni dal messaggio evangelico, solo un terzo dell’umanità è cristiano. I cattolici, poi, da soli sono 375 milioni di fronte ad un miliardo e 230 milioni di infedeli... Per rendere più evidente la significazione della statistica, restringiamo un momento il quadro. Se ci riferiamo all’Asia, le missioni stabilite nell’India, Siam, Indocina, Cina, Giappone e Corea abbracciano complessivamente 950 milioni di uomini, che presto toccheranno il miliardo. Si tratta di circa mezza umanità. In mezzo a questa immensa massa pagana lavorano ininterrottamente, da tre secoli, i Missionari cattolici. Ma non sono riusciti a raccogliere che una messe esigua: 9 milioni e 195 mila cattolici. Presentemente nei territori ora ricordati lavorano 11.759 Missionari, senza contare le suore, i catechisti, ecc. Nell’esercizio 1936-37 si sono avuti in questi territori complessivamente 153.767 conversioni. Volgiamo ora gli occhi all Africa, che è ravvivata da un soffio di Pentecoste... La situazione statistica di oggidì è la seguente: circa 9 milioni di cattolici contro 150 milioni di infedeli. In Africa si è sul buon cammino, ma quanto lontana apparisce ancora la meta!». Bei periodi quelli di Mons. Celso Costantini, quando l’eresia era chiamata eresia; quando l’ecumenismo era considerato, a ragione, apostasia; quando esistevano i Missionari; quando la loro missione era quella di convertire gli eretici, gli scismatici, gli infedeli e i giudei.
• Molti presero pretesto per gridare all’intolleranza di Mons. Costantini: «Se vi fosse una religione sulla terra, ha scritto Rousseau (Emilio, Professione di fede del curato savoiardo), fuori della quale non ci fosse che pena eterna, e in qualche parte del mondo un solo mortale in buona fede, che non fosse stato colpito dalla sua evidenza, il Dio di una siffatta religione sarebbe il più iniquo e crudele tiranno». E nel Contratto sociale (L. IV, c. 8) egli domanda che sia bandito chi osa pronunziare la massima: Fuori della Chiesa non c’è salvezza. La Revue Chrétienne, rivista protestante di Parigi, la definisce senz’altro bestemmia mostruosa (Revue chrétienne, 1892, II, 409). Per Rousseau e per altri, che come lui pensano e sentenziano, tutte le religioni sono buone per dare il debito culto a Dio. Errore gravissimo questo principio, proclamato e praticato dall’indifferentismo religioso: Siamo liberi di pensare intorno a Dio ciò che vogliamo e di onorarlo come ci piace. Errore derivante da un’immensa superbia, che vuole fare a meno di Dio e ricusa di ubbidirGli.
• Indifferentismo religioso. E chi può negare a Dio il potere di rivelare all’uomo delle verità più alte e più perfette, superiori alla luce della ragione, e il diritto di domandargli di essere onorato con quel culto e in quel modo che Egli vuole? E, se Dio si è degnato di dare all’uomo la Rivelazione, non è forse evidente il dovere dell’uomo, che è creatura, in tutto e sempre dipendente da Dio, di indagare e di cercare di conoscere questa Rivelazione, quando gli consti in qualche modo che Dio ha parlato? Difendere e praticare l’indifferentismo religioso è un oltraggio gravissimo, che l’uomo superbo fa a Dio, è un atto di ribellione, simile a quello degli angeli ribelli, è un atto contrario alla ragione, che ci intima di ubbidire con umile sottomissione a Dio e di tendere con seria e deliberata volontà alla nostra felicità suprema. E quando consta positivamente, sicuramente, che Dio è intervenuto nella vita religiosa dell’umanità con la Rivelazione, è sommamente irragionevole e temerario affermare e pretendere che l’uomo è libero di tenerne conto o no, di onorare Dio nel modo da Lui voluto o no, ovvero di onorarlo in altro modo da quello stabilito da Dio.
• Tutte le religioni sono buone? (Ovvero la dottrina del Vaticano Secondo) Tutte le religioni sono buone?! Errore gravissimo, intollerabile, sommamente offensivo di Dio che è Creatore e Signore di tutte le cose. Come se le varie religioni, che sono tra loro contraddittorie e insegnano l’opposto una dell’altra, potessero essere simultaneamente vere; e come se Dio, che è la verità, la sapienza e la santità essenziale, potesse ugualmente approvare e gradire ciò che è vero e ciò che è falso: la sublime purezza, la verginità cristiana, come le infamie dei pagani e le superstizioni di altre religioni!
• Un altro eccesso. Vi possono essere per altra parte alcuni, e vi sono realmente stati, che, spiegando troppo rigidamente il principio: fuori della Chiesa non ce salvezza, erigendosi a giudici severi ed implacabili, condannano — senza quasi provare un intimo fremito di commiserazione — all’eterna perdizione quanti non hanno la fortuna di appartenere alla Chiesa visibile di Gesù Cristo. Ben diversa è la dottrina della Chiesa, insegnata in modo autentico dai Concilii, dai Sommi Pontefici e dai più eminenti Dottori e Teologi. Cercheremo di esporla con ordine e chiarezza, fondandoci sopra le migliori e più autorevoli testimonianze, affinché si possa avere — in argomento così importante e delicato — un’idea chiara e precisa di quanto la Chiesa insegna col suo magistero.
• I limiti della presente questione. Dobbiamo quindi distinguere bene varie questioni, connesse al problema che studiamo: a) non si tratta qui di dimostrare che la salvezza eterna ci è data solo da Gesù Cristo, il quale parlò ed operò con autorità divina, essendo il Figlio di Dio umanato, Dio-Uomo; b) neppure si tratta di dimostrare che l’unica vera religione è quella insegnata da Lui, e che, per mantenerla intatta, Egli fondò la sua Chiesa visibile, alla quale ha affidato la missione, il diritto e il dovere di governare, di istruire e santificare i suoi fedeli e di guidarli alla salvezza; c) e nemmeno si tratta qui di provare che la Chiesa di Gesù Cristo vive perenne, e si perpetua unicamente nella Chiesa Cattolica, e quindi non nelle religioni protestanti o sedicenti ortodosse. Queste verità vengono dimostrate con evidenza di argomenti teologici, e qui noi supponiamo che il lettore ne abbia già sufficiente conoscenza (Supponiamo, quindi, che il lettore abbia almeno un’infarinatura dei principii cristiani da terza elementare). Fondandoci su queste basi di verità sicure vogliamo cercare, come abbiamo detto poco fa, quale sia il senso esatto da attribuire al principio: Fuori della Chiesa non c’è salvezza; vogliamo esporre il senso che la Chiesa Cattolica stessa attribuisce a questa formola.
• Intendiamo in questo breve lavoro di limitare la nostra trattazione alla salvezza eterna degli adulti e non dei bambini (che muoiono senza battesimo, prima di aver raggiunto l’uso di ragione), perché tale problema esigerebbe trattazione speciale (ne abbiamo già parlato approfonditamente su Sursum Corda a proposito del Limbo). A questo riguardo scrive il P. A. Taverna: «La condizione dei bambini privi dell’uso di ragione differisce da quella degli adulti, perché, non essendo in grado di provvedere a se stessi, anche secondo la naturale loro condizione, la loro sorte dipende dalla cura di altri uomini. Si deve pure notare che, se essi perdono la beatitudine soprannaturale, che è beneficio indebito, tuttavia, poiché non hanno colpa personale, non soltanto non incorrono — secondo il parere comunissimo oggi tra i Teologi, — nelle pene del fuoco eterno, ma godono uno stato di felicità conveniente alla natura (nel Limbo): sicché, come dice San Tommaso: “Melius est eis sic esse, quam non esse”».
• Come interpretare questa formula? «Il diritto, la filosofia, le scienze hanno certe formole, che in poche parole espressive e comprensive condensano tutta una dottrina e la ricordano a chi la conosce. Chiare per gli iniziati, oscure per i profani, prima di disconoscerle o di combatterle, bisogna assicurarsi di comprenderle bene. È una regola di lealtà e di buon senso. Cosi è della nostra massima, per la quale i nostri avversari dimenticano questa regola, turbati senza dubbio dallo spettro della pretesa intolleranza cattolica. Essi l’interpretano a loro modo, ottenendo così libero campo di gridare alla crudeltà, alla bestemmia. Ci fanno dire: Niuno è salvo, se non conosce la Chiesa cattolica, se non recita il suo credo, non osserva i suoi comandamenti, non ubbidisce ai suoi superiori. Donde conchiudono trionfalmente: Dunque gli infedeli, gli eretici, gli scismatici, i protestanti, i razionalisti tutti dannati in massa, tutti al fuoco dell’inferno. Lo confesso anch’io, questa dottrina è mostruosa: ma, lo sostengo, questa non fu mai la dottrina della Chiesa. L’insegnamento dei Papi, dei Concilii, dei Teologi si riassume in tre proporzioni, che formeranno l’oggetto del nostro studio» (Leroy S. J., Gesù Cristo, Vol. VII, 1910, p. 124).
• Principio fondamentale. Per procedere con ordine è conveniente prima stabilire bene un principio fondamentale, dal quale derivano due conseguenze, a primo aspetto quasi antitetiche e inconciliabili, che noi diremo come si possono facilmente conciliare. Secondo le mirabili disposizioni della Provvidenza divina, l’uomo ha per suo destino supremo, per suo obiettivo finale, non una felicità semplicemente naturale, proporzionata alla sua natura, a cui tendere per istintivo impulso, ma una felicità che trascende le sue aspirazioni e le sue facoltà naturali. Dio ha elevato l’uomo all’ordine soprannaturale; per mezzo della grazia santificante lo ha fatto Suo figliuolo adottivo, ma vero, destinandolo a godere della Sua stessa felicità in cielo. È questo il disegno primitivo, ammirabile, di Dio, che ci attesta la Sua immensa bontà per il genere umano. Giungere a salvezza vuol dire raggiungere questa felicità soprannaturale, possedere e godere Dio eternamente in cielo. Il primo uomo, uscito dalle mani creatrici di Dio, arricchito di questi grandi doni, che doveva trasmettere ai suoi discendenti, capo e rappresentante responsabile di tutta l’umanità, ha rovesciato quel magnifico disegno divino di amore col suo peccato, che si trasmette per via di origine a tutti i suoi figli. Ha perduto per sé e per essi la vita soprannaturale, mettendoli nell’impossibilità di poter pervenire a quella felicità eterna, a cui il Signore li aveva destinati.
• L’uomo, con le sue sole forze non avrebbe mai potuto ritornare in grazia di Dio: solo Dio poteva restituirlo a quello stato. Dio volle farlo: e il mezzo scelto fu l’Incarnazione del Suo Figlio Unigenito, Gesù Cristo. L’unica via per ottenere la salvezza e la felicità del cielo ora è Gesù Cristo, Salvatore dell’umanità; sono i mezzi di grazia, che Egli ci ha meritati, per mezzo della redenzione. Da questo deriva per necessaria conseguenza la verità del principio: Fuori della Chiesa non c’è salvezza.
• La parola della verità. Apriamo la Sacra Scrittura, che contiene la parola infallibile di Dio, e vi troviamo chiaramente espressa questa legge, promulgata da Gesù Cristo, come un’impreteribile necessità: Per salvarsi è necessario appartenere a Gesù Cristo, alla sua Chiesa. E, notiamolo subito, non si tratta solo di una necessità di precetto, derivante dall’obbligo di ubbidire ad un comando grave, espresso da Dio, dal quale obbligo è scusato chi si trova nell’impossibilità di osservarlo o per ignoranza o per altro motivo. No, è una necessità di mezzo: l’unico mezzo indispensabile, senza eccezione alcuna, per potersi salvare, è l’appartenere alla Chiesa, in modo tale che colui, il quale, per qualsiasi ragione, non appartiene in qualche modo alla Chiesa, non si può salvare. L’aria è assolutamente necessaria per conservare la vita fisica, e quando uno è ridotto al punto di non poter più respirare l’ossigeno dell’aria, necessariamente viene meno alla vita del corpo e muore. L’appartenenza a Gesù Cristo ed alla sua Chiesa è ugualmente necessaria per raggiungere il fine supremo dell’uomo, la felicità del cielo; e chi non vi appartiene non può essere ammesso all’eterna felicità. Ascoltiamo la parola formale del divino Maestro, consegnata nel Vangelo. Dopo la Risurrezione, su un monte di Galilea Gesù appare ai suoi discepoli, e trasmette ad essi, quale sacra eredità, la grande missione ricevuta dal Padre di salvare il mondo. Scena veramente mirabile e grandiosa nella sua semplicità: Gesù che invia undici poveri e rozzi pescatori alla conquista del mondo alla sua religione, di morale così pura, di dottrina così elevata. Solo un Dio poteva parlare come Gesù, con la visione sicura del trionfo della Chiesa: «Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato, sarà salvato; chi non crederà sarà condannato» (Marco, XVI, 15-16 Cf. Matteo, XXVIII, 19-20).
• Deduzione necessaria. Due conseguenze derivano dalla parola di Gesù. Prima conseguenza: la parola di Gesù suona condanna per chi ricusa positivamente di accettare la Sua dottrina, predicata integralmente dagli Apostoli e dai loro successori, e di aderire ad essa con la fede e con la pratica, ricusa cioè di appartenere alla sua Chiesa. E poiché una tale condanna importa la perdita della salvezza per chi non vuole fare parte della Chiesa, bisogna dedurre che l’appartenere alla Chiesa è una condizione essenziale, sine qua non, per potersi salvare. Seconda conseguenza: la condanna portata dal divino Maestro, in forza dell’antitesi esistente tra i due membri della frase, cade soltanto su coloro, che avendo conosciuta la verità della dottrina di Gesù Cristo, rifiutano positivamente di credere; e non riguarda coloro, che, ignorando in buona fede la Sua dottrina e l’autorità divina della Chiesa, di fatto non fanno parte come membri della Chiesa stessa. Bisogna perciò dire che essi in qualche modo, come si vedrà, si possono salvare. Queste due conseguenze formano come la trama del presente lavoro: sono le tesi che svilupperemo e dimostreremo.
• Nella sola Chiesa si può ottenere la salvezza. Gesù Cristo, la vigilia della Sua morte, nel Cenacolo, in quel commovente discorso di addio ai Suoi apostoli, che stava per lasciare, ha detto: «Io sono la vite, voi i tralci; chi rimane in me ed io in lui, produce molto frutto; perché senza di me voi non potete far nulla. Chi poi in me non rimane, è gettato via come il tralcio e si dissecca e raccolto si butta nel fuoco e brucia» (Giov., XV, 5-6). È un principio evidente proclamato da Gesù: privi della vita soprannaturale, gli uomini sono morti ad essa e non possono produrre nulla di meritorio, che possa servire per l’eterna salvezza. Di qui la necessità assoluta di stare uniti a Gesù Cristo per avere la vita della grazia, per portare frutti di vita eterna e poter raggiungere la felicità del cielo. «Per il tralcio, dice Sant’Agostino, non c è via di mezzo: o la vite o il fuoco: per non essere buttati nel fuoco, restino uniti alla vite». La stessa cosa avviene per gli uomini: senza l’unione con l’albero della vita, che è Gesù Cristo, non possono vivere della vita della grazia, che deve cambiarsi poi definitivamente nella vita della gloria. E anche più chiaramente Gesù ha detto nello stesso discorso: «Io sono la via, la verità, la vita; nessuno può andare al Padre, se non Per mezzo mio» (Giov., XV, 6). Egli solo è la via, per cui bisogna camminare per poter pervenire al cielo, perché Egli è l’unico Mediatore per andare al Padre. Egli solo è la verità, a cui bisogna credere per salvarsi, per giungere alla vita.
• La stessa verità ha proclamato altamente San Pietro davanti al Sinedrio di Gerusalemme, che aveva intimato a lui e agli altri apostoli di non predicare la religione del Nazareno. «Non c’è salvezza che in Gesù Cristo, perché non c è sotto il cielo nessun altro nome dato agli uomini, nel quale noi dobbiamo essere salvati» (Atti, XV, 12). Soltanto con una adesione totale a Gesù Cristo si può ottenere la salvezza. È l’unico mezzo, l’unica via: appartenere a Gesù Cristo e praticare la Sua religione. Altre vie per giungere al cielo non esistono né possono esistere. Chi segue una via diversa è fuori di strada, o meglio, è sulla strada che non conduce alla felicità, ma alla perdizione.
• Gesù Cristo nella Sua Chiesa. Ora tutti i cristiani sanno, o almeno dovrebbero sapere, che la Chiesa fondata da Gesù Cristo è la continuazione di Gesù Cristo in terra, è quasi, secondo un’espressione molto efficace, «l’incarnazione permanente del Figlio di Dio... È Cristo, che si estende nel tempo e nello spazio» (Moehler, Le simboliche, Carmagnola, 1852, p. 310). È quella istituzione perenne, indefettibile, in cui Gesù ancora risiede col Suo spirito, in cui opera con la Sua virtù divina, in cui ha posto il Suo stesso potere e per mezzo della quale Egli continua la Sua missione di santificazione e di salvezza (Gesù maestro = insegna; Gesù Re = governa; Gesù sacerdote = santifica). Questo è il programma di vita della Chiesa, e forma tutta la sua ragione di essere. La Chiesa, quale risulta dalla sua fondazione, non è altro che «il regno di Dio» predetto dai Profeti, proclamato nel Vangelo. Sotto il suo aspetto esteriore, visibile e collettivo, qui in terra, ha per fine di procurare «il regno di Dio» sotto il suo aspetto interiore e morale, cioè la santità delle anime, e preparare così il regno di Dio sotto il suo aspetto definitivo e celeste, che è la vita eterna. E tutti, per giungere a fare parte del regno di Dio in cielo, devono anche appartenere al regno di Dio in terra, cioè alla Chiesa, e stabilire il regno di Dio nel loro cuore per mezzo della grazia.
• Ancora di più. Come spiegheremo più avanti, la Chiesa è il corpo mistico di Gesù Cristo. Egli ne è il capo e noi dobbiamo esserne membri viventi. Il battesimo, per sua istituzione, come appare anche dal suo simbolismo, ha per fine la nostra consacrazione a Gesù Cristo e unione con Lui; significa che il cristiano è nel sacro rito quasi immerso in Gesù Cristo, incorporato a Lui in modo da diventare membro del Suo corpo mistico. Ne consegue che come per salvarsi è assolutamente necessario il battesimo, «chi crederà e sarà battezzato sarà salvo», così è altrettanto necessario appartenere al corpo mistico di Gesù Cristo, cioè alla Chiesa. La parola di Dio contenuta nella Sacra Scrittura è, adunque, esplicita e formale e non ammette il minimo dubbio: Per salvarsi è necessario appartenere alla Chiesa, come è necessario appartenere a Gesù Cristo, al Suo regno in terra, al Suo corpo mistico. Necessità universale per tutti gli uomini, senza distinzione ed eccezione; necessità assoluta, che non ammette scusa alcuna, e non contempla nessun caso di impossibilità ; necessità tale, che se uno non appartiene alla Chiesa, non si può in nessun modo salvare.
• Quale è la Chiesa di Gesù Cristo. Ci si potrà forse domandare quale sia questa Chiesa, a cui bisogna assolutamente appartenere per salvarsi. La risposta è facile: la Chiesa cattolica romana. La Chiesa del Cristo, infatti, non può essere che la Chiesa fondata da Lui, organizzata da Pietro e dagli Apostoli, governata dai loro successori, in una parola la Chiesa che risale fino a Gesù Cristo per mezzo degli Apostoli. La Chiesa del Cristo non è dunque né il giudaismo, né il buddismo, né il maomettanismo, né alcuna altra delle società religiose, che non riconoscono per fondatori né il Cristo, né gli Apostoli. La Chiesa del Cristo non è dunque la chiesa greca-ortodossa, che cominciò nel secolo XI col patriarca di Costantinopoli, Michele Cerulario; né alcuna delle chiese orientali separate, perché la loro origine è posteriore agli Apostoli. La Chiesa del Cristo non è il Protestantesimo, o lo si consideri nell’insieme delle sette che lo compongono — o meglio lo dividono — o in ciascuna di esse: la luterana, la calvinista, l’anglicana, l’americana, l’evangelica, la liberale, l’ortodossa, o qualunque altro nome abbia: si contano a centinaia. Lutero, Calvino, Enrico VIII ed altri ribelli come loro ne furono i fondatori in tempi ben conosciuti, molto vicini a noi, ben lungi dagli Apostoli. La Chiesa del Cristo è la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica romana soltanto; perché soltanto essa, per una successione non interrotta di pastori legittimi, risale fino agli Apostoli e per gli Apostoli sino a N. S. Gesù Cristo.
• Deduciamo la conseguenza. Se dunque per essere uniti a Gesù Cristo, sorgente della vita e della salvezza, è necessario essere membri della Sua Chiesa, bisogna conchiudere che nessuno sarà salvo, se non appartiene alla Chiesa cattolica romana, l’unica Chiesa del Cristo. Noi siamo così condotti dal Vangelo stesso e dalla sua parola infallibile alla dottrina, che esattamente traduce l’assioma che così severamente alcuni vogliono condannare: Fuori della Chiesa non c’è salvezza.
• La dottrina di Gesù conservata nei secoli... Agli insegnamenti del Vangelo fa eco la voce unanime dei Padri e dei Dottori della Chiesa. «Nessuno si inganni, dice Origene nelle sue Omelie sopra Giosuè (Hom. III, n. 5), nessuno cerchi vanamente di Persuadersi: extra hanc domum, id est extra Ecclesiam nemo salvatur, fuori di questa casa, cioè fuori della Chiesa, nessuno si salva». È noto il detto di San Cipriano: «Non può avere Dio per Padre chi non ha per Madre la Chiesa» (De unitate Ecclesiae, VI). «Che importa, dice Sant’Agostino ai Donatisti scismatici (In Ps. 88, sermo II, n. 14), se tu confessi Dio, e onori Dio e lo lodi, se riconosci il Figlio Suo e confessi che siede alla destra del Padre... e poi bestemmi la sua Chiesa? Tenete tutti unanimemente, o carissimi, Dio come Padre e come madre la Chiesa». «Nessuno, dice ancora Sant’Agostino (De unitate Ecclesiae, XIX), può essere salvo e conseguire la vita eterna, se non ha Cristo per capo; nessuno ha Cristo per capo, se non appartiene al Suo corpo, che è la Chiesa». I Padri, per inculcare con un esempio questa verità, si servono del simbolo biblico dell’arca. Nell’universale diluvio avvenuto al tempo di Noè, si salvarono soltanto i pochi privilegiati, che entrarono insieme con lui nell’arca; mentre gli altri tutti non poterono sfuggire alla furia distruggitrice delle acque, e perirono miseramente. Così nessuno sfugge al diluvio della perdizione, se per la porta del battesimo non entra nell’arca della Chiesa. La Chiesa, maestra infallibile di verità, nel suo magistero ordinario e nel suo magistero solenne, ha ripetutamente e chiaramente insegnato questa verità, per combattere errori, che su tale argomento si diffondevano in mezzo al popolo cristiano. Nel quarto Concilio ecumenico Laterano (a. 1215), la Chiesa ha solennemente definito contro gli Albigesi come dogma di fede: «Unica è la Chiesa universale dei fedeli, fuori della quale nessuno si può salvare».
• ... fino ai giorni nostri. E in molte altre circostanze, per opporsi agli errori qua e là insorgenti, la Chiesa non ha lasciato di promulgare e richiamare con grande fermezza questo principio, come una verità che fa parte del deposito della fede. Pio IX nella sua allocuzione concistoriale del 9 dicembre 1854 e nella sua lettera enciclica ai Vescovi d’Italia del 10 agosto 1863, e nel Sillabo (prop. 16-18), riprova fortemente e solennemente l’indifferentismo di coloro, che falsamente si immaginano che si può essere salvi anche fuori della Chiesa. Tenendum ex fide est, dichiara solennemente Pio IX nell’allocuzione del 9 dicembre 1854. È quindi verità di fede, obbligatoria a credersi da tutti, per non separarsi dalla Chiesa e cadere nell’eresia, che la Chiesa è l’unica via per giungere a salvezza: Extra Ecclesiam nulla salus.
• La Chiesa arca di salvezza. La Chiesa cattolica romana è pertanto l’unica arca di salvezza, è la sola nave, che faccia il tragitto dalle rive del nostro mondo al porto dell’eternità felice. Soltanto quei passeggeri, che saranno rimasti a bordo sino al termine del loro viaggio, saranno annoverati tra gli eletti; chiunque non sale e non resta sino al termine della vita sulla nave della Chiesa, guidata da Pietro, non si può salvare: Fuori della Chiesa non c’è salvezza.
• Tutti gli uomini di buona fede si possono salvare? A dir vero, il principio ora dimostrato con l’autorità del Vangelo, della Chiesa e dei Padri e Dottori, appare a tutta prima un principio molto severo, quasi in aperta opposizione con la bontà e misericordia di Dio. Sembrerebbe doversi dire senz’altro, in forza di tale principio, che tutti quelli che, per qualsiasi ragione, anche senza nessuna loro responsabilità, non appartengono alla Chiesa visibile di Gesù Cristo, debbano andare fatalmente e irremissibilmente perduti. Ma non è così, poiché ugualmente certo è il secondo principio, anch’esso fondato sopra l’autorità dei Vangelo e della Chiesa.
• Conseguenze inammissibili. Quali sarebbero infatti le conseguenze che si dovrebbero ammettere, se non fosse possibile che tutti gli uomini di buona fede si possano salvare? Si supponga un adulto, che viva e muoia in una ignoranza incolpevole dell’esistenza della Chiesa Cattolica, dei suoi diritti esclusivi e dell’obbligo assoluto di abbracciarla per salvarsi, e che segua fedelmente i dettami della legge naturale, quali gli sono intimati dalla voce della coscienza. Siffatta ignoranza e il fatto stesso di non appartenere alla Chiesa non gli può essere imputato a grave colpa. Se soltanto per questo non potesse salvarsi, ne verrebbero necessariamente queste due conseguenze. La prima conseguenza: che Dio non vorrebbe seriamente e sinceramente l’eterna salvezza di tutti, perché non a tutti, e senza loro colpa, concederebbe i mezzi necessari per giungere alla felicità. La seconda conseguenza: che Dio comanda delle cose impossibili: comanda cioè a tutti di salvarsi, fine ultimo della vita imposto a tutti gli uomini, mentre a tanti ciò riesce impossibile per causa dell’ignoranza e di altre circostanze in cui si trovano... Prosegue la prossima settimana ...
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci eravamo salutati studiano il prezioso volumetto del P. F. S. Porporato, «La verità nei libri storici della Bibbia», SOS (Collezione di Opuscoli Apologetici per le Persone Colte), imprimatur 1945. Ricominciamo sfatando la ridicola obiezione secondo cui Gesù sarebbe il primogenito..., pertanto non sarebbe figlio unico. Tanto si è scritto nel precedente numero di Sursum Corda, dunque concludiamo affermando che un figlio è detto «Primogenito» dalla Scrittura non solo perché è stato seguito da altri, ma anche per il solo fatto che da altri non è stato preceduto «primogenitus est non tantum post quem et alii, sed ante quem nullus» (S. Hier, De Perpetua virginitate Beata Mariae adversum Elvidium, n. 10 P.L. 23, col. 192-3).
• La bestemmia di Elvidio è quindi sfatata e smentita dal momento che sfatata e smentita è l’interpretazione del vocabolo su cui era incastellata: e San Luca poté ben scrivere che Maria «partorì il figlio suo primogenito», senza recare il minimo pregiudizio alla verginità perpetua della Madre di Dio. Del resto a confusione degli antichi eretici non meno che dei moderni razionalisti che, da veri epigoni di quelli antichi, osano schierarsi contro la perpetua verginità di Maria SS.ma, rimettendo in campo obbiezioni già mille volte vittoriosamente ribattute, la Provvidenza serbava ai tempi nostri una prova delle più schiaccianti. Tutti codesti oppositori ripetono in sostanza, con Holtzmann: «Questo termine protótohos prova che anche il nostro Evangelista (Luca), come i precedenti, vede in Gesù il maggiore di una serie di fratelli e sorelle. Infatti anche qui si applica ciò che Luciano (Demonax, 29) dice di Agatocle: “Se primo non è solo, se solo non è primo”». Agatocle fu un filosofo peripatetico, che con grande boria vantava se stesso per unico e primo dei dialettici. Gli risponde argutamente Demonatte: «O Agatocle, se sei unico non sei primo, e se primo non unico». Ma la filologia con tanta baldanza invocata, è venuta a gettare loro in faccia una smentita solenne, clamorosa, mediante l’iscrizione d’una lapide sepolcrale, trovata nel 1922 negli scavi di Iehudieh, l’antica Leontopoli, già sede di una fiorente colonia ebraica. In quella iscrizione è introdotta a parlare una giovine ebrea, per nome Arsinoe, che lamenta d’esser morta, in sul fior degli anni, nei dolori del parto del suo figlio primogenito «odeíni prototókou téknou».
• Più ancora: è ivi segnato il tempo della composizione di tale iscrizione: è il vigesimoquinto anno di Cesare Augusto (= anno 5° a. C.), su per giù il tempo in cui ora si colloca generalmente la data della nascita del Salvatore. Le conseguenze di una tale iscrizione, ognuno le vede, sono di una portata al tutto eccezionale. Il figlio di Arsinoe viene chiamato protótokos — primogenito, eppure è unico. Dunque è falso che«se primo non è solo, e se solo non è primo»: in altre parole è falso che il termine protótokos = primogenito, non possa avere un senso assoluto, ma implichi sempre un senso relativo, un rapporto ad altri fratelli o sorelle, nati dopo il primo. Il figlio di Arsinoe viene chiamato protótohos — primogenito e non monogenés = unigenito, eppure era chiaro che Arsinoe era senza alcuna possibilità di averne altri. Dunque poté San Luca chiamare Gesù il Figlio primogenito di Maria anziché Figlio unigenito, pur sapendo che, posto in Maria il proposito di perpetua verginità (cf. c. I, v. 34), altri, dopo il primo, erano impossibili
• Il Grimm, che nel suo «Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti» (Lipsiae, 1888), sotto la voce adelfós scrive: «Si Maria post Jesum alios liberos non peperisset pro yion protótokon dicendum fuisset yion monogené», parimenti l’Usener che rifrigge la stessa obbiezione hanno da questo documento una confutazione perentoria, senza replica. C’era poi una ragione tutta speciale per San Luca di usare il termine primogenito, dato che quel termine era il necessario fondamento e il titolo legale della Presentazione al Tempio, da lui solo riferita (San Luca raccoglie le memorie della Vergine Maria, ndr.). Pertanto quando nel Piccolo dizionario biblico, composto a cura dell’eretica comunità valdese di Torre Pellice nel 1941, a pag. 160, sotto la voce Fratelli di Gesù leggiamo: «Quest’ultima espressione (Figliuolo primogenito, Luc. 2; 7) non dimostra essa che l’evangelista credeva che Gesù non fosse l’unico figlio di Maria?», ci prende un senso di stupore e, anche scientificamente parlando, siamo costretti a deplorare di trovarci dinanzi a cose che sanno di arretrato. Ecco come per la verità storica sia importante ben appuntare l’occhio al significato inteso dall’agiografo nell’uso che fa d’una locuzione o d’un vocabolo; quanto sia importante inquadrare locuzioni e vocaboli nella mentalità di chi scrive non meno che nelle particolarità del linguaggio corrente in cui si scrive.
• Metodo di computazione. Anche per giudicare rettamente della verità di certi computi della Scrittura conviene essere attenti a cogliere il metodo di computazione che può aver seguito l’agiografo: altrimenti si corre il rischio di mettersi in una falsa prospettiva e di pronunciare condanna che in realtà ferirà non la Scrittura ma la falsità delle nostre apprensioni intorno alla Scrittura. Un esempio ci pare di trovarlo nel libro secondo dei Paralipomeni (17, 13-17), dove sono nominati cinque capitani i quali hanno sotto di sé dei soldati come segue: Il primo trecento eleph, il secondo duecentottanta eleph, il terzo duecento eleph, il quarto duecento eleph, il quinto centottanta eleph. Se interpretiamo «eleph» per «migliaia» effettive, abbiamo in tutto 1.160.000 uomini. E dire che tutti sono residenti nella città di Gerusalemme (verso 19), tutti formanti come la coorte pretoriana del re Giosafat. Evidentemente è cifra esorbitante, fuori del credibile. Errore dell’agiografo, come vogliono i razionalisti? Sbaglio dei copisti, come dicono altri? Né l’uno né l’altro. A ridurre il computo a proporzioni ragionevoli, basterà spiegare l’»eleph» = migliaia, come valore fisso, ma convenzionale, sotto cui si raggruppano i valori reali, espressi dalle altre cifre. In altri termini sarebbero gruppi di 300, di 280, di 200, di 200, di 180 soldati appartenenti rispettivamente a cinque divisioni o coorti militari dette millenarie, alla cui testa stavano quei capitani (o capi-migliaia) come li chiama espressamente (v. 14) il testo ebraico.
• Ecco i due libri dei Maccabei. Nei dati cronologici di entrambi il lettore moderno resta dapprima sconcertato dall’uso che fanno d’un’êra speciale, quella dei Seleucidi cominciata nell’ottobre del 312 avanti Cristo. Ma, quel che è più e fa al caso nostro, talora non s’accordano fra loro nel riferire a un dato anno il medesimo fatto. La questione è che l’autore del 1° libro dei Maccabei, seguendo l’uso ebraico che poneva il principio dell’anno in primavera (Nisan, marzo-aprile), ha computato come primo anno dei Seleucidi dal marzo-aprile del 312 al febbraio-marzo del 311. In conseguenza per lui già nel marzo-aprile del 311 comincia l’anno secondo dei Seleucidi, riuscendo così in anticipo di 6 mesi sull’autore del libro secondo che lo comincia nell’ottobre seguente. Da ricordarlo, per non attribuire ad errore il trovare, nel primo libro, segnati coll’anticipo di un anno, quegli identici avvenimenti che il secondo ha datato coll’anno susseguente.
• Similmente notiamo che quando i sinottici riferiscono la profezia di Gesù: «Il Figlio dell’uomo dopo tre giorni risusciterà» (Matt. 17, 22 ; 20, 19; Marc. 9, 30; 10, 34; Luc. 18, 33), evidentemente parlano secondo il computo in uso presso gli Ebrei, per i quali una frazione di giorno contava per un giorno intero. Altro esempio dal libro di Giosuè 1-3. Giosuè dà ordine a tutto il campo di apparecchiarsi, perché tre giorni dopo si deve passare il Giordano (1, 11). Poi manda esploratori a Gerico, i quali di ritorno sul far della notte: per non incappare negli inseguitori sguinzagliati loro dietro si gettano attraverso la montagna e vi rimangono tre giorni (2, 22). Scesi poi da Giosuè e informatolo che le cose vanno bene e il momento è propizio, in fin di tre giorni si muove il campo e si giunge al Giordano (3, 2). Contraddizione fra i due ultimi dati, ovvero contrordine e ritardo a muovere il campo in attesa del ritorno degli esploratori? Né l’uno né l’altro; a tutto conciliare basta prendere per non interi i tre giorni della dimora nella montagna, ma la sola notte per il primo, e le prime ore del mattino per il terzo con solamente il secondo intero, tempo abbondante, nonché sufficiente, allo scopo. Rileviamo infatti dagli scritti rabbinici la testimonianza di R. Eleazar bar Azaria che diceva, verso l’anno 100 dopo Cristo: «Un giorno e una notte formano una ’ona (spazio di tempo equivalente a 24 ore), ma una ’ona cominciata vale una ona intera».
• San Giovanni, nel racconto della Passione, nota un particolare che pare in aperto contrasto con San Marco. Questi dice espressamente: «Era l’ora terza quando lo crocifissero (il Salvatore) (15, 25)». San Giovanni invece afferma che era quasi l’ora sesta quando Pilato pronunciò la condanna e lo diede a crocifiggere (19, 14). Ma il contrasto scompare dinanzi a una semplice riflessione sopra la divisione del giorno, seguita dai due Evangelisti. L’ora terza, comprende tutto lo spazio che decorre dall’inizio alla fine dell’ora terza, vale a dire dalle nove alle dodici. Pertanto qualunque punto di queste tre ore può verificare l’affermazione di San Marco. Ora San Giovanni non farà che meglio precisare quel punto quando scrive che la condanna di Gesù fu pronunziata circa l’ora sesta. Dichiara così che l’esecuzione, seguita immediatamente alla condanna, avvenne quando l’ora terza era sul terminare, e non è punto in disaccordo con San Marco.
• Esclusione di ogni errore? Con questo non vogliamo negare che qua e là nella Scrittura le cifre numeriche non abbiano subito delle alterazioni; ma questo punto rientra nell’ambito di un’osservazione più generale che ancora dobbiamo aggiungere per comprendere a dovere la verità della Scrittura, massime nei libri storici. Bisogna dunque sapere che l’esclusione assoluta di ogni errore, che diciamo essere proprietà essenziale della Scrittura, riguarda la Scrittura quale, nel suo testo originario, è uscita dalle mani degli agiografi. È qui dove in tutta la piena estensione del termine, ogni singola asserzione, così come è espressa per iscritto, è parola scritta da Dio, garantita perciò infallibile dall’infallibilità di Dio stesso. Ma ben lo sappiamo: coll’andar del tempo, agli autografi, che perirono, successero gli apografi, cioè le copie trascritte e, come è facile immaginare, moltiplicate in grande quantità. In questo lavorio di continua trascrizione e nella lunga serie di tanti secoli, supporre che tutto sia stato conservato appuntino, conformemente agli originali primitivi, sarebbe supporre miracoli sopra miracoli. Ora i miracoli non si suppongono, ma si provano. Avvenne pertanto ciò che in simili casi suole avvenire per altri libri.
• Gli scrivani, o per sbaglio d’occhio nella lettura o per sbaglio d’orecchio nella dettatura, o per stanchezza di mente, o per deficienza di attenzione, qua e là inciampano, scambiano una locuzione per un altra, un nome per un altro, saltano talora incisi, linee, interi periodi; cercano, a volte, di dare un costrutto qualunque a ciò che essi non intendono, quando ancora non si pigliano la libertà di aggiungere essi, ad arbitrio, qualche glossa loro propria, dove il testo offre oscurità. E la ragione è che nel copiare a mano (unico modo di edizione nell’antichità e nel medio evo) è moralmente impossibile che in un testo di qualche lunghezza non si introduca qualche modificazione: non si danno due manoscritti della medesima opera perfettamente identici per il testo. Tanto è provato da un’esperienza continua d’ogni giorno.
• Ebbene una sorte simile ebbero anche a incontrare i libri sacri. Per altro, notiamolo subito, c’è una parte nei libri sacri sulla quale indubbiamente Dio dovette invigilare con una provvidenza tutta particolare, perché, nella trascrizione del testo sacro, nell’avvicendarsi di trascrizioni innumerevoli, nulla si alterasse di ciò che riguarda la sostanza del libro ispirato, ossia di ciò che riguarda la fede e i costumi: diversamente il deposito della rivelazione non si sarebbe trasmesso sempre intatto e integro alle generazioni più remote, e sarebbe stato frustrato il fine che ebbe Dio nell’ispirare quei libri. È quindi fuori di dubbio che le parti sostanziali, sia dogmatiche sia morali, si conservarono sempre immuni da qualsiasi errore, benché talvolta possano essere andate soggette a difetti di trasmissione del testo, come varianti che non alterano sensibilmente il significato.
• Ma in modo più assoluto e perentorio bisogna dire ciò nel caso dei «passi dommatici», ossia in quelle, anche brevi, locuzioni che tecnicamente, a così dire, esprimono la verità rivelata, come, per esempio, nel racconto della consacrazione eucaristica. Invece per le parti accidentali, secondarie, che nella Scrittura sono come un accessorio, senza necessaria attinenza e intimo collegamento con la fede e i costumi, non possiamo dire altrettanto. Queste non furono esenti dall’incontrare la sorte comune di ogni altro documento letterario dell’antichità: in queste poterono infiltrarsi qua e là delle alterazioni, delle modificazioni e perfino degli errori, per le cause sopra esposte e che Dio non ha voluto impedire.
• Errori per scambio di lettere. Applichiamo ora quanto abbiamo detto ai libri storici della Bibbia, e avremo facile il modo di sciogliere parecchie difficoltà. Anzitutto ci rendiamo conto delle differenze che occorrono in questo, o in quel punto accessorio, massime a riguardo dei nomi proprii, dove lo scambio di lettere, molto simili tra loro nella forma, è tanto facile; come pure a riguardo di cifre numeriche, dato che anche queste si solevano rappresentare con segni alfabetici. Sapremo così spiegare perché un identica persona si chiama nel Genesi (3, 39) Adar, e invece in I Par. (1, 50) Adad; perché Ackar e Zabdi trovati in Giosuè (1, 1, 17, 18) si cambiano nel I Par. (12, 6. 7) in Achar e Zamri; perché nel 3° dei Re (9, 28) si dice che da Ophir si portarono a Salomone 420 talenti d’oro, mentre nel 2° Par. (8, 18) sono invece 450; perché il libro 2° dei Re (10, 8) parla di 700 carri e di 40.000 cavalieri, invece il l° Par., nel luogo parallelo, (19, 8) di 7.000 carri e di 40.000 fanti; perché secondo il quarto dei Re (8, 26) Ochozia, quando principiò a regnare, aveva 22 anni, 42 invece secondo il 2° Par. (22, 2); perché nel 2° dei Re al capo 6, 23 troviamo affermato che Micol, figlia di Saulle, non ebbe mai figli in vita sua, mentre al capo 21, 8 (per confusione avvenuta di Michol con Merob, anch’essa figlia di Saulle) leggiamo che Michol ebbe 5 figli da Adriele, figlio di Berzellai (cf. 1° Re 18, 29; 25, 24); perché nel libro di Esdra (2, 1-70) e nel libro di Nehemia (2° di Esdra 7, 8-66) benché la somma totale degli Ebrei tornati dall’esilio Babilonese in Palestina si trovi in entrambi del tutto uguale (12.360), tuttavia i numeri parziali da cui risulta variano fra loro tanto da non dare il totale notato.
• Sono tutte divergenze per cui è alterata la verità storica accessoria, verissimo; ma di cui si hanno a chiamare in colpa non altri che i copisti. È noto il giudizio di San Girolamo a riguardo del sincronismo tra i re di Giuda e Israele, quale risulta dal 3° e 4° dei Re nel testo attuate. Il grande esegeta vi trovava tanta confusione di numeri da sentenziare che tentare un accordo sarebbe fatica gettata. «Relego omnes et veteris et novi Testamenti libros et tantam annorum reperies dissonantiam et numerum inter Iudam et Israel, id est, inter regnum utrumque confusum, ut huiusmodi haerere quaestionibus non tam studiosi quam otiosi hominis esse videatur». Epist. 72 n. 5 ad Vitalem (Migne, P. L. 22, 676). Il primo libro dei Re (6, 19) ci riferisce il castigo inflitto da Dio ai Betsamiti per il contegno irriverente tenuto verso l’Arca santa, allorché questa, dalle mani dei Filistei, era tornata in Israele. Vi è detto, nel testo ebraico, che Dio «percosse del popolo settanta uomini, cinquanta mila uomini». Trattandosi d’una piccola città, quale era Betsames, la cifra ha dell’incredibile. Ma è autentica? A guardare attentamente il testo, vi si scorge una doppia irregolarità, e cioè che, contrariamente all’usato, vien premesso il numero minore al maggiore e che viene omessa, davanti al secondo numero, la congiunzione solita in tali costrutti. Ciò dimostra che il secondo numero dev’essere un’interpolazione, tanto più che esso manca in alcuni codici ebraici (Kenn. 24.210.418); e Giuseppe Flavio (Ant. VI, I, 4), narrando lo stesso fatto, parla solo di settanta uomini. Pertanto la cifra sbalorditiva non deve farsi risalire all’agiografo.
• Una crudeltà di Davide? Vi è di peggio. Con ragione il P. Condamin, a un articolo pubblicato nelle Revue Biblique (1898, p. 253-258), poneva in fronte questo titolo: «David cruel par la faute d’un copiste». Ed ecco in che modo. Davide stando al testo ebraico attuale (2 Re, 12 31 b) avrebbe fatto passare nelle fornaci di mattoni, e quindi fatti bruciare, gli Ammoniti, e non solo quelli della città di Rabbath Ammon da lui espugnata, ma quelli ancora di tutte le altre città. Eccessi sopra eccessi di crudeltà, tanto che il Mangenot nel Dictionnaire de la Bible (Vol. II, col. 1316), sotto la voce David, si crede in dovere di scrivere: «Crudeltà di questo genere, che ci fanno orrore e che non c’è bisogno di attenuare... si spiegano abbastanza, senza che si possano scusare, con i costumi barbari del tempo». Ma ormai la critica testuale, anche di parte acattolica, ha reso giustizia a Davide in questo punto. Ha dimostrato che tutto è dovuto allo scambio di due verbi «àbar = passare e àbad = lavorare», le cui consonanti finali (resc e daleth) sono molto simili tra loro. Infatti, nella forma hiphil, se invece di «heèbir = far passare» si legge «heèbid = far lavorare», subito muta pure il senso e ne risulta: «fece lavorare gli Ammoniti nelle fornaci da mattoni». Cosa ben differente e per nulla crudele, e tanto più da ammettere se si riflette che il nome, retto dal verbo e interpretato per formarci da mattoni, ha propriamente il significato di «forme da mattoni»; se di più si riflette che solo così ha il pieno accordo con quanto precede, che cioè Davide, come applicò gli Ammoniti a vari altri gravosi lavori, «alle seghe, agli erpici ferrati, alle scuri (v. 31 a), così li fece lavorare in fabbricare mattoni (31 b)». Come già accennammo, gli stessi critici razionalisti giustificano ora Davide dall’accusa di crudeltà che, per il fatto degli Ammoniti, ha gravato tanto tempo sulla sua memoria. È un caso, questo, che sta a dimostrare a che gravi conseguenze possa portare lo scambio di una lettera, e quale vigile Provvidenza siasi dovuta esercitare per preservare da ogni errore le parti sostanziali del testo originale.
• Alterazioni nelle versioni. E che diremo se passiamo a considerare il testo sacro nelle versioni? Già si sa che la versione in se stessa, voglio dire in quanto versione, non è ispirata, e San Girolamo, parlando della versione Alessandrina, la cosiddetta versione dei Settanta, che pure era accolta e adottata nell’uso pubblico della Chiesa, ebbe a dire: «Aliud est vatem, aliud est esse interpretem». Altro è scrivere sotto la divina ispirazione, altro tradurre lo scritto ispirato. Nessuna meraviglia pertanto, se qui la verità storica, in cose accessorie, anche più di frequente, abbia avuto a soffrire alterazioni; ma in pari tempo sarà anche più evidente quanto sarebbe ingiusto l’attribuire ciò all’agiografo.
• La Volgata. È ben vero che c’è nella Chiesa una versione che ha un suggello di autorità unico, perché solennemente approvata dal Concilio di Trento come autentica, ossia come documento irrefragabile della rivelazione divina scritta. È la Volgata latina. Sarà essa, per questo, scevra di errori? Sì, se si tratta di cose che appartengono al pubblico magistero della Chiesa, che riguardano cioè la materia di dogma e di morale e quanto con il dogma e la morale ha stretta attinenza; no, se si considera ciò che vi ha di meramente accessorio. Che sia così fu riconosciuto da quegli stessi Padri e Teologi che presero parte al Concilio, come è riconosciuto tuttora da quanti trattano di questo argomento. Anzi abbiamo ora la dichiarazione autentica del magistero ecclesiastico nella enciclica sugli studi biblici «Divino afflante spiritu» (Cfr. Civ. Catt., 1943, IV, 201). E non lo nasconde la stessa Volgata che, appunto nei libri storici, contiene quegli errori medesimi che più sopra abbiamo elencato a riguardo del testo ebraico, oltre ad altri che sarebbe facile ad aggiungere, dovuti non a sbagli di stampa o di tipografi, ma addirittura alla versione stessa. Qualche saggio. Chi non lo vede, quando, per esempio, legge in Giosuè (14, 15) che Adamo il massimo (e cioè il primo degli uomini) è sepolto tra gli Enacim in Ebron, mentre il testo ebraico dice chiaramente che ivi era sepolto Arbe, uomo (ebr. ’adam ma nome comune e non proprio) il più grande che sia stato tra gli Enacim? Quando legge in 2° Esdra (9, 7) che «Abramo fu da Dio tratto fuori dal fuoco dei Caldei», interpretandosi il vocabolo ebraico «Ur» come nome comune (= fuoco), mentre è nome proprio indicante la città dei Caldei? E non è manifesto controsenso quando leggiamo nei libro primo dei Re (13, 1) che «Saulle (il quale sopravanzava il popolo dalla spalla in su, cfr. .10, 23) aveva un anno quando cominciò a regnare e ne regnò due sopra Israele»? Questo versetto, che nei Settanta manca del tutto, nell’ebraico è lacunoso, essendo caduti totalmente il primo numero (quello degli anni dell’età) e parzialmente il secondo (quello degli anni del regno); ad ogni modo nella Volgata non si può a meno di vedervi un errore. Similmente un errore riscontriamo nel versicolo 28 del Capo 32 dell’Esodo. La strage che Mosè, disceso dal Sinai, unitamente con i figli di Levi, fa degli idolatri del vitello d oro, sale, stando alla Volgata, a circa 23.000 uomini. Ma è cifra errata: il testo ebraico porta circa 3.000, d’accordo in questo con la versione dei Settanta, con la parafrasi aramaica, con la versione siriaca e con l’antica latina, citata da Tertulliano (Scorpiace III, P. L. 2, 129) e da Sant’Ambrogio (Epist. 56 ad Romanum, 1; P. L. 16, 1227).
• Un altro esempio particolarmente significativo. Dopo che Sansone ebbe percosso con una mascella d’asino mille Filistei, sentendosi riarso da gran sete, levò la voce a Dio per soccorso: e «Dio, stando alla Volgata, aperse il dente molare della mascella d’asino e ne fece sgorgare delle acque, onde Sansone si ristorò» (Giudici, 15, 14 segg.). Sennonché la versione qui non ha colto il senso. Il testo legge: «e Dio aperse la roccia concava (maktesc) che è sull’altura “Mascella” e ne scaturirono delle acque». Adunque «Mascella» non è altro che il nome dato a quella località, in memoria del fatto ivi accaduto e la fonte non sgorgò dal dente mascellare dell’asino, ma dalla cavità della pietra posta sul colle «Mascella». Tanto è vero che, ancora al tempo che l’autore sacro scriveva, quella fonte era detta «la fonte di colui che invocò (Dio) sull’altura della Mascella (v. 20)».
• E che dire della frase che incontriamo nella Volgata di San Matteo (21, 1): «Vespere autem Sabbati quae lucescit in prima sabbati?». Quanto è lontana dal rendere il testo originale: «dopo il sabbato, sull’albeggiare del primo giorno della settimana». E più lontana ancora senza paragone la versione degli Atti al c. 27, v. 13. Siamo a Creta. La nave che porta Paolo prigioniero a Roma ha sostato alquanto nella baia di Buoniporti, ed ora, volendo dirigersi al porto Fenice, salpa, secondo la Volgata, da Asson e costeggia Creta. «Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam». Ma Asson, isola o città marittima, non si trova in nessuna parte. Il traduttore ha quindi scambiato per nome proprio ciò che nel testo originale è avverbio comparativo, asson da anchi, che perciò si ha da intendere: «Avendo levate le ancore, più da vicino (asson) costeggiavano Creta».
• Dopo quanto abbiamo esposto si stenta veramente a credere come vi sia stato chi, non ha molto, abbia potuto sentenziare che il decreto Tridentino dà la «certezza del sacro testo», così che la Chiesa non ha bisogno di «ancora ricercare l’autentica lettera di Dio» (p. 7), e ciò non soltanto «in rebus fidei et morum», ma in tutti i rispetti «anche letterari, geografici, cronologici ecc...» (Acceniamo all’opuscolo che ha per titolo: «Un gravissimo pericolo per la Chiesa e per le anime. Il sistema critico-scientifico nello studio e nell’interpretazione della Sacra Scrittura, le sue deviazioni funeste e le sue aberrazioni» pubblicato in data 24 maggio 1941 sotto l’anonimo dal sac. Dolindo Ruotolo (Dain Cohenel). Se ne legga la confutazione nella Lettera circolare della Pontificia Commissione per gli Studi Bibblici diretta agli Ecc. Ordinari d’Italia, in data 20 agosto 1941. A. Vaccari, Lo Studio della Sacra Scrittura, Roma, Civiltà Cattolica, 1943). Se così fosse la Volgata ci dovrebbe dare sempre la verità esatta di tutte le narrazioni bibliche, in ogni più minuto particolare, perché sempre in tutto e per tutto vi leggeremmo con ogni certezza la autentica lettera di Dio. Ma è così? Gli esempi addotti, spigolati qua e là attraverso i libri storici della Bibbia, sono prova più che sufficiente del contrario; e non aggiungeremo altro.
• Appendice. Dire donde sia nata l’opinione che faceva gli spartani discendenti da Abramo è impossibile. Ma a torto si negherebbe che una tale opinione si sia potuta infiltrare nelle memorie di quel popolo. Leggasi quanto scrive Tacito nel libro V delle Storie, al capo 2°, intorno alle origini dei Giudei: «Si racconta che i Giudei, fuggendo dall’isola di Creta, si stabilirono sugli estremi confini della Libia, al tempo che Saturno, cacciato da Giove, abdicò al suo regno. Una prova è dedotta dal loro nome. A Creta, è celebre il monte Ida e i suoi abitanti erano chiamati Idei, nome che, aumentato per barbara corruzione d’una lettera, è divenuto Iudei. Secondo alcuni sotto il regno d’Iside, la moltitudine pollulata in Egitto, si riversò nelle terre vicine sotto la condotta di Ierosolimo e di Giuda. Parecchi vedono nei Giudei una razza d’Etiopi che timore e odio spinsero, sotto il regno di Cefeo, a mutare dimora. C’è anche chi ne fa una popolazione di emigranti Assiri, i quali, per mancanza di terra, si impadronirono d’una parte dell’Egitto, e ben presto colonizzarono, per proprio conto, le città e le terre ebraiche e le regioni vicine alla Siria. Secondo altri finalmente i Giudei hanno origini illustri: i Solimi, popolo celebre nei canti d’Omero, avrebbero fondato una città, che da essi prese il nome di Ierosolima». Non fa quindi meraviglia che Areo, forse per qualche suo particolare interesse, ricordi, scrivendo ad Orna, la comune origine che gli spartani affettavano di avere con i Giudei. Certo è che anche l’empio Giasone era di questa opinione, e fuggì a Sparta nella speranza di trovare ivi un rifugio, mosso appunto dal pensiero dell’affinità di razza (2 Macc. 5, 9)...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, tra le conseguenze immediate, anzi una proprietà essenziale della divina ispirazione, è l’inerranza, ossia l’infallibilità di quanto scrive l’agiografo e scrittore sacro. Ne abbiamo già parlato a sufficienza anni fa su Sursum Corda, studiando altresì le sentenze della Chiesa a riguardo. Infallibilità di quanto scrive l’agiografo, né potrebbe essere altrimenti: dal momento che quello scritto è, in tutto rigore del termine, parola di Dio, è perciò stesso posto sotto la garanzia di quella infinita veracità a cui ripugna essenzialmente ogni errore. Nel caso di libri storici, la verità garantita per infallibile sarà la verità storica di quanto ci vien narrato con tutti i relativi particolari della narrazione. Sennonché, a voler percepire con ogni esattezza tale verità, fa d’uopo che si tengano presenti varie osservazioni, che sono, per così dire, come altrettanti punti di vista, ove dobbiamo collocarci per riportarne la giusta visione. Nell’odierno approfondimento ci faremo aiutare dal P. F. S. Porporato, «La verità nei libri storici della Bibbia», SOS (Collezione di Opuscoli Apologetici per le Persone Colte), imprimatur 1945.
• Verità della citazione e verità del contenuto. Anzitutto conviene badare a distinguere il racconto che l’agiografo dà come suo proprio o che approva, da quanto egli riferisce semplicemente come racconto altrui.
• Alcuni esempi. Prendiamo il fatto della morte di Saulle. L’agio-grafo ce lo racconta nel primo libro dei Re (31, 3-6). L’infelice monarca, nella battaglia contro i Filistei sulle alture di Gelboe, ha avuto l’esercito in piena rotta e volto in fuga. Egli stesso, gravemente ferito, si vede in procinto di cadere nelle mani dei nemici. In tale frangente, prega il suo scudiero di ucciderlo, ma questi ricusa. Saulle, allora, afferra la propria spada e vi si getta sopra, troncandosi così la vita con un suicidio. A quella vista lo scudiero ne imita l’esempio, anch’egli si uccide allo stesso modo. Questa la narrazione fatta dall’agiografo e che viene ripetuta nel libro l° dei Paralipomeni (10, 1 segg.), quasi con le medesime parole. Ora ecco nel libro 2 dei Re (1, 1 segg.), una seconda narrazione del medesimo fatto, ma con particolarità ben diverse. Un amalecita si è recato tutto frettoloso da Davide che stava nella città di Siceleg, tuttora ignaro dell’accaduto, e gli narra la sconfitta dell’esercito e la morte di Saulle sui monti di Gelboe. L’aveva visto nell’atto che, gravemente ferito, stava ricurvo appoggiato sulla propria lancia: era oppresso da spasimi atroci. All’avvicinarsi dei nemici, Saulle stesso l’aveva chiamato a gettarsi sopra di lui e a finirlo: egli lo aveva fatto. In prova, mostrava il diadema e i braccialetti tolti all’ucciso e portati lì davanti a Davide. Come non vedere che la seconda narrazione contraddice alla prima? Falsità, dunque, nell’agiografo ispirato? Per nulla.
• L’agiografo non fa che riferire il racconto tale e quale fu in realtà esposto dall’amalecita, e di questo solo si rende garante (veritas citationis); che poi a quel racconto risponda l’esattezza storica (veritas rei citatae = verità del contenuto nella citazione) è ben altro. L’agiografo stesso lo nega implicitamente, dal momento che proprio nel capo ultimo del libro precedente ci ha narrato la morte di Saulle ben altrimenti. L’opportunità, però, dell’episodio è evidente. Senza di esso l’atto magnanimo di Davide che, lungi dal rallegrarsi, punisce di morte l’amalecita per avere ucciso l’Unto del Signore e che piange cordialmente sulla morte di Saulle, statogli tanto nemico, non sarebbe giunta a conoscenza dei posteri.
• Allo stesso modo è da sciogliere la difficoltà che sorge sulla morte di Antioco IV Epifane. Tre volte vien essa narrata. Nel primo libro dei Maccabei (capo 6, 1-16), è detto che Antioco, stando in Persia e bramando di impadronirsi dei tesori racchiusi nel tempio di una città della Elimaide, da una sollevazione popolare è costretto a darsi alla fuga. Intanto eccogli recate le funeste notizie delle sconfitte toccate dai suoi nella Giudea, onde ripieno di tristezza profonda muore, non già a Babilonia, come falsamente viene da alcuni interpretato, ma mentre è m viaggio alla volta di Babilonia, dove aveva intenzione di giungere. Tale il testo greco che dice: «Si ritirò per tornare in Babilonia». Nel secondo libro dei Maccabei (9, 3), Antioco, dopo la fuga di Elimaide, è fatto morire a Ecbatana (leggi Aspadana, la Gabe dei Greci, rispondente all’odierna Ispahan). È questo un particolare che rende più precisa la notizia, troppo vaga, del libro precedente, designando il punto del viaggio, ove realmente ebbe le tristi notizie della Giudea e dove, colpito da morbo schifoso e ribaltato dal cocchio, in preda alla vergogna, al dispetto, ai rimorsi, morì. Come si vede nulla di contraddittorio nei due testi. Essi si integrano a vicenda: il secondo, più ricco di particolari, illustra il primo, e in essi i due autori sacri hanno esposto direttamente il loro pensiero. Ora ecco come, invece, narra la lettera scritta dai Giudei di Gerusalemme ai Giudei di Alessandria in Egitto e riportata al principio del secondo libro dei Maccabei (2, 10-17). Antioco, trovandosi in Persia, sotto pretesto di sposare la dea Nannea, cerca d’impadronirsi dei tesori del tempio a titolo di dote. I sacerdoti fingono di accontentarlo, ma appena è entrato nel tempio, chiuse subito le porte, uccidono lui e tutti i suoi a colpi di pietre [Cfr. Zerwick, in Verbum Domini, 19 (1939), pag. 308-314. C’è chi pensa che nella citata lettera si parli di Antioco III il grande, ucciso appunto mentre voleva rapire i tesori del tempio di Bel e di Nannea in Elimaide. Ma essa parla evidentemente della morte del persecutore dei Giudei (1, 72) e non fu mai tale Antioco III. Pertanto vi si hanno da vedere riflesse le false voci che, in un primo tempo, corsero nella Giudea sulla morte di Antioco Epifane].
• La contraddizione ai due primi racconti è palese. Falsità dunque nell’agiografo ispirato? No. È una citazione, e altro è che la lettera sia stata veramente scritta quale vien riportata, e di questo ci assicura con infallibile certezza l’agiografo, altro che sia vero il suo contenuto a proposito della morte di Antioco. L’agiografo stesso tacitamente ci avverte di correggere, quando egli narrerà poi quella stessa morte in ben altra maniera al capo 9, 1-28.
• Qualche difficoltà. Questo principio che lo storico ispirato non fa sue le parole del documento citato, salvo il caso in cui le approvi o espressamente o in altra maniera equivalente, ha un’ampia applicazione, e alla sua luce si dileguano non poche difficoltà che certi critici vorrebbero far passare come altrettanti abbagli storici dell’agiografo. Leggono, per esempio, nel primo libro dei Maccabei (8, 1-17) l’elogio fatto dei Romani e della loro politica, e gridano: Ciò è falso; come è falso che il senato si adunasse (vers. 15) ogni giorno, falso che un solo eletto annualmente avesse in mano il governo della repubblica (vers. 16). Chi non sa che i consoli annui erano due? Nello stesso libro (12, 6-18. 20-23) due lettere, l’una del sommo sacerdote Gionata agli Spartani, l’altra del re spartano Areo in risposta ai Giudei, parlano di comunanza di stirpe tra Giudei e Spartani (sono fratelli e della stirpe di Abramo ). Ma chi vorrà ciò ammettere per vero?
• Ebbene con l’osservazione fatta qui sopra sarà facile la risposta. Nel primo caso l’agiografo non ci esprime il proprio pensiero, ma si limita a riferire quanto Guida Maccabeo aveva udito dire dei Romani (et audivit Iudas... 8, 1), per la voce che ne correva; che poi tal voce non rispondesse alla realtà dei fatti, è cosa in cui l’agiografo non entra. Nel secondo caso l’agiografo non fa che riportare le due lettere, ove è espressa quell’opinione; ma di suo non una parola che confermi o che approvi: tutta la responsabilità è quindi lasciata agli autori dei documenti [Parimenti quando scriverà che Giasone, già usurpatore del Sommo sacerdozio, andato ramingo in diverse parti, finalmente si ridusse presso gli spartani, sperando di trovare colà un rifugio per l’affinità di razza (quasi pro cognatione refugium habiturus - 2 Macc. 5,10), manifestamente non vi esprime il pensiero suo proprio, bensì quello di Giasone].
• Caso invece ben diverso è quando, per esempio, l’Autore del 3 e 4 dei Re e l’Autore dei Paralipomeni indicano i documenti a cui attingono le notizie che scrivono. Essi allora non riferiscono semplicemente, ma manifestamente mostrano di approvare quanto riferiscono, facendoselo proprio: perciò ce ne garantiscono la piena verità. Si osservi ancora in che differente maniera parla l’autore sacro, quando narra (2 Macc. 12, 43) che Giuda Maccabeo aveva inviato al tempio di Gerusalemme, per l’offerta d’un sacrificio a prò dei caduti in battaglia, la colletta di 2000 dramme (12000 dice la Volgata). Due idee avevano suggerito quel fatto: riguardavano l’una la finale risurrezione dei corpi con la relativa sopravvivenza delle anime dopo morte, l’altra i suffragi giovevoli a coloro che erano morti nella pietà. Ora, per l’una e per l’altra, l’agiografo appone il suggello della sua approvazione: qualifica la prima come «giudizio giusto e pio» [bene et religiose de resurrectione cogitans (Judas) vv. 43, 44]; chiama la seconda «pensiero santo e salutare» (sancta ergo et salubris est cogitatio pro defunctis exorare ut a peccatis salvantur, v. 46).
• I discorsi nei libri storici. Quanto abbiamo detto delle citazioni, lo possiamo applicare anche ai discorsi che troviamo riferiti nei libri storici della Bibbia. Anche qui indubbiamente avrà luogo la «verità della citazione» (veritas citationis) e non sarebbe lecito credere che tali discorsi siano invenzione fittizia dell’autore che scrive. Perciò ci sembra che hanno avuto torto quanti, nei discorsi dei libri dei Maccabei, pretesero che fosse salva tale verità per questo solo che quei discorsi sono conformi alle idee e all’indole di chi parla, adatti alle condizioni del tempo e come sbocciati spontanei dalla realtà stessa degli avvenimenti [Fra questi si ha da annoverare anche il Knabenbauer, Commentarius in duos libros Macch., Parisiis (1907), p. 358]. Hanno poi errato quanti, nei discorsi del quarto Vangelo, vollero vedervi «non discorsi veri e propri del Signore, ma composizioni teologiche dello scrittore, poste in bocca al Signore» (Commiss. Biblica circa l’autore e la verità storica del 4° Vangelo, 29 maggio 1907, n. 3. Cfr. anche il decreto «Lamentabili», prop. 16).
• Hanno errato quanti, col Renan (Histoire des origines du Christianisme, Tome II; Les Apotres, Paris, 1866, pag. XXVIII s.), vollero giudicare dei discorsi contenuti negli Atti Apostolici (che sono ben 27) alla stregua di quelli che ci offrono gli storici classici: Erodoto, Tucidide, Senofonte fra i Greci; Sallustio, Tito Livio e anche Tacito fra i latini; dove i pensieri elaborati dal genio di chi scrive, per artifizio retorico, sono messi in bocca or a questo or a quel personaggio, a volte per metterne in rilievo l’animo e il carattere, altre volte per descrivere, in modo più drammatico, la situazione di un dato momento. Si è detto, quanto ai discorsi riportati dagli Atti, che sono troppo brevi: tanto brevi che il più lungo di essi, quello di Santo Stefano (cap. 7), non pare possa durare più di sette o dieci minuti: or come possono aversi per autentici? Fa davvero meraviglia che l’occhio della critica siasi fatto così miope da non riuscire a vedere cosa tanto manifesta, che cioè quei discorsi San Luca li reca soltanto in compendio e non già per intero. Si è ripetuto che l’uniformità di stile in discorsi appartenenti a tanti personaggi così diversi, tradisce l’artifizio della finzione. Ma non è forse naturale che chi redige un compendio lo faccia sempre in uno stile che è lo stile suo proprio, massime quando il compendio è fatto in altra lingua da quella in cui i discorsi furono pronunziati? È il caso di San Luca che compendia e non solo, ma che, il più delle volte, compendia in lingua greca discorsi aramaici.
• Ciò posto, non si ha diritto di esigere altro che questo, che i pensieri, pur così compendiati nello stile dell’autore, siano veramente di quel dato oratore a cui vengono attribuiti. Ebbene che sia appunto così e non altrimenti, ce lo garantisce la divina ispirazione, la quale per ciò che spetta alla «veritas citationis» non può assolutamente errare. Del resto anche considerati unicamente dal lato letterario, quei discorsi mostrano tale autenticità, che il celebre filologo Fr. Blass, acattolico, poté scrivere: «Che ha da fare Luca con gli storici greci e romani, mentre non v’è neppure il minimo indizio che li abbia letti o li abbia imitati? Quanto più attentamente si considerano questi discorsi (di San Luca) tanto più si trovano ragioni che vietano di riferirli ad una libera retorica dello scrittore, tanto sono adattati egregiamente ai tempi e alle persone... Davvero mi meraviglio che in cosa tanto manifesta possano alcuni ancora dubitare» (Acta Apostolorum - editio philologica. Guttingen, 1895, pag. 11).
• Ma che pensare per ciò che riguarda alla «veritas rei citatae» e cioè al contenuto del discorso citato? Diremo subito che, ove non intervenga l’approvazione esplicita o tacita dell’agiografo, il solo fatto di essere un discorso riportato nella Scrittura non conferisce al discorso alcun nuovo valore, oltre quello che esso ha da se stesso. Esaminiamo il discorso di Santo Stefano, tenuto davanti al Sinedrio di Gerusalemme, e riportato da San Luca al capo settimo degli Atti. Quanto è ivi contenuto è tutto vero? I particolari di alcuni fatti (7, 4. 14-16) mal si accordano con i particolari che dei medesimi fatti ci dà il testo ebraico del Genesi (33, 19 cf. 23, 8-19; 11, 32; 46, 26 s.) riprodotto nella nostra Volgata, tanto che gravi autori, quali San Beda Venerabile, Dottore della Chiesa, il Beato Rabano Mauro, Melchior Cano ed altri non esitano a confessare che quelli sono errori, incorsi, per manco di memoria, durante la foga del parlare. Ebbene siano errori, non vogliamo qui discutere: diremo però che tali errori non sarà lecito mai di addebitarli a San Luca. Egli, da storico coscienzioso, ci dà, sì, fedelmente la sostanza del discorso tenuto, ma delle singole asserzioni ne lascia, come è naturale, la responsabilità a chi le ha pronunziate. Il quale, pur essendo pieno di Spirito Santo per confondere i Giudei, non consta che nel parlare fosse anche divinamente ispirato nel senso stretto della parola, in modo da non incorrere nessun errore, neanche in particolari di minima importanza.
• Citazioni implicite? Più sottile e delicata è la questione, non forse l’agiografo, senza dar segno nessuno di citazione, faccia tuttavia di fatto una citazione in ciò che narra, riportando documenti da lui posseduti, ma senza volerne garantire la veracità. È il caso delle cosiddette «citazioni implicite o tacite», mediante le quali da alcuni si vorrebbero risolte una quantità di difficoltà bibliche, specie in materia di storia. Esagerazione. Ecco a proposito il responso della pontificia Commissione Biblica. Richiesta se, per spiegare le difficoltà che si incontrano in alcuni passi della Sacra Scrittura che riferiscono fatti storici, sia lecito all’esegeta cattolico dire che in essi si tratta della citazione tacita o implicita di un documento, scritto da un autore non ispirato, di cui l’autore ispirato non intende approvare o far sue le asserzioni, le quali per conseguenza si possono considerare come non immuni da errore, rispondeva il 13 febbraio 1905 nei termini seguenti: «No, non è lecito, eccettuato il caso in cui, con buoni argomenti, si possa dimostrare: l.o) che l’agiografo davvero cita effati o documenti altrui; 2.o) che egli non li fa suoi né li approva; sicché a buon diritto si possa ritenere che non parli in nome proprio. Sempre inteso che bisogna essere disposti ad accettare il senso e il giudizio della Chiesa». E ben a ragione: perché altrimenti quel principio potrebbe aprire la via a infinite applicazioni errate e condurre a un dubbio metodico e a un pratico scetticismo circa il reale valore e l’oggettività della storia biblica.
• Le genealogie bibliche. Un’altra osservazione conviene tener presente. È un canone di senso comune, che ogni testo, dunque anche il sacro, debba essere spiegato nella luce della mentalità di chi scrive, e secondo l’indole particolare e la proprietà del linguaggio in cui scrive: linguaggio che in determinati casi potrà essere affatto convenzionale. Perciò pretendere che la verità sia espressa secondo un dato criterio particolare, o peggio, sia espressa secondo i criteri propri di noi occidentali, di noi figli del nostro secolo, sarebbe un’esorbitanza ridicola. Noi, per esempio, in una genealogia siamo soliti enumerare con accuratezza i singoli anelli della serie genealogica, e ci suonerebbe male, se un individuo determinato apertamente si dicesse figlio o generato da tale che in realtà è il suo nonno o bisnonno o altro più remoto antenato. Sono questi gusti e costumi nostri, ma senza paragone differentissimi dai gusti e costumi dei semiti e in genere degli orientali. Per essi «figlio» è sinonimo di «discendente», perciò dirlo generato da un suo antenato, qual che esso sia, è cosa usuale e corrente, massime quando lo schema genealogico è fatto per uno scopo mnemonico. Orbene lo scritto ispirato rispecchia quest’usanza, e chi, applicando ad essa i criteri nostri, presume di coglierla in fallo, non fa che mostrare la propria imperizia circa la conoscenza dei costumi di età e di popoli che non sono i nostri. Esemplifichiamo.
• Troviamo nei primi capi del Genesi che, posto a capostipite Adamo, ci viene tracciato un albero genealogico dei patriarchi che si succedono. Ma di che genere è questa successione? Immediata o mediata? Di questo tace la Scrittura, e benché dei singoli anelli dica sempre che il precedente generò il seguente, posta la spiegazione data più sopra, noi non siamo obbligati a vederci l’una piuttosto che l’altra successione, dal momento che l’una e l’altra vi possono aver luogo. «Quindi lo parole, per esempio, Sem a 100 anni generò Arfaxad e visse di poi cinquecento anni si possono spiegare in questo modo: Sem a cento anni generò un tale N. da cui (per una serie di membri non determina in individuo e dopo un tempo non indicato) fu generato Arfaxad». Un indizio, poi, che la successione non sia immediata potrebbe essere il modo artificioso onde paiono disposti i Patriarchi nella loro genealogia: sono dieci prima del diluvio (Gen., 5), parimenti dieci (Così nella versione greca dei 70, dove tra Arphaxah e Sale viene interposto Cainan. Cfr. Luc., 3, 36) dopo il diluvio (Gen., 11, 10 e seg.). Che proprio tanti e non più siano stati così prima come dopo il diluvio, non par credibile e chi dicesse che sotto il numero simbolico di dieci si nasconde lo scopo mnemonico, non andrebbe lontano dal vero. Da quanto abbiamo esposto, risulta che è impresa da non mai venirne a capo voler fissare l’anno del diluvio partendo dall anno della creazione dell uomo. Abbiamo un bell’addizionare gli anni dei singoli patriarchi, nominati nel capo 5 del Genesi, ma sappiamo noi le lacune che tra l’uno e l’altro poterono intervenire? Si aggiunga che, per colpa di copisti, facili ad alterare le cifre nella successiva trascrizione dei codici, l’età stessa assegnata ai singoli patriarchi spesso varia secondo i diversi testi (Massoretico, Samaritano, Settanta) e conseguentemente varia la somma totale. Questa, infatti, secondo il testo Massoretico (e quello della Volgata), sarebbe di 1.656 anni; secondo il Pentateuco Samaritano di 1.307; secondo la versione di Settanta di 2.262. Con dati di tal genere ognuno vede l’impossibilità di stabilire una vera e propria cronologia da Adamo al diluvio. E altrettanto si dica dal diluvio ad Abramo, appoggiati al capo 11, 10-26 del Genesi, per le stesse ragioni. Adunque poiché nulla di preciso afferma la Scrittura, qualunque sia l’epoca che, in base agli studi geologoci e paleontologici, si assegni al diluvio, non si avrà mai nulla che contraddica alla Bibbia.
• Degno di considerazione è un altro esempio del Nuovo Testamento. San Matteo, nel tessere l’albero genealogico di Gesù Cristo (1, 1-16) lo divide nettamente in tre gruppi: da Abramo a Davide, primo gruppo; da Davide all esilio di Babilonia, secondo gruppo; dal ritorno dall’esilio fino a Gesù Cristo, terzo gruppo. In ognuno di essi numera quattordici generazioni: vi sono però lacune che appaiono evidenti in più d’un punto, non causate davvero da ignoranza, ma appositamente volute. Così, a tacer d’altro, nel 2° gruppo (v. 8) tra Ioram e Ozia sono omessi i Re Ochozia, Gioas e Amasia, eppure si continua a dire: Ioram generò Ozia, come fin dal principio non dubita di chiamare Gesù Cristo figlio di Davide e Davide figlio di Abramo, e così prosegue in seguito la successione come se avvenisse sempre da padre in figlio con sempre lo stesso verbo tecnico: «generò». E una genealogia così fatta, senza alcun timore di vederla o contraddetta o ripudiata, San Matteo la presenta agli occhi dei suoi connazionali, come prova irrefragabile di un punto capitale, che cioè Gesù di Nazareth è il Messia aspettato, perché verifica in sé la prima delle condizioni del Messia, quella di essere discendente di Davide (È assai probabile che nello schema genealogico adottato da San Matteo la ragione simbolica vi entrasse anche per qualche cosa, se si considera che le tre consonanti del nome di David, prese nel loro valore numerico ebraico e insieme addizionate, danno appunto il numero 14. Infatti dalet uguale 4; vav uguale 6; dalet uguale 4; onde si ha 4 più 6 più 4 uguale 14 in ogni serie, ossia tante volte David quante sono le serie). Dato lo scopo mnemonico a cui si mira, data l’ampiezza di significato che ha la voce «figlio» e il verbo «generare», quella genealogia, benché in sé incompleta, sta indubbiamente nei limiti della verità. Anche San Luca (3, 23-32) segue l’istessa norma, tessendo a sua volta la genealogia di Gesù, non però in linea discendente, come fa San Matteo, ma in linea ascendente da Gesù ad Adamo. Enumera così una serie di settantasette membri, chiamando sempre il precedente figlio del seguente, quantunque venga a omettere parecchi degli anelli intermedi. E così la conoscenza degli usi genealogici presso gli Ebrei ci illumina a conoscere la verità storica della Scrittura in fatto di genealogia, nonostante la singolarità del modo onde viene proposta.
• In San Luca il numero degli antenati nel periodo che va da Davide a Gesù Cristo è di molto maggiore che non in San Matteo: di più sono tutti nomi diversi, tranne due: Salatiel e Zorobabele. Secondo una sentenza che ha la sua probabilità, San Luca ci avrebbe riferito gli antenati di Maria Vergine. Altri sostengono che anche qui abbiamo descritti gli antenati di San Giuseppe, non però secondo la genealogia naturale, come in San Matteo, ma secondo la genealogia legale. Difatti la legge detta del Levirato, dal latino Levir uguale cognato, (Deut. 25, 5-6) così diceva: «Se dei fratelli abitano insieme e l’uno di essi muore senza figli, la moglie del morto non dovrà maritarsi a un estraneo, ma il suo cognato (Levir) se la piglierà per moglie e il primogenito che essa darà alla luce andrà sotto il nome del fratello defunto, né sarà cancellato il nome di costui di mezzo a Israele». In forza di questa legge Eli, essendo morto senza figli, il fratello suo Giacobbe ne dovette sposare la moglie, onde il primogenito di questo matrimonio, Giuseppe, era figlio di Giacobbe per discendenza naturale, ma figlio di Eli per discendenza legale. Un’altra spiegazione è stata proposta, appellando a un genere speciale di adozione, in uso presso gli Ebrei, per cui in certi casi, il genero (nel caso nostro San Giuseppe sposo di Maria ) entrava a far parte della famiglia del suocero (nel nostro caso della famiglia di Eli, padre di Maria) in qualità di figlio adottivo del suocero stesso...
• Usi linguistici ebraici. E non meno ci illuminerà la conoscenza dell’uso linguistico proprio dell’Oriente e degli Ebrei in particolare. L’universalità del diluvio. Una difficoltà insormontabile parve a molti l’ammettere che il diluvio abbia inondato tutta quanta la terra (universalità geografica assoluta). Leggevano infatti al capo 7 del Genesi che Dio determinò di sterminare dalla faccia della terra tutti gli esseri da lui fatti (verso 4), che le acque del diluvio predominarono e aumentarono grandemente sopra la terra e copersero tutti i più alti monti che sono sotto il cielo (verso 19), che fu consumata ogni carne che ha moto sopra la terra, gli uccelli, le bestie, le fiere e tutti i rettili (verso 23). D’altra parte mille difficoltà accampava la scienza contro una siffatta universalità geografica; difficoltà d’una serietà indiscutibile. Come salvare la verità della Bibbia? Ricorrere a una moltiplicazione di miracoli, sempre facili a supporre ma difficilissimi a provare? Non occorre. Basterà ricordare una semplice norma di ermeneutica, ma assai importante, che cioè la Scrittura usa talora modi di dire convenzionali per cui «tutta la terra», «sotto ogni parte del cielo», (e per conseguenza tutti i monti e tutti gli animali che vi sono contenuti), sono espressioni che si limitano al cosiddetto orizzonte geografico, ossia alla terra, al cielo, ai monti, agli animali che sono conosciuti da chi parla o nell’ambito del soggetto di cui si parla, e nulla più.
• E non è questa un’asserzione gratuita, trovata per il bisogno della causa. Altri esempi abbiamo proprio nello stesso Pentateuco. Leggiamo al capo 41 del Genesi che, al sopravvenire della carestia dei sette anni predetti da Giuseppe, in tutte le regioni prevalse la fame (verso 54); che da tutti i paesi si veniva in Egitto a comprare grano da Giuseppe, essendo grande la fame in tutta la terra (verso 57). Ora queste espressioni nessuno pensò mai ad estenderle all’intero globo terrestre: tutti le hanno sempre ristrette alle regioni vicine all’Egitto. Parimenti nel Deuteronomio (2, 25) il Signore dice: «Oggi comincerò a mandare il terrore e lo spavento sopra i popoli che abitano sotto qualunque parte del cielo ». Ora è chiaro che si tratta non di altro che dei popoli limitrofi alla Palestina. Del resto, anche il terzo libro dei Re, al cap. 10, 23-24, quando ci farà sapere di Salomone che tutto il mondo desiderava di vederlo per udire la sapienza di cui Dio l’aveva fornito, tutto ciò si dovrà intendere con la restrizione che lo stesso libro ebbe segnato al capo 4, 34, quando scriveva: «Da tutti i popoli e da tutti i re della terra, quanti avevano udito parlare della sua sapienza, si veniva a udire la sapienza di Salomone». E San Luca, quando parlerà dell’editto di Cesare Augusto per il censimento di tutto il mondo (2, 1), non vorrà significare l’intero mondo abitato, ma soltanto l’impero romano; e quando dirà che nel giorno della Pentecoste erano a Gerusalemme uomini di tutte le nazioni che sono sotto il cielo (Atti 2. 6), in questa espressione egli non comprenderà se non quelli che poco dopo enumera nominatamente (Atti 2, 9), e che sono ben lungi dall’essere tutte quante le nazioni della terra. Adunque la stessa Scrittura ci insegna che siamo in pieno diritto di applicare a un’universalità relativa parole che, prese in sé, suonerebbero universalità assoluta. Si dirà che, stando a questi principii, si potrebbe negare anche l’universalità antropologica del diluvio e non solo la geografica e la zoologica. Difatti se le parole «tutta la terra», «ogni carne», possono essere intese in senso ristretto, perché non si potrà fare lo stesso dell’espressione «tutti gli uomini»? Qui entriamo in una questione più delicata. Primieramente tutti gli uomini ben possiamo supporli circoscritti tuttora in una determinata regione, se facciamo indietreggiare la data del diluvio in un tempo assai più vicino ad Adamo di quanto non si sia fatto: cosa che non ci è punto vietata. Di poi non c’è da esitare: se per la formazione di certe razze e di certi linguaggi la scienza antropologica riuscisse a dimostrare la necessità di ammettere l’esistenza di uomini non toccati dal diluvio, non per questo la Scrittura sarebbe in fallo. La Bibbia non è una stona del mondo, ma solo del popolo di Dio, sicché nel racconto del diluvio, essa perde di vista tutti gli altri uomini che non hanno relazione con la storia della Redenzione. Agli occhi dell’autore sacro i «figli di Dio» discendenti da Set, e le «figlie dell’uomo» le donne cioè di quelle nazioni in mezzo alle quali vivevano i Patriarchi, costituivano «tutti gli uomini» dei quali Dio aveva decretato la distruzione. Quando il mondo patriarcale è corrotto, tutta la terra è corrotta.
• Anche il P. Vaccari così nota al nostro proposito: «Che il diluvio non si sia esteso a tutto l’orbe terracqueo è ora sentenza comune di tutti gli interpreti cattolici: non sarebbe stato fisicamente possibile. Sulla sua estensione relativamente agli uomini non regna uguale unanimità. I più tengono ancora con gli antichi che si estese a tutti gli uomini senza eccezione. Altri, in piccolo ma crescente numero, opinano che neanche per gli uomini il diluvio fu universale. Si appoggiano da una parte sui dati delle scienze profane (etnografia, glottologia, ecc.), dall’altra sulla Bibbia stessa che... non si occupa dei rami laterali, che non hanno relazione con la storia del popolo eletto. Il diluvio fu un tremendo castigo della corruzione esposta (6, 1-5), e l’arca di Noè, fuori della quale tutti perirono, è simbolo della Chiesa, fuori della quale non vi è salute (1 Piet., 3, 20); al valore di questa doppia lezione basta che il diluvio abbia raggiunto tutti i colpevoli e che tutti gli uomini a cui si estese il diluvio vi siano anche periti, tranne i rifugiati nell’arca. Se la scienza veramente dimostrerà che non tutti gli uomini perirono nel diluvio noetico, non perciò potrà accusarsi la Bibbia d’errore». (La Sacra Bibbia tradotta dai testi originali, Vol. I, p. 77-78. Firenze, Salani, 1943). • I “fratelli” di Gesù. Quando l’eretico Elvidio perfidiava in negare la perpetua verginità di Maria SS. ricorrendo alla Scrittura, giocava d’astuzia, con falsare il punto di vista donde si hanno da guardare e intendere locuzioni e vocaboli. Leggeva nei Vangeli medesimi e in altri passi del Nuovo Testamento che si attribuivano a Gesù dei fratelli; tanto gli era bastato per menare trionfo. Trionfo stolto. È infatti risaputo che gli Ebrei, come in generale i Semiti, poverissimi di termini che distinguano fra loro i vari gradi di parentela, solevano con uno stesso vocabolo (’ach; aram, ’acha) designare non solo il fratello propriamente detto, ma anche il nipote, anche il cugino e in generale tutti i congiunti di qualunque grado fossero: ed è del pari risaputo che questo uso, in tutta la sua ampiezza, si è riflesso nella voce adelfós della versione greca dei LXX (Basti pensare che oggigiorno spesso si usa dire «fratello» addirittura ad un caro amico, ndR). Perciò nessuna meraviglia che la locuzione usata a significare i congiunti di Gesù, sorta nell’ambiente aramaico della primitiva catechesi, passando nel linguaggio greco, trovasse senz’altro il vocabolo adelfós come suo corrispondente, al modo stesso che era avvenuto presso i LXX in casi analoghi. Ed ecco la locuzione oi adelfoi toú Iesoú, oi adelfoi toú Kyriou = fratres Jesu, fratres Domini, che indica non altro se non i congiunti di Gesù. Di questi si danno anche i nomi: sono Giacomo, Giuseppe, Giuda e Simone, ma nessuno di essi mai è detto né nei Vangeli, né altrove figlio di Maria o di Giuseppe, anzi ai due primi (Giacomo e Giuseppe) si assegnano espressamente il proprio padre, Alfeo o Cleofa, e la propria madre Maria, sorella = parente di Maria SS.ma (cf. Matt. 27, 25; Marc. 11, 40; 16, 1; Giov. 19, 25). Il senso pertanto voluto vederci da Elvidio, con attribuire alla parola fratelli un unico significato, è falso.
• La solita sua astuzia usava Elvidio, quando pretendeva di rincalzare il suo argomento con l’appiglio alle parole di San Matteo, ove è detto che «Giuseppe non conobbe Maria, sua sposa, fino a che ebbe partorito il figlio suo primogenito» (1, 25). Un nuovo tentativo di falsare il punto di vista donde si hanno a guardare e intendere locuzioni e vocaboli. Il pensiero è ivi espresso mediante una proprietà linguistica, ben conosciuta nella Scrittura, la quale, nel dire che una cosa non fu fatta fino a un memento indicato, lì fa punto e non procede oltre. Avvenne di poi, non avvenne? Non se ne dice nulla, la cosa deve giudicarsi da altri criteri. Ecco, per esempio, dei passi ove l’avverbio «àd ki = fino a tanto che» esclude evidentemente l’avveramento ulteriore di ciò che si dice non essere avvenuto. «Micol non ebbe figli fino a tanto che morì», così nel secondo libro dei Re (6, 23). Da questa espressione chi sogna mai di inferire che la Scrittura attribuisca dei figli a Micol dopo la morte? «Nessuno conobbe la tomba di Mosè sino al giorno presente», così nel Deut. (34, 6). Chi sogna mai di credere che quella tomba si sia trovata di poi? Adunque la semplice locuzione: «ciò non fu fatto fino a tanto che...» non dà alcun diritto a concludere che dopo sia avvenuto davvero.
• Gesù “figlio primogenito”. Ma, s’insiste ancora, Gesù non è forse chiamato figlio primogenito? Sì, non però da San Matteo, il cui testo critico manca di quell’appellativo, bensì da San Luca il quale scrive: «(Maria) partorì il figlio suo primogenito» (2, 7). Ora Elvidio esclamava: «Primogenito non si può chiamare se non chi ha fratelli dopo di sé». Falso, ribatteva già San Girolamo, falso è l’asserto di Elvidio. E il grande dottore che non ha pari nell’interpretare le Scritture, con gli esempi alla mano, mostrava che nell’uso biblico, unica autorità in materia, il nome di primogenito è dato senz’altro al primo nato, senza ancora sapere se altri ne vengano dopo o no. Tale il caso della legge, ripetuta a più riprese (Es. 13,2.12.15; 34,19; Lev. 27,26; Num. 8,16), la quale comandava che ogni primogenito, ossia, (si noti la spiegazione data dalla Scrittura stessa) ogni maschio uscito il primo dal seno materno, fosse consacrato e offerto al Signore e che fosse riscattato con lo sborso di 5 sicli (circa 20 lire) un mese dopo la nascita. La legge chiama adunque primogenito colui che fu generato per il primo, colui che è tuttora unico, necessariamente unico e unico potrebbe in seguito rimanere. Tale pure il caso dell’ultima piaga dell’Egitto, ove afferma la Scrittura che tutti i primogeniti furono uccisi dall’angelo sterminatore. Si noti bene: tutti i primogeniti. O diremo che quanti non ebbero altri generati dopo di sé siano stati risparmiati? La supposizione è semplicemente ridicola. Prosegue la prossima settimana... a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, le prime pagine della Sacra Scrittura ci narrano, con un sapore ed una freschezza incomparabili, le relazioni dei primi uomini verso il loro Creatore e Signore: Iddio parla ad Adamo e ad Eva, essi parlano con Dio, si scusano con Lui del loro fallo; i loro figliuoli offrono vittime espiatorie e propiziatrici, animali del gregge e frutti della terra (Genesi, capp. 2. 3, 4). La religione degli uomini più antichi, quindi, quale ci viene presentata dal Sacro Testo, è il più puro monoteismo; solo più tardi troviamo narrate le aberrazioni idolatriche a cui si abbandonarono i figli degli uomini. Con l’aiuto del P. Giovanni Caprile - «La religione dell’umanità primitiva», SOS, imprimatur 1942 - impareremo perché queste affermazioni della Scrittura possono reggere ancora di fronte alle numerose scoperte scientifiche, o pseudo tali, di questi ultimi tempi.
• Lo negarono i fautori del materialismo e dell’evoluzionismo religioso, i quali pretesero dimostrare che l’ateismo più crasso, quale può essere quello delle bestie e di uomini recentemente differenziatisi da esse, fu il primo patrimonio religioso dell’umanità, mentre il monoteismo non sarebbe stato che il termine di una lunga evoluzione.
• Il punto cruciale. II punto vitale della nostra questione, quindi, consiste nello stabilire, su basi scientifiche, quale fosse la religione dell’umanità dei tempi preistorici. Se troviamo l’ateismo, l’evoluzionismo religioso avrà trionfato; se invece troviamo il monoteismo, esso (l’evoluzionismo) resterà battuto in pieno. Di quali mezzi ci serviamo? Non esistono documenti scritti: i dati della paleontologia si restringono a scheletri e manufatti, più raramente a pitture o a pseudo scritture indecifrabili e sono tali che, se ci parlano a favore dell’esistenza di riti e, quindi, di un sentimento religioso, non ci dicono in quale forma questo si concretizzasse. Ma uno studioso non può né deve trascurare un fatto che, in realtà, è proprio quello che nella storia della Religione può gettare maggiore luce sulle sue origini.
• Al presente vivono ancora, in molti punti del globo, popolazioni la cui civiltà è enormemente arretrata rispetto alla nostra: vivono, cioè, a quel grado di cultura in cui vivevano i nostri antenati migliaia di anni or sono. Studiando presso di essi il fenomeno religioso possiamo agevolmente almeno avvicinarci alle sue origini. Questi popoli, però, non presentano tutti la stessa forma di religione, né si trovano ad un unico livello di civiltà: c’è quello che ha scoperto l’uso della ruota e quello che ancora trascina i suoi carichi; c’è chi usa armi di ferro, chi si contenta di semplici pietre scheggiate e chi non conosce nemmeno queste. Il problema allora si sposta su un altro piano: quale di questi popoli cosiddetti incivili è quello che ha mantenuto il più possibile la cultura dei primi uomini e, quindi, si avvicina di più ad essi? Assodato questo, sarà facile indagare e stabilire la forma di religione predominante presso tali popoli e concludere che essa è la meno lontana da quella professata dalla vera umanità primitiva. Per giungere a dimostrare scientificamente le nostre conclusioni vedremo: quale presupposto abbiano avuto gli evoluzionisti e quali teorie vi abbiano imbastito sopra: porteremo prove positive per dimostrare quali popoli fra quelli ora esistenti sulla terra, siano i più antichi; esporremo infine le loro credenze religiose. Compiuti diligentemente questi passi, le conclusioni si imporranno da sé.
• Il presupposto fondamentale dell’evoluzionismo. «Il metodo della storia delle religioni deve essere scientifico e storico e deve tendere in quanto è possibile a conoscere tutti i fatti in relazione al proprio oggetto e stabilire l’apparizione e la successione dei fatti religiosa non in base a principii aprioristici, ma in base ai fatti e alla portata legittima dei fatti» (Polestra, Religione, in Dizion. Encicl. Fedele, vol. IX, pagg. 436.439). Ora, appunto in questo peccò il metodo degli evoluzionisti: partiva, come da presupposto provato ed ormai indiscutibile, proprio da quella stessa verità che voleva provare; e cioè che: «È necessariamente di età più antica tutto ciò che c’è di più basso, di simile allo stato bestiale, di brutto; invece tutte le cose più perfette sono prodotti di stadi di evoluzione più elevati e perciò più recenti» (Schmidt, Manuale di Storia comparata delle religioni, Brescia, Morcelliana, 1934, pag. 9). Quindi nel campo familiare vi sarebbe stata all’inizio una bestiale promiscuità: solo più tardi il matrimonio a gruppi e poi monogamico; in religione dall’ateismo originario, come affermava il Lubbok (L’origine della civiltà e la primitiva condizione dell’uomo, Londra, 1870), attraverso complessi stadi evolutivi si sarebbe giunti al monoteismo. Queste erudite quanto gratuite costruzioni di tavolino furono a lungo, e non sempre per puro zelo di scienza, salutate come conquiste scientifiche intangibili. Eppure non c’è lettore che non veda la debolezza di questo modo di argomentare: anticipare gratuitamente le conclusioni e servirsene come di principii, per giungere ad esse.
• Popoli areligiosi. Il punto di partenza del fenomeno religioso sarebbe stato, dunque, l’ateismo. È proprio vero? Prendendo il fenomeno religioso nella sua universalità, senza determinare alcuna forma particolare, vediamo che è costituito «dalla fede in un essere superiore, unico o molteplice, con la conseguente certezza d’una dipendenza vitale da quest’essere del mondo e dell’uomo, che non rimane più contemplatore, ma crea relazioni drammatizzate (concretate) in un riconoscimento di questa sua dipendenza mediante un culto sensibile, culminante nel sacrificio» (Polestra, Op. cit., pag. 438); orbene: possiamo oggi affermare che nessun popolo conosciuto, tra quelli estinti o tuttora esistenti è assolutamente privo di ogni forma di religione? Non i popoli estinti. La paleoetnografia ha completamente sfatato la premessa su cui si basava la loro asserita areligiosità. Nel 1883 il De Mortillet scriveva: «II primo risultato di tutte le idee religiose è di far temere la morte o almeno i morti. Ne segue che da quando le idee religiose si fecero strada, si introdussero le pratiche funerarie. Ebbene non vi è pratica funeraria per tutto il paleolitico [Il paleolitico è il periodo umano remotissimo in cui gli utensili e le armi si fabbricano scheggiando la selce. Questo periodo è suddiviso in: paleolitico inferiore (il più antico) medio e superiore]. L’uomo del paleolitico era completamente sprovvisto di ogni sentimento religioso» (G. De Mortillet, La préhistorique. 1900, G. e A. De Mortillet, La préhistoire. Paris, Schleicher, 1910, pag. 292). E suo figlio aggiungeva: «L’uomo discendente dagli animali, si avvicinava troppo ai suoi antenati scimmieschi per avere una religione e dare sepoltura ai morti» (L’origine du culte des morts, in Goury, Origine et évolution de l’homme, Paris, Picard, 1927, pag. 134).
• I fatti, però, parlano altrimenti. Gli scheletri delle grotte di Grimaldi, nella Liguria, presentano segni di evidente inumazione: «Le tre salme (uomo, donna, bambino) erano state accuratamente inumate in una fossa scavata... e poste l’una accanto all’altra su di uno strato di ocra. Ciascun corpo era stato sepolto con i suoi ornamenti: collane fatte con conchiglie marine, vertebre di pesci e denti di cervidi» (Graziosi, I Balzi Rossi, Albenga, 1937, pagg 23-24). E risalendo ancora a periodi più antichi, al paleolitico medio: «Lo scheletro della Chapelle aux Saints era interrato in una fossa della profondità di 30 cm. scavata nel suolo duro della grotta. Sulla testa tre o quattro pietre piatte e sopra queste delle ossa di bovidi, prova evidente che erano state deposte con la carne, perché servissero da nutrimento al morto nell’oltretomba» (Goury, op. cit., pag. 136). Gli scheletri della Ferassie, appartenenti allo stesso periodo, erano ricoperti con pietre piatte sulla testa e sul tronco, come nel caso precedente. Così due scheletri di fanciulli in luoghi distinti sono disposti in posizione non dubbia per attestare che vi ebbe luogo una sepoltura. La testa di uno di essi è ricoperta da una specie di cupola (Furon, Manuel de préhistoire generale, Paris, Sajot, 1939, pag. 102). Concludendo col Goury: «Esiste all’epoca mousteriana (paleolitico medio) un vero culto dei morti che si manifesta per l’identità della disposizione del cadavere deposto in fosse scavate intenzionalmente, e, in mancanza di queste, protetto da pietre, nell’atteggiamento del sonno» (Origine et évolution de l’homme, Paris, Picard, 1927, pag. 137 cfr. anche Graziosi, Le civiltà preistoriche, in R Biasutti, Le razze e i popoli della terra, Torino, UTET, 1941, vol. I, pag. 146).
• Questi uomini, dunque, avevano una qualche religione. Quale fosse non possiamo saperlo. Per giungere ad una conclusione non arbitraria dobbiamo tentare un’altra via: interrogare i popoli primitivi tuttora esistenti. Riguardo alla pretesa areligiosità degli attuali popoli di natura, i più moderni risultati dell’etnologia l’hanno definitivamente relegata tra le asserzioni gratuite della pseudo scienza. La terza parte dell’opuscolo giustificherà la nostra affermazione. Né è il caso di prendere in esame la affermazione circa lo «stato prelogico» dell’uomo primitivo, che sarebbe una cosa di mezzo tra la bestia e l’essere razionale, né altre di questo genere: «I primitivi non distinguono ciò che appare nel sogno da ciò che è vissuto nella veglia....; fuori della cultura materiale appaiono indifferenti ai nostri principii logici di identità, di contraddizione, di causalità eccetera» (Canella, Principii di Psicologia razziale, Firenze, Sansoni, 1941 pagg. 157-158). Quando il Levy-Bruhl ed i suoi simpatizzanti tracciarono simili asserti non impiegarono che pochi secondi e pochi tratti di penna; più laboriosa ne riuscirebbe la dimostrazione. Invece l’ingegnosità e la varietà dei metodi e degli strumenti da caccia e da pesca, degli utensili domestici; le manifestazioni artistiche, ecc (Lowie, Manuel d’anthropologie culturelle, Paris, Payot, 1936, Capp. 3, 5, 6, 8, 9, 11 - Schmidt, L’anima dei primitivi, Roma, Studium, 1931) dimostrano che anche i più primitivi conoscono i nostri principii logici, le nostre nozioni di causa e di effetto, di fine e di mezzo.
• Il punto di partenza dello sviluppo religioso. Man mano che, nella prima metà del secolo scorso, furono meglio conosciuti i popoli di natura dell’Africa, dell’Oceania, dell’America, l’attenzione degli studiosi si rivolse alle loro religioni che spesso presentavano forme grossolane. Era quello che aspettava l’evoluzionismo religioso! Ogni nuova forma conosciuta venne allora proclamata la più antica: i sistemi si susseguono e si accavallano. Sarà compito del nostro secolo sgombrare il terreno da tante macerie e costruire, su basi solide, qualcosa di positivo. I viaggiatori portoghesi, venuti a contatto con i popoli dell’Africa occidentale, furono colpiti da un fatto strano: quegli indigeni tributavano atti di culto a oggetti materiali, come pietre, vasi, conchiglie. Già nel 1760 il De Brosses (Du culte des Dieux fétiches, Paris, 1760) rendeva noto all’umanità che una tal forma di culto (feticismo) doveva riguardarsi come punto di partenza di tutto il pensiero religioso, evolutosi in forme superiori presso i popoli civili, rimasto invece stazionario presso quelli di bassa cultura. La stessa opinione fu abbracciata dal Comte e dalla scuola positiva. L’inglese Spencer, invece, credette di aver trovato una soluzione migliore assegnando al culto e venerazione degli antenati (manismo) il primo gradino nell’evoluzione religiosa. Un suo contemporaneo, il Tylor, la pensava un pò altrimenti. A suo parere i fenomeni del sonno, del sogno, dell’estasi, della morte avrebbero destato nell’uomo l’idea di uno spirito che può abbandonare il corpo in cui abita e che può sopravvivergli in una vita d’oltretomba.
• Per la tendenza a prendere se stesso come misura delle cose l’uomo avrebbe, in seguito, attribuito un’anima a tutto ciò che lo circondava (animismo). Dal culto dei morti, dovuto alla fede nella sopravvivenza dell’anima, si sarebbe passato al concetto di puri spiriti e al politeismo. Il monoteismo sarebbe dovuto all’innalzare di grado uno di questi dei e concepirlo superiore agli altri. Altri sistemi credono di trovare nelle pratiche magiche la spiegazione dell’origine di ogni idea religiosa. Per accennare ad uno dei tanti, ecco la spiegazione del Frazer (Il ramo d’oro, Londra, 1890): Il primitivo concepisce il mondo come governato da forze personali aventi, come lui, intelletto e volontà, e da forze impersonali, le quali sarebbero, in pratica, le leggi della natura. Secondo che l’una o l’altra concezione del mondo prevale, si ha la religione o la magia. Questa, però, sarebbe più antica, perché solo dopo aver constatato la sua impotenza a domare queste forze cieche e impersonali, l’uomo si sarebbe rivolto alle potenze personali del bene e del male, propiziandosele con sacrifici e preghiere.
• Alcuni popoli assumono, come insegna comune a tutti gli individui di una tribù, una classe di oggetti o di esseri naturali: animali, piante, ecc. Tale classe di oggetti (totem) costituisce come un essere solo: se, per esempio, il totem di una tribù è l’orso, tutti gli orsi — e non un determinato orso — saranno oggetto di venerazione. Il totem viene ad essere considerato come un antenato di tutta la tribù e questo legame di parentela si esprime, in pratica, attraverso riti di vario genere, tra cui caratteristica la proibizione di ammazzare l’animale o di sradicare la pianta con cui la tribù si crede imparentata. Senza fermarci a mostrare i punti deboli di queste teorie e senza negare loro il merito d’aver lumeggiato queste forme di religiosità e le loro probabili origini, notiamo solo che metterle alla base dello sviluppo religioso è contro ogni dato di fatto: queste forme, presso i popoli antichissimi e quindi più vicini alle origini dell’umanità, o sono affatto sconosciute, o occupano un posto molto secondario, mentre di fronte ad esse si erge ben definita l’idea di un unico Essere supremo.
• Sul retto sentiero. Si era a questo punto, quando un fatto imprevisto gettò lo scompiglio fra gli uomini di “scienza”: lo scozzese Andrew Lang rese noto al pubblico che, nel corso dei suoi studi, aveva trovato presso certi popoli primitivi la venerazione per un Essere supremo, considerato come autore e tutore dell’ordine morale, come Creatore e Padre benevolo e buono. Queste affermazioni incontrarono dapprima la più fiera opposizione, poi furono circondate di sprezzante silenzio. A questo stato di cose pose termine la scuola storico-culturale, che in Germania, in Inghilterra, in America e in altri paesi trovò valenti cultori. Essa, che si distingue per la serietà del suo metodo oggettivo, conta fra le sue schiere i più illustri scienziati come Graebner, Ankermann, Schmidt, Pinard: de la Boullaye, Baumann ecc., e va imponendosi su tutte le altre scuole.
• Il metodo storico-culturale per individuare i primitivi. Prescindendo da qualsiasi sistema e dottrina religiosa, la scuola storico-culturale è riuscita a determinare vari criteri per valutare l’antichità di un popolo: è infatti, come notammo, su questo punto che si impernia tutta la questione sulla forma più antica di religione. Per la portata del presente lavoro basterà esporne solo qualcuno: Il primo criterio è dato dall’esame della cultura materiale e cioè del genere di vita, del modo di lavorare gli utensili ecc.: quanto più tale cultura è semplice, tanto più il popolo che la possiede è primitivo e simile ai primi uomini. Non c’è bisogno, infatti, di nessun sistema filosofico per ammettere che gli uomini più antichi conducessero un genere di vita più rozzo (non più bestiale), più semplice che non i popoli giovani, che lavorassero più grossolanamente le loro armi, i loro utensili, le loro abitazioni ecc. In questo la Bibbia e la Paleoantropologia vanno pienamente d’accordo. L’una e l’altra ci affermano che l’uso dei metalli fu molto posteriore a quello della pietra. Così pure più recenti sono la coltivazione dei campi e il grande allevamento del bestiame.
• Il secondo criterio è dato dal confronto e dall’esame delle zone e dei cicli culturali (Chiamiamo ciclo culturale quell’insieme di elementi vari che costituiscono la civiltà di un popolo. Così, per es., diciamo che tutti quei popoli, i quali non conoscono l’agricoltura ed usano utensili di pietra, appartengono ad un ciclo culturale diverso da quello dei popoli che conoscono l’agricoltura e i metalli. Qui intendiamo per ciclo culturale quei popoli che hanno una certa forma di civiltà, si capisce allora com’è che si può parlare di contatti, separazioni ecc. Lo stesso significato diamo a «zona culturale»). In un continente, per esempio in Africa, c’è un’enorme diversità di razze, di linguaggi, di civiltà. Non è da credere che tutti questi elementi si siano sviluppati sul posto che ora occupano, indipendenti l’uno dall’altro. Certamente, come ce lo conferma anche la storia, vi saranno state immigrazioni e emigrazioni in massa, invasioni e cozzi di popoli con prevalenza dei più forti.
• In tutto questo groviglio di civiltà è possibile stabilire quale sia la più antica, quali i popoli invasori e gli oppressi? Il lavoro è possibile per determinate zone. Gli elementi presi in esame sono la cultura (linguaggio, modo di vivere, utensili ecc.) e la posizione geografica. Due cicli culturali possono venire a contatto fra loro in maniera diversa. Si è riscontrato che, a volte, un popolo appartenente a un ciclo culturale attraversa un altro popolo che appartiene a un ciclo culturale diverso, tagliandolo in due, in modo che le due parti separate restino fra loro senza contatto, così come un fiume di lava vulcanica separa nettamente in due le floride campagne che attraversa. È chiaro che in tal caso, nel posto della separazione, il popolo tagliato è più antico di quello che lo taglia; altrimenti bisognerebbe ammettere che il popolo invasore, a un certo punto, ha scavalcato il popolo oppresso, senza passarvi in mezzo, o almeno senza lasciarvi traccia alcuna: supposizione, questa, molto innaturale. Ma c’è ancora un altro caso da considerare: molte volte troviamo due zone culturali distinte fra loro e disperse l’una nell’altra in questo modo: l’una è continua così come il mare che circonda un gruppo di isolotti; l’altra è frammentata e dispersa nella prima, come tanti isolotti nel mare. Dobbiamo ritenere che la zona culturale frammentata è più antica di quella in cui è dispersa. A meno che non si voglia immaginare, cosa assai difficile, che il popolo invasore si sia disperso in mezzo al popolo invaso. È invece più naturale pensare che quest’ultimo, non potendo resistere, si sia ritirato in luoghi più sicuri benché meno comodi. Infatti si osserva che questi frammenti di popoli abitano sempre luoghi di difficile accesso (monti, foreste vergini, posti paludosi), isolati e di poca attrattiva a popoli più giovani e progrediti.
• In base a questi criteri si può stabilire, dapprima per le singole regioni, poi per ogni continente, la successione e l’età dei singoli cicli culturali che vi si trovano. Meta ultima di questi studi è conoscere la diffusione dei vari cicli culturali su tutta la terra e, confrontandoli fra loro, stabilire quale di essi sia il più antico di tutti, che ordine abbiano avuto nel succedersi ed in quale regione debba ricercarsi la loro origine. Oggi questa meta è ancora lontana, ma si possono determinare alcune norme sicure, tra cui per il nostro scopo è importantissima la seguente: un ciclo culturale che in ogni parte del mondo, in cui ancora oggi si trova, è riconosciuto come il più antico rispetto alle altre civiltà limitrofe, è in via assoluta il più antico di tutti. Se, per esempio, studiando i popoli dell’Africa risulta quale cultura più antica quella dei Pigmei; studiando i popoli dell’Australia, della Terra del Fuoco, della Siberia, dell’Indonesia ecc. risulta pure come più antica una cultura corrispondente a quella dei Pigmei africani, si dovrà concludere che questa forma di cultura è assolutamente la più antica su tutti i continenti. Si noti, infine, che questi criteri si applicano l’uno indipendentemente dall’altro. Applicati insieme conducono al medesimo risultato, il che è una potente garanzia della loro bontà e serietà. Per esempio, i popoli di civilizzazione più primitiva (primo criterio) li troviamo ai limiti estremi dei continenti o sparpagliati in piccoli gruppi separati fra loro, rifugiati in luoghi remoti e circondati da altri aventi una civiltà più progredita (secondo crit.).
• I risultati. Si sono venuti così a determinare tre gradi di cultura: primitivo, primario o secondario. Al grado primitivo appartengono quelle tribù in cui l’uomo vive ancora nello «stadio della raccolta»: non lavora la terra né alleva il bestiame ma vive di quello che la natura spontaneamente gli offre. L’uomo va a caccia o alla pesca, la donna raccoglie erbe e radici selvatiche. Al grado primario appartengono quei popoli che sono passati dalla pura e semplice raccolta dei prodotti della natura alla coltivazione dei campi e all’allevamento del bestiame. Nel grado secondario si trovano nuovi cicli culturali risultati dall’incrocio di culture primarie fra loro o con culture primitive. Si notano progressi culturali. A un ciclo culturale terziario appartengono le antiche grandi civiltà asiatiche, europee, americane. La cultura più antica è quella del grado primitivo. «Tutte e tre assieme sembrano poi farci intravedere una cultura ancora più antica, la vera cultura primordiale, la quale però finora non si poté scoprire concretamente in nessun luogo e che probabilmente non sarà più possibile constatare in via diretta ed immediata» (Schmidt, Manuale di Storta comparata delle Relig.). Per citare qualche nome di popoli primitivi ricordiamo: nell’Africa i Bagielli nel Kamerum, i Negrilli ecc.; nell’Asia gli Andamanesi, i Negritos delle Filippine, i Samojedi e i Korjaki nelle zone fredde dell’Artide; in America: alcune tribù della Terra del Fuoco (Yamana), della California (Algonchini ecc.); e infine nell’Australia alcune tribù sud-orientali: Kurnai ecc..
• L’antichità della cultura primitiva. I popoli appartenenti al grado primitivo sono, fra quelli conosciuti, i più antichi. Ciò è stato stabilito con i criteri già esposti: essi occupano generalmente le più remote regioni alla periferia dei continenti, regioni isolate e quasi inaccessibili, che rappresentano le ultime zone di rifugio. Ivi essi sono i primi e gli unici abitatori, né vi si riscontra traccia di abitatori precedenti. Nella stragrande maggioranza questi popoli vivono allo stadio della raccolta: le poche eccezioni sono dovute ad evidente influsso di popoli vicini. Gli utensili e le armi sono generalmente di pietra; non si conoscono i metalli. Alcune tribù di Pigmei non conoscono la lavorazione della pietra e usano solo quelle pietre piatte e levigate che la natura mette a loro disposizione. Gli Andamanesi e i Bakango (Congo Nord-est) non sanno neppure produrre spontaneamente il fuoco (Lowie, Manuel d’anthropologie culturelle, Paris, Payot, 1936, pag. 71). Possiamo quindi concludere che questi popoli, appartenenti al grado culturale primitivo, sono i più antichi ceppi umani che attualmente possiamo conoscere e quindi debbono ritenersi i più vicini all’umanità primitiva.
• Ci si presenta ora spontaneo un quesito: Siamo sicuri che questi popoli oggi esistenti anno proprio la stessa civiltà che avevano i loro antenati migliaia di anni or sono? Certo non si può dire che ne posseggano tale e quale, immutata, tutta la civiltà, anche nei suoi minimi particolari: in fin dei conti non sono delle mummie e sono, quindi, suscettibili di progresso o di regresso. Però si può anche affermare che essi hanno una civiltà molto vicina a quella dei loro più remoti antenati e ne conservano moltissimi elementi. Infatti nello sviluppo di questi popoli è intervenuto un curioso fenomeno di congelamento, di stagnazione; a un certo punto, mentre altri popoli progredivano, essi si sono fermati, quasi fossilizzati. Invece di avanzare in linea retta verso il progresso, lasciandosi definitivamente alle spalle la vecchia civiltà, si sono aggirati per secoli e secoli più o meno attorno ad uno stesso centro: è sorprendente il parallelo tra la civiltà di questi popoli attuali e di quelli più antichi scoperti nelle ricerche paleontologiche. I fattori che determinarono questo fenomeno di stasi possono ridursi ai seguenti: l’isolamento di questi popoli, abitanti in luoghi remoti quasi del tutto privi di ogni rapporto con altri; l’assenza del bisogno: fornendoli la natura di tutto il necessario, essi non sentirono il bisogno di perfezionare o trovare nuovi strumenti con cui procurarsi di che vivere. Di qui l’arresto nello sviluppo della civiltà materiale; l’attaccamento alle tradizioni della tribù, frutto istintivo dell’isolamento e della segregazione. Da ciò ebbero la loro origine i riti di iniziazione con i quali, all’epoca della pubertà, si trasmette gelosamente ai giovani il patrimonio culturale della tribù. Molte volte tali riti comprendono cantici e preghiere in una lingua antichissima e incomprensibile agli stessi indigeni e che solo la loro tenacissima memoria permette di trasmettere ai posteri.
• La religione. Le religioni dei primitivi hanno una grande importanza: da esse, come da quelle che sono relativamente più vicine alla prima origine dell’umanità e contengono, quindi, ancora molte particolarità di essa, si dovranno prendere le mosse per studiare questa stessa origine del fatto religioso. Tale affermazione richiede due integrazioni. Prima di tutto, appunto perché queste religioni non hanno più progredito, esse hanno subito un irrigidimento e un abbassamento di intima vitalità. Quindi è da escludersi che le forme di religione dei primitivi possano conservare ancora tutto il calore e la ricchezza che furono proprie, per esempio, della religione dei Patriarchi. In secondo luogo: ammettendo un’origine unitaria e unica del genere umano e considerando i differenti cicli culturali del grado primitivo (Nel grado primitivo si comprendono popoli di razza e civiltà molto diverse, i quali, però, sono tutti caratterizzati dal vivere nello stadio di raccolta) è chiaro che tali differenziazioni hanno richiesto un periodo di sviluppo abbastanza lungo tra la vera origine e il formarsi di quelle differenti culture, durante il quale anche la religione avrà subito modificazioni non indifferenti.
• Se, dunque, lo studio delle religioni dei primitivi non ci dà la forma di religione che fu propria dell’umanità originaria, si può legittimamente dedurre quale questa fosse, raccogliendo quanto tutte queste religioni contengono di comune. È chiaro che l’elemento comune deve considerarsi anteriore agli elementi propri e particolari. Ora, l’elemento comune alle religioni primitive è la fede in un Essere supremo unico. Presso alcune tribù questo è chiarissimo; presso altre è offuscato, mai però tale da degenerare in politeismo. Un’ultima deduzione: queste tribù primitive che hanno tali credenze, abbracciano, nella loro distribuzione geografica, come in una cintura, il centro meridionale del mondo antico e, nel fenomeno di repulsione agli estremi nascondigli di isole sperdute, di foreste inaccessibili e montagne boscose, dimostrano dovunque che la loro presenza in quelle regioni era un tempo ben più estesa e compatta. Inoltre esse arrivano fino agli estremi confini della terra, da un polo all’altro: nessun ciclo culturale posteriore può vantare tale diffusione.
• Se, dunque, è certo che dovunque compaiono ancora ruderi di popoli appartenenti alla cultura primitiva essi possiedono tutti la credenza in un Essere supremo, si può concludere che questa credenza formi una parte essenziale di quell’antichissima cultura umana e che fece parte di essa, forte e profonda, già in quei remotissimi tempi quando quei singoli gruppi non erano ancora divisi l’uno dall’altro. Dopo questo lungo, ma necessario lavoro di messa a punto, non ci resta che illustrare le credenze religiose di questi popoli, per dedurne, secondo i principii indicati, quale dovette essere la religione dell’umanità primitiva.
• Figura e nomi dell’Essere supremo. Il concetto dell’Essere supremo è tanto più puro quanto più la tribù è primitiva. Alcuni popoli, come i Negritos, i Batwa, gli Andamanesi dicono che l’Essere supremo non si può vedere, ma solo sentire: è inafferrabile come il vento. Gli Yamana della Terra del Fuoco, quando lamentano la morte di una persona cara, vorrebbero vedere l’Essere supremo, Watauinewa, che la ha rapita, ma Egli è invisibile e non lo si può raggiungere. Altri popoli gli danno figura umana, ma con qualche tratto che manifesta una personalità superiore: così lo dicono «vecchio, dalla lunga barba, splendente di candore, simile al fuoco...». I nomi, molteplici ed espressivi, sono pronunciati solo raramente e col massimo rispetto; in molti casi si preferiscono circonlocuzioni o qualche segno, come per esempio indicare il cielo con la mano. Gli appellativi più comuni sono quelli che esprimono la paternità, l’opera creatrice, la dimora nel cielo. «Padre, mio padre celeste, il divino costruttore dei mondi, il Creatore della vita, creatore del mondo, colui lassù in alto... ». Altri nomi si riferiscono agli attributi di Dio «il vecchio, l’antichissimo, il divino padrone del Cielo, il donatore, sostegno (dell’universo), culla (del bambino), l’altissimo, il fortissimo, il maestro, l’onnipotente, il vigilante, l’eterno...». Attributi dell’Essere supremo. Già i nomi dati a Dio da questi popoli ci avranno stupito, mostrandoci tanta ricchezza là dove meno si immaginava. L’impressione non si cancellerà esaminando gli attributi di questo Dio. Eternità: quasi tutti i primitivi affermano che l’Essere supremo è sempre esistito e sempre esisterà. I Wiradyri dell’Australia, usano per Bajame, il loro essere supremo, una parola esplicita, che significa «eternità» (bur-rambin). I Pigmei dell’Africa equatoriale dicono che «prima (che ci fossero gli uomini) c’era Kmvum (l’Essere supremo), Kmvum solo, Kmvum senza nessun altro con lui», e, richiesti se esso fosse o no mortale, risposero: « Dopo la notte il giorno, dopo l’albero un altro albero, dopo la nuvola un’altra nuvola, dopo di me un altro uomo; e Dio è là; Dio non muore, della morte Egli è il padrone».
• Onniscienza: l’Essere supremo vede le azioni degli uomini e sa tutto, specialmente i loro errori. «Nulla esiste — dicono i Batwa del Ruanda — che Imana (Essere supremo) non sappia: egli sa tutto», conosce anche i segreti peccati di pensiero, penetra gli intimi moti del cuore, anche di notte. I Dama della montagna dicono: «Gawab è dappertutto e sa tutto», e i Wanyika: «Dovunque tu vada Dio ti vede». Bontà: l’Essere supremo, il Padre, è buono; perdona volentieri i peccati, vuole gli uomini felici, li invita a rivolgere a lui la loro fiduciosa preghiera, promettendo di aiutarli; se manda la morte è «per punire il male». Onnipotenza: una qualità, che contraddistingue in modo speciale l’Essere supremo della cultura primitiva è la sua illimitata potenza. Di lui alcune tribù australiane dicono che può andare dappertutto e fare quel che vuole. Gli Yamana dicono che «tutto viene sempre e solo dall’alto. Watauinewa dà la vita, dà i bambini, ma manda pure la morte. Può guarire gli ammalati, salvare dai pericoli, mandare il bel tempo». Egli è il padrone del suolo, degli animali; l’uomo coltiva il territorio che egli gli ha dato e non deve abusare dei suoi doni. Virtù creatrice: la creazione è il massimo atto dell’onnipotenza. Mai questa virtù è negata esplicitamente; tutt’al più è ignorata: un vecchio Yamana confessava all’esploratore Gusinde: «Non è la prima volta che mi si presenta questo dubbio.... Ho meditato in proposito e ne ho domandato ai grandi maghi e ai vecchi più autorevoli, ma nessuno ha saputo dirmi donde e come gli uomini sono venuti. Perciò non ne so nulla». Presso altre tribù, invece, abbiamo perfino l’idea di Creazione dal nulla! E pensare che nemmeno Aristotele, col suo ingegno, v’era arrivato. Così l’Essere supremo dei Maidu chiama per nome il sole, la luna, le stelle ed esse sorgono dal nulla. Gli Achemaw hanno un Creatore che fa venire a se col pensiero un pezzo di terra e lo lancia nello spazio vuoto per formare il mondo. Del Dio dei Wiyot si racconta: «Egli fece le cose congiungendo le mani e allargandole. Non adoperò nessun strumento, né sabbia, né terra, né verghe, per fare gli uomini: soltanto pensò, ed essi furono».
• L’origine della prima coppia umana è generalmente attribuita all’Essere supremo, che ne plasma il corpo e ne infonde l’anima. Ecco un racconto dei Pigmei, che sembra ricalcare, sia pure contraffacendolo in più punti, quello della Genesi (Cap. II): «Quando Dio ebbe finito di creare ogni cosa si sedette sulla sponda del ruscello vicino al grande villaggio degli animali. E il nome di Kmvum era Bali (forse il pensante). E prese della terra nera, della terra nera presso il ruscello e ne fece delle statuine, delle cose con braccia, gambe, teste e prese della terra rossa e prese della terra bianca... E la terra nera fece gli uomini neri, la terra rossa fece gli uomini rossi (cioè i Pigmei)... Ed Egli disse agli uomini: “Camminate”, e camminarono; “Mangiate e bevete”. (ex omni ligno Paradisi comede). Ed ecco a un tratto che Rhe, la grande scimmia, e Lui, il Gorilla, vennero tutti curiosi, saltando e sgambettando: “Su, su veniamo a vedere gli amici”. E Kmvum si rizzò irritato: “No, non è così che si deve dire, ma invece: È il nostro capo che veniamo a vedere”». (Trilles, Les Pygmées de la Forèt equatoriale, Paris, Muenster, 1932, pag. 70 citato dal Boccassino in Azione fucina, n. 14, 1939.).
• Molte popolazioni credono anche che i primi antenati abbiano visto l’Essere supremo, giacché alle origini avrebbe abitato presso di loro insegnando la caccia e le cerimonie sacre. Ma poi, per qualche colpa degli uomini, si sarebbe ritirato da loro. C’è chi crede — come pochi gruppi di Pigmei Africani — che un giorno forse ritornerà; pensano che Kmvum, anche dopo di essersi ritirato «là in alto», si curi ancora di loro. Secondo gli Algonchini di California, l’Essere supremo, essendo per sé sommamente buono, ha creato anche il mondo e tiene in mano la sorte di tutta l’umanità. Egli vuol tenere lontano dagli uomini la malattia, la morte ed anche ogni specie di agitazione e di disillusioni; i primi uomini vivevano in una regione dove esistevano in quantità selvaggina, pesci, e uccelli; il suolo produceva quanto occorreva all’uomo. Lavoro e fatica dovevano essere risparmiati; divenuto vecchio l’uomo doveva trasportarsi in alto, presso l’Essere supremo: beveva ad una fonte, si bagnava in un’altra e veniva rivestito di giovinezza immortale. In questo luogo di delizie l’uomo era in pace, ma Coyote, lo Spirito cattivo, non permise di goderne: indusse i primi uomini a disubbidire all’Essere supremo, ed allora essi furono espulsi da quel luogo. Con ciò entrarono nel mondo le fatiche, il lavoro, la malattia, le disillusioni, la morte...Per i Peda del Dahomey, è il serpente che induce gli uomini al male e Dio lo condanna aspramente: «Tu striscerai sempre nella terra, sarai calpestato, esposto tutto nudo agli sguardi degli uomini e resterai così disonorato...» (Aupiais, in Revue Apologétique, Maggio 1938). Anche la vita di ogni uomo dipende dall’Essere supremo: parecchi popoli (Semang, Ainu, Korjaki, ecc.) credono che egli infonda l’anima a ogni individuo.
• Il concetto della moralità. Tra tutti i primitivi, più o meno praticata, esiste una legge morale spesso molto elevata. Essa ha per base l’idea di un Essere supremo legislatore, perché padrone degli uomini. La sfera di tale legislazione non si estende egualmente presso tutti i popoli. Generalmente parlando, i precetti da essi conosciuti si riferiscono alle cerimonie e al culto, al rispetto degli anziani e della vita umana, alla moralità sessuale, al dovere di soccorrere i vecchi, i bisognosi, gli infermi. I giovani vengono istruiti ufficialmente nei loro doveri dagli anziani della tribù, durante le feste di iniziazione. Però l’ultima sorgente di tutte le regole e proibizioni è l’Essere supremo: «Bada bene — dicono i vecchi — noi anziani non abbiamo inventato le leggi e le prescrizioni vigenti; queste provengono tutte dall’Essere supremo. Se tu sarai negligente nell’osservarle, noi non te lo potremo impedire, ma l’Essere supremo vede le tue azioni ed il suo castigo certamente li raggiungerà». Se la moralità dei primitivi non è generalmente di basso livello, significa che essi osservano di fatto i divieti e i precetti dell’Essere supremo. Per essi il peccato è una disubbidienza fatta, a Dio.
• L’Essere supremo e l’ordine morale. Egli non è solo legislatore ma anche vindice della legge morale. Alcuni primitivi affermano che il premio in terra consiste in una lunga vita; il castigo nella malattia e in una morte prematura. Tutti, senza eccezione, credono in una vita futura e moltissimi anche in una sanzione. Secondo gli Andamanesi, Puluga, il Creatore, giudica le anime subito dopo la morte e pronuncia per ciascuna di esse la sentenza, inviandole o in Paradiso o in una specie di purgatorio. Qui possono purificarsi aspettando il giorno della resurrezione, in cui l’anima e il corpo di tutti gli uomini si ricongiungeranno per una nuova vita felice, che Puluga farà sorgere dopo un terremoto che distruggerà la terra. La speranza di sfuggire ai tormenti dell’altra vita influisce sulla condotta di quegli isolani. Per alcuni la vita dei buoni nell’oltretomba è una ripetizione di quella terrestre; altri escludono esplicitamente i piaceri dei sensi, il cibo, la procreazione, la sofferenza e la morte. Così i Maidu, i Wiradyri ecc.
• La sorte dei cattivi è chiaramente descritta come una punizione: per i Negrilli Ajongo c’è la pena del fuoco e del calore; per altri quella del freddo e del girovagare senza pace. Per gli Acciuabo l’anima cattiva, partendo dal mondo, passerà sul filo che conduce da questa vita alla felicità, ma il filo si spezzerà ed essa piomberà per sempre nella palude sottostante. Alcune tribù di Pigmei affermano che numerosi spiriti circondano il morente e, se fu cattivo, ne conducono l’anima al fuoco che si trova sotto terra. Gli Australiani raccontano che, in antico, quando gli uomini avevano dimenticato i buoni costumi, l’Essere supremo li punì mandando l’incendio e il diluvio universale.
• I precetti della legge morale. Diamo qualche esempio di quelli che si trovano più in vigore presso i primitivi. II nome di Dio non è pronunziato che raramente e con grande rispetto. Se nell’eccesso del dolore si danno a Dio dei titoli poco onorifici, come quello di «crudele», lo Yamana non va a letto senza aver chiesto perdono. I figli devono riverenza e obbedienza ai genitori, agli anziani, a quanti hanno autorità. Sono espressamente vietati l’affronto, l’insulto, la calunnia, l’avvelenamento, la rapina... Tra gli Andamanesi si è tenuti a risarcire i danni arrecati ad altri. Gli stessi, come pure i Ba-vili, condannano la menzogna come un grave peccato che provoca l’ira del Creatore. Ecco ancora qualche altro precetto: Se tuo padre è già morto e vedi un uomo bisognoso di qualche cosa, dagli ciò di cui ha bisogno e non mandarlo via dicendo: non ho niente a che vedere con lui... Se t’accorgi che un vecchio non è riuscito a raccogliere legna sufficiente per la notte, corri subito a raccogliere legna per lui. Con tuo marito non devi litigare per ogni piccolezza, altrimenti diventa impaziente e scontento... Sii operoso e non litigare con altri.
• Il senso del pudore. Secondo gli evoluzionisti la vita sessuale presso i primitivi sarebbe bestiale: invece non è così. Spiccato è il senso del pudore. Presso i Semang il P. Schebesta osservò che, quando un giovanotto, in presenza d’altri, pronunziò delle frasi oscene — in genere ivi molto rare — un uomo adulto si alzò di scatto gridandogli minaccioso: «Lawaid Karei! questo è un peccato contro l’Essere supremo Karei» e il giovane zittì all’istante. In una serie di tribù di questo stadio di civiltà (australiani sud-orientali, Negritos, Korjaki) troviamo il dovere della castità preconiugale tra le ragazze rigorosamente richiesto e quasi sempre osservato; eventuali trasgressioni sono punite severamente. Se in qualche luogo c’è meno rigore, ogni licenza cessa quando la ragazza ha concepito; colui poi che ne fu la causa deve sposarla. In questa antichissima fase non esistono matrimoni a gruppi, né promiscuità, né donne a prestito, né scambi di donne. Non vi sono i misfatti dell’aborto e dell’infanticidio: quest’ultimo o è affatto sconosciuto o, nei pochi casi in cui si verifica, non è dovuto a indifferenza dei genitori verso i figli, né ad assenza di idee morali, ma a gravi strettezze economiche. I peccati contro natura sono quasi affatto sconosciuti, come pure gli spettacoli e balli indecenti o le orge sessuali, sia segrete sia pubbliche, di qualsiasi genere.
• La famiglia. La monogamia è la forma nettamente più dominante nella società primitiva e molto più diffusa della poligamia. L’indissolubilità del vincolo matrimoniale non è dappertutto uguale, ma meno rigida tra i primitivi settentrionali. Presso i Pigmei d’Africa il matrimonio non si scioglie più quando ne è nato un bambino. Molto rara è anche l’infedeltà coniugale; essa è punita con pene severe, anche con la morte. La donna gode in generale diritti uguali a quelli del maschio e nella scelta ha valore soltanto la libera volontà dei due sposi, lasciando larga possibilità ai veri matrimoni d’amore. I figli sono allevati con affetto; la famiglia consuma i pasti in comune; l’autorità paterna è tenuta in grande considerazione. Il matrimonio fra consanguinei è severamente vietato presso quasi tutte le tribù: violare questo precetto sarebbe attirare su tutti i castighi del cielo.
• Gli atti di culto. Si riducono a due principalmente: sacrificio e preghiera. Parecchie tribù ignorano qualsiasi forma di sacrificio; fra quelle che lo conoscono la forma unica o predominante è l’offerta delle primizie: dopo la caccia o la raccolta delle piante, prima che alcuno osi toccare il cibo, piccole parti di questo vengono offerte all’Essere supremo, gettandole in alto, per riconoscerne il dominio su tutte le cose. Così presso i Pigmei. I popoli del ciclo artico usano offrire le parti migliori dell’animale. I Semang della Malesia praticano un sacrificio singolare: quando imperversa il temporale — segno per essi dell’ira di Dio — si cavano un poco di sangue dalla gamba e, misto all’acqua, lo lanciano verso il cielo con umili invocazioni di perdono e di pentimento. Se il temporale non accenna a cessare, ognuno confessa ad alta voce le sue colpe. L’offerta di cibo ai defunti è ignota presso quasi tutte le tribù primitive: quindi non si può ricollegare ad essa l’origine del sacrificio. La preghiera è quanto di più espressivo abbia l’animo di questi popoli: sentimenti di fiducia, di riconoscenza, di ricorso filiale, di pentimento: «Grazie, o Padre mio, che sei stato oggi benevolo verso di me». Etc... Preghiere belle, umane ed anche naturalmente cristiane!
• Sintetizzando in pochi tratti, possiamo concludere così: I Popoli primitivi non sono perciò stesso i più barbari e i più bestiali. Se posseggono una civiltà materiale appena abbozzata, hanno anche un livello morale molto elevato rispetto a popoli più progrediti. Forme di degenerazione religiosa o non si trovano presso di essi o sono di secondaria importanza e dovute per lo più all’influsso di popoli vicini. Di fronte a questi culti si afferma nettamente la fede in un unico Essere Supremo, Padre, Creatore, Vindice, Perfettissimo... Questi popoli, cristallizzatisi in un ordine di idee e presentanti una civiltà antichissima, debbono considerarsi come i più vicini rappresentanti, finora conosciuti, della umanità primitiva. Però il patrimonio culturale e religioso di questi popoli, ridotto a brandelli e disseminato su tutto il globo, è come la ganga che fa luccicare un filone d’oro: lascia cioè almeno intravedere quale fosse la vera forma primitiva di religione immensamente più ricca di forza e di vita. Al presente, non siamo ancora in grado di dare con esattezza e sicurezza scientifica una risposta positiva alla questione dell’origine dell’idea del gran Dio della cultura primitiva e della religione che a lui si riferisce. Siamo però in grado di dare alcune risposte negative in varie direzioni; possiamo cioè enumerare una lunga serie di elementi dai quali quella religione certamente non è derivata. Sono questi tutti quegli elementi sopra i quali si costruirono le molte teorie sull’origine della religione: il Feticismo, il Manismo, l’Animismo, il Totemismo, la Magia. La religione del gran Dio (Monoteismo) esiste proprio presso i popoli, lo abbiamo visto, più antichi, pertanto non può essere risultante di evoluzione. Proprio presso i popoli più antichi i suddetti elementi o non esistono affatto, come il Totemismo, il Feticismo, l’Animismo; oppure si manifestano, come la Magia e il Manismo, in forme debolissime, così deboli da essere per noi ininfluenti. Quindi le parole della Bibbia circa il Monoteismo dell’umanità primitiva, lungi dall’essere in contrasto con i dati della scienza, ne ricevono una bella conferma.
A cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, ancora oggi e nonostante la storia sia stata maestra di verità, non pochi avventori sostengono che «il comunismo ed il socialismo non sono irriducibili nemici della religione». Ed ancora, essi dicono, «socialismo comunista e cristianesimo, pur partendo da diversi punti, si incontrano in un comune ideale di giustizia sociale e di pace». Essi vedono, quindi, «possibile un’intesa, almeno sul terreno pratico, per il bene della travagliata società moderna». Si risponde mostrando l’opposizione assoluta tra comunismo, socialismo e cristianesimo, tale da escludere ogni possibilità di intesa. Nell’odierna ricerca ci faremo aiutare dal P. Clemente Cavassa, «Comunismo e Cristianesimo», SOS, imprimatur 1944.
• I fondamenti filosofici del comunismo. Prima d’entrare nel vivo della questione, è necessario dissipare un equivoco che trae in inganno non pochi, e chiarire la distinzione che corre tra comunismo dottrinale e sistematico, e comunismo sentimentale, fatto di aspirazioni generose verso una giustizia maggiore, una maggiore uguaglianza e carità. Inasprito od esasperato da noncuranze e da abusi purtroppo reali, l’operaio trova questo povero mondo mal organizzato; trova incomodo e troppo piccolo il posto ch’egli vi occupa; troppo disagiata la sua esistenza. Quindi aspira naturalmente ad una migliore retribuzione del suo lavoro e ad una maggiore assistenza sociale, ad un’atmosfera più fraterna, in cui cessi finalmente l’esasperante contrasto fra il proletario che stenta e l’ozioso che sperpera. E là dove l’autorità non si degna di andare incontro all’operaio ed ai suoi giusti desideri, non c’è da meravigliarsi che l’operaio vada ad accrescere le file dei comunisti e dei socialisti, che gli promettono, anche se poi non mantengono, l’attuazione delle riforme desiderate. «Il comunismo di oggi — disse SS. Pio XI, nella Enciclica sul comunismo — in modo più accentuato che in altri simili momenti del passato, nasconde in sé un’idea di falsa redenzione. Uno pseudo ideale di giustizia, di uguaglianza, di fraternità nel lavoro, pervade tutta la sua attività di un falso misticismo, che alle folle adescate da fallaci promesse, comunica uno slancio ed un entusiasmo contagioso, specialmente in un tempo come il nostro, in cui da una distribuzione difettosa delle cose di questo mondo risulta una miseria non consueta».
• Il comunismo, però, è una dottrina totalitaria; non è soltanto una concezione particolare della proprietà del lavoro, della produzione, degli scambi, dei rapporti sociali, ma è anche una dottrina filosofica, ha cioè una concezione sua propria della vita e dei fini dell’uomo, dalla quale fa derivare le norme che devono dirigere l’uomo nella ricerca e nella pratica dei doveri verso di sé e verso la collettività. Ed i capi del comunismo definiscono non poter essere vero comunista chi solo segue la sociologia o l’economia del comunismo e ne lascia da parte la filosofia; a quel modo che vero cattolico non è chi ritiene l’insegnamento sociale della Chiesa e ne trascura i dogmi.
• Dottrina materialistica. Il fondamento filosofico del comunismo, così come è professato da Federico Engels dopo il Marx, ed ora dopo Lenin da Stalin è il materialismo, ossia l’affermazione del primato della materia su tutti gli altri valori umani, che tende quindi a far prevalere il fattore economico nella visione del mondo, considerandolo come l’unico modo di far trionfare in esso la verità e la giustizia. La dottrina materialistica si può riassumere così: Quando il mondo divenne atto a contenere esseri viventi la vita apparve sulla terra; e quando questi esseri viventi si perfezionarono talmente da possedere un cervello capace di produrre e di albergare un pensiero umano, il pensiero fece la sua comparsa e l’animale si trovò uomo. Non c’è pensiero possibile senza materia; il pensiero che non sgorghi dalla materia è un’assurdità. Non vi è dunque un Essere supremo, Autore del mondo, della vita e degli uomini; non un Legislatore supremo, il Giudice dei vivi e dei morti, al quale è dovuta l’adorazione e l’obbedienza degli uomini.
• I comunisti ed i socialisti cacciano dal mondo Iddio, l’anima immortale, tutto ciò insomma che non è materia o prodotto dalla materia. E anche la storia del genere umano con le sue guerre, le sue rivoluzioni, le sue crisi, viene da ciò che l’uomo produce i mezzi della sua vita materiale. Da principio gli uomini, semplici animali più perfetti, nella lotta contro la natura, cioè col lavoro, avevano acquistato forme umane; e, fieri della prima vittoria contro la natura, vivevano felici e possedevano tutto in comune. Fu quella l’età dell oro del comunismo primitivo, essi sostengono.
• Lotta di classe. Ma ben presto succedette la decadenza dovuta alla proprietà privata; a mano a mano un’infima minoranza accumulava la ricchezza e il potere, mentre la moltitudine piombava nella miseria e nella schiavitù, gemendo sotto l’oppressione; l’uomo fu sfruttato dall’uomo, e la storia non fu più che una successione di guerre e di delitti, d’ingiustizie e di orrori. «Tutta la storia dell’umanità — dice il Marx — è la storia della LOTTA DELLE CLASSI». Al mondo, caduto nella miseria, ecco ora brillare la stella rossa della redenzione, redenzione pur essa totalmente materialistica. Adagio, adagio nonostante gli sforzi degli oppressori — cantano i comunisti — le forze disperse degli oppressi si ritrovano, si raggruppano, intimano la guerra agli oppressori. L’inesorabile lotta finale, a cui i comunisti invitano il genere umano, è il sacrificio supremo, è la condizione indispensabile alla nascita dell’umanità nuova, nella quale tutti gli uomini saranno uguali, né vi saranno più né ricchi, né poveri, né oppressi, né oppressori, ma tutti saranno felici ugualmente, e il paradiso, costruito dalle mani dell’uomo, rifulgerà di nuovo sulla terra! (Cfr. G. Ledit - La nuova condanna del Comunismo, in Civiltà Cattolica 1937, II, pp. 19-27.).
• Per capire come un’ideologia, così strana e in perfetto contrasto con l’esperienza storica, abbia potuto sorgere nella mente di un uomo, converrà tener presente che Carlo Marx era un ebreo: l’idea messianica del «regno di Dio» è rimasta in fondo ai suoi sogni devastatori ma spogliata di ogni contenuto religioso: il proletariato è quasi il novello Israele che aspetta il suo messia, il quale — come molti israeliti scettici dei tempi moderni pensano — non sarebbe già un personaggio, ma un periodo storico di perfetta giustizia sociale, quasi un’età dell’oro a preparare la quale un fiume di sangue, se sarà necessario, dovrà scorrere per imprimere il movimento ai popoli del mondo. Ed è indubitato che, sulle orme di Marx, molti altri israeliti di talento lavorano nei vari stati a favore del comunismo e del socialismo per l’avvento di questo paradiso in terra affatto materiale e tutto pervaso di una concezione materialista.
• Il Comunismo marxista è contro la religione. Ecco una verità che va bene affermata e che vogliamo provare con argomenti irrefutabili se mai ve ne fosse ancora bisogno, dopo i fatti di orribile odio antireligioso avvenuti nella Spagna e che hanno destato raccapriccio in ognuno che conservi senso di umanità. Il marxismo è nato con un aperto programma anti idealista, ma più ancora antireligioso, essendo la religione l’affermazione ideale più potente dell’uomo, radicata fin dentro il suo essere così da farlo chiamare animal religiosum: e giustamente poiché il fatto di essere animal rationale — animale ragionevole — pone l’uomo nella possibilità e anzi nella necessità morale di riconoscere nelle creature l’opera del Creatore e lo pone quindi, quasi istintivamente, di fronte a Dio.
• Per il marxismo, invece, la religione è un’invenzione degli sfruttatori; Carlo Marx la definisce anzi l’oppio dei popoli e ad essa oppone due idee fondamentali e quanto mai feconde di sviluppi pratici: 1) La lotta per l’emancipazione della massa popolare va unita a quella antireligiosa; 2) il proletario ha una vocazione messianica alla quale deve rispondere per liberare l’umanità. Ora, è certo che il comunismo ha bensì mutato in parte il marxismo, ma ne ha rispettato pienamente il carattere antireligioso, come dichiara espressamente Nicola Berdiaeff. Lenin dice la religione «la vodka del popolo» e afferma che la canaglia idealista è il gran nemico del comunismo perché la credenza in Dio e la religione intralciano i desideri e lo sviluppo delle forze dell’uomo e la sua felicità in questo mondo, con la chimerica attesa di una vita migliore e definitiva nell’altro.
• La morale stessa è ridotta dal comunismo agli interessi della lotta delle classi, ossia all’interesse materiale e viene chiamata morale (comunista) scientifica, all’infuori e contro, se occorra, di ogni comandamento di Dio, naturale o positivo; tutto diviene lecito e anzi santo, perché il fine è santo: abolire le classi, per fare giustizia nella libertà. Già il Marx aveva scritto: «La coscienza è determinata dal regime», perciò quello capitalistico, giustificandosi con una legge eterna voluta da Dio, dirà ai lavoratori sfruttati e oppressi: sopportate in pazienza e umiltà ... per la felicità celeste. E ai ricchi: fate beneficenza — così li giustifica e dà il biglietto d’ingresso alla vita eterna: ecco l’assenzio nel quale gli schiavi del capitalismo affogano la figura di uomini. «Bisogna dunque combattere energicamente la religione — dirà Lenin — ecco l’A. B. C. del marxismo integrale». Atei, quindi, sono i marxisti bolscevichi e in genere tutti i comunisti moderni, militanti per estirpare fin le radici sociali della religione.
• Metodi di propaganda. Tuttavia la lotta e la propaganda contro la religione potranno essere rinviate a tempi più adatti là dove il popolo le è ancora fortemente attaccato; bisognerà prima trascinare i lavoratori alla lotta di classe, farne dei militi attivi della collettività, mostrando loro che la religione non è che l’effetto del timore che loro aspira la potenza cieca del capitale. Ma non mai la religione potrà essere considerata dal comunismo come un affare privato, così come dichiara lo stato borghese: il quale la confina nella coscienza dell’individuo e nella famiglia, come anche permettono alcuni socialisti. I mezzi per svellerla però saranno scientifici, non già violenti, fin che sarà possibile; perché l’ateismo militante — afferma il Berdiaeff — non si prenderà il piacere sadico di privare l’uomo delle sue illusioni, come neppure si sforzerà di togliergli la credenza in Dio col terrore, la persecuzione e il martirio. Se tali mezzi tuttavia sono usati, ciò avviene come di «misure politiche di repressione dei controrivoluzionari».
• Mezzi scientifici. Mezzi ordinari, invece, e veramente efficaci sono quelli scientifici, ossia il miglioramento della situazione agricola, la costruzione di vie di comunicazione, la messa in valore dei trattori meccanici nello sfruttamento agricolo etc. I contadini potranno così fare a meno della pioggia del cielo e non avranno più bisogno di fare processioni per implorare Dio. Il gran mezzo liberatore è quindi «la dialettica» ossia la tattica cauta che commisura i mezzi al fine e procede oculata per tutte le vie della propaganda antireligiosa. Essa giustificherà il disprezzo diretto della religione e delle sue pratiche, la repressione di ogni propaganda religiosa anche privata, l’eliminazione dei ministri di culto e degli uomini dal carattere religioso (preti senza sottana). Essa giustificherà il terrore, ma parimenti l’astensione dai mezzi terroristici, l’ateismo teoretico di tutti i comunisti ed infine anche l’opportuno sfruttamento temporaneo delle passioni religiose per far trionfare la causa del proletariato. Ma il risultato finale dell’azione, tanto diretta che indiretta, dovrà essere l’annientamento di ogni religione.
• «Noi odiamo il cristianesimo e i cristiani — scriverà Lounatcharski, Commissario dell’Istruzione pubblica — anche i migliori fra essi devono essere considerati come i nostri peggiori nemici». È infatti nel cristianesimo che i comunisti riconoscono il loro peggiore nemico e insistono a dichiararlo e si sforzano di provarlo «un’imbecillità» come tutte le altre religioni. Sfruttando alcune pratiche idolatriche superstiti fra certe popolazioni russe e certe debolezze o colpe dei dignitari ecclesiastici e dei fedeli, essi ne deducono che il cristianesimo non è che un mezzo di sfruttamento, e che una convinzione sincera non è mai esistita presso nessuno.
• Guerra ad ogni religione. Se colpe non ci sono, si propalano delle frottole: ogni mezzo è buono perché, come scrive Lenin «dietro ogni icona del Cristo e di Budda non si vede che il gesto brutale del capitale». «Solo gli opportunisti possono credere che la gente religiosa possa essere comunista. Nessuna tregua sul fronte antireligioso. Mostrare l’abisso che separa la scienza dalla religione e aiutare le masse a superarlo, ecco la nostra missione. La lotta contro la religione è lotta per il socialismo» («Senza-Dio» dell’agosto 1935). E nel 1936 il comunista bulgaro Dimitrow, ben noto per il processo sull’incendio del Reichstag di Berlino, nell’introduzione di un nuovo opuscolo di propaganda dei senza-Dio, destinato ad esser diffuso a milioni di copie in tutta la Russia sovietica, identificando ogni religione, ma specialmente la cristiana, come la peggior nemica del comunismo, così si esprimeva: «Si tratta di distruggerla completamente. In questa lotta non bastano né parole, né libri. Bisogna far appello alle armi. Ci si rimprovera che demoliamo le chiese e i conventi. Simili rimproveri son ben lungi dall’intenerire un comunista. Sulle rovine del vecchio mondo il comunismo erige il vero socialismo». E nello stesso tempo il capo dei Senza-Dio russi Jaroslawsky pubblicò un manifesto destinato ai suoi collaboratori, nel quale dice: «Noi vogliamo incendiare le chiese del mondo intero in un fuoco generale. Il nostro movimento Senza-Dio è diventato una forza gigantesca che distrugge ogni sentimento religioso. Questo movimento è uno degli elementi più importanti della nostra lotta sociale antireligiosa destinata a rovinare le fondamenta del vecchio mondo. I fedeli di Dio di ogni religione devono ben sapere che nessuna divinità, nessun santo, nessuna preghiera può salvarsi dal naufragio».
• Risulta dunque evidente che il comunismo è decisamente ed assolutamente contrario a ogni religione e ad ogni sentimento religioso, al cristianesimo specialmente. Esso si identifica, anzi, con l’ateismo militante, ne sposa la causa per i suoi fini sociali, così come l’ateismo fa breccia nelle folle operaie — e non soltanto operaie — del mondo agitando il vessillo purpureo delle rivendicazioni sociali: sopra di esso si incrociano simbolicamente falce e martello, strumenti di lavoro, ma prima strumenti di morte: la falce vuol mietere le teste di tutti i credenti come il martello vuole stritolare ogni segno religioso per forgiare a nuovo l’antico idolo del mondo: il vitello d’oro.
• Organizzazione e attività dei Senza-Dio a favore del comunismo. È in virtù di tali principii che in Russia il comunismo, appena arrivato al potere nel 1917, instaurata la dittatura del proletariato e cercato di spazzare da ogni residuo dell’antico regime il terreno occupato con la forza, inizia con Lenin un combattimento accanito contro la Chiesa e la religione, considerata da esso come una «parte integrante» della società capitalistica. Interessa ora vedere quali siano state, fin dagli inizi del comunismo russo, l’organizzazione e l’attività del movimento antireligioso, seguirle negli ulteriori sviluppi fino a questi ultimi anni, perché risulti così sempre più evidente l’assoluta opposizione fra comunismo e cristianesimo.
• Inizi e sviluppi. Nei primi anni che seguirono l’inverno 1917-18 la lotta religiosa in Russia non era organizzata. Solo nel 1919 vi fu qualche persona incaricata della direzione di quest’opera, cosicché fino al 1921, se si toglie qualche campagna antireligiosa alla quale è particolarmente iniziata la «Gioventù comunista», la lotta contro la religione conserva un carattere individuale. Ma da questa data le cellule atee cominciano a lavorare le città e le campagne. Nel 1923 il XII Congresso del partito comunista decide una azione antireligiosa sistematica per evitare che «i pregiudizi religiosi scossi e compromessi conservino ancora terreno». Da allora due giornali, il Bezbojnik (Senza-Dio) e il Bezbojnik ou Stanka (Senza-Dio al cantiere) sono lanciati tra il pubblico: entrambi sono organi autentici dell’antireligione e stimolano il proselitismo degli atei di Mosca, i quali nel 1925 fondano l’Unione dei senza-Dio.
• Fine di quest associazione presieduta da Jaroslawsky (il suo vero nome è Goubelmann ed è di origine giudaica) è di far penetrare l’ateismo marxista fra tutte le popolazioni delle Repubbliche sovietiche. Essa cerca di influire specialmente su tre categorie di persone: gli operai, i contadini e la gioventù. Dal 1925 al 1929 il numero di queste cellule aumenta senza posa... Ma gli atei di Mosca non sono contenti: nel secondo congresso tenuto a Mosca nel giugno 1929 l’U. S. D. decide di aumentare celermente i suoi effettivi e di prendere un carattere nettamente aggressivo; ed è appunto per affermare questo nuovo atteggiamento che essa si chiamerà d’ora innanzi «Unione dei senza-Dio militanti (U. S. D. M.)», secondo le parole stesse dei suoi statuti essa vuol «unire le masse operaie dell’U. R. S. S. (Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche) per una lotta attiva, sistematica e incessante contro tutte le religioni, che sono un ostacolo alla costruzione socialista e alla coltura rivoluzionaria».
• La struttura dell’U. S. D. M. Da un regolamento del 26 febbraio 1934 ci è descritta minutamente la struttura di tale Unione nelle Repubbliche Sovietiche. La cellula è la base dell’organizzazione; essa conquista le aziende, le officine, le fabbriche, i poderi collettivisti Kolkhoz, così come conquista le varie unità dell armata rossa. Se ha meno di 15 membri, la cellula è diretta da un «organizzatore», se è più importante da un ufficio di 3 o 5 membri. Se un’azienda ha più rami di mestieri, avrà un’organizzatore per ciascuno di essi. Tutti i militanti dell’Unione saranno segnati su di uno speciale registro e, oltre la tessera di membro dell’Unione, ciascuno di essi riceverà la tessera di militante che sarà annullata o prolungata dai Consigli regionali o urbani. Vi saranno i Consigli provinciali; e i lavoratori del Consiglio regionale dell’Unione incaricati, oltre il lavoro fra le minoranze nazionali, di organizzare le campagne collettive, il lavoro antireligioso fra i fanciulli e il lavoro scientifico e informativo dell’Unione.
• Metodo e mezzi di lavoro. Il principio fondamentale dell azione antireligiosa dell’Unione è così espresso da Stepanoff: «Noi dobbiamo agire in modo che ogni colpo inflitto al clero, attacchi la religione in generale... I più ciechi vedono a quale punto diventi indispensabile la lotta decisiva contro il Prete, si chiami egli Pastore, rabbino, patriarca, mullah o papa; questa lotta deve estendersi non meno ineluttabilmente contro Dio sia che si chiami ]ehovah, Gesù, Budda o Allah». La tattica, poi, da seguire in questo lavoro è così esposta da Golovkine, che è uno dei, capi più autorevoli in questo campo: «Il proselitismo antireligioso deve tener conto della diversità degli stati di coscienza, perché vi sono due categorie di persone: i credenti e gli increduli. Presso i primi il lavoro consisterà nello scalzare i fondamenti della fede; gli altri dovranno soltanto essere incoraggiati a star fermi nella loro incredulità e a diventare degli atei militanti».
• Cosicché Golovkine esorta a non mai separare la lotta contro la religione dalla lotta di classe, a non ferire i credenti nei loro sentimenti religiosi quando ciò possa nuocere al fine ultimo ed a condurre una critica larga e completa delle origini della religione e dei suoi sviluppi. Vuole che si lavori fra le donne riconoscendo in esse, se non siano lavorate, il più sicuro rifugio della religione; vuole pure che si lavori tra i fanciulli, per condurli a una concezione atea del mondo e destare in essi una volontà di lotta contro i pregiudizi religiosi delle loro famiglie e del loro ambiente. Il comunismo moscovita vuole, insomma, che tutti i mezzi politico-sociali siano impiegati per agire sulle coscienze. Nel manuale antireligioso del Loukatchevsky, edito nel 1933 a Mosca, è detto che «la scuola attua l’educazione antireligiosa; la stampa, il cinema, la radio, la letteratura, l’arte sovietica lottano esse pure contro la religione». Sarebbe interessante esporre qui la tattica diabolica seguita nell’uso di tutte queste armi rivolte contro la religione. Ma la brevità dell’opuscolo ce lo impedisce. Diremo soltanto che all’opera diretta fu aggiunta, fin dal 1929, il metodo indiretto della fame: è di tale anno un decreto del Commissario dell’Interno che vieta a tutte le associazioni religiose di prendere qualsiasi iniziativa di soccorso materiale o spirituale a favore dei propri membri. Tale Commissariato sottrae, poi, ogni diritto civile e ogni tessera alimentare ai ministri del culto ed ai loro figli, ai quali tutti, essendo loro proibito di lavorare, viene sottratto ogni mezzo di vita. I figli del clero “ortodosso” sono tenuti a rinnegare pubblicamente i loro genitori se vogliono vivere. Ecco la tattica veramente inumana seguita dal comunismo nella vana illusione di togliere dal mondo ogni religione!
• Sviluppo dell’Unione dei Senza-Dio Militanti. È applicando tali metodi che nel 1930 l’U. S. D. M. era giunta ad avere 35.000 cellule con due milioni di membri. Essa pensò allora di estendersi nel mondo intero, lanciando il suo grido di guerra «abbiamo detronizzato gli Czar della terra, ora abbatteremo quello del cielo». Per meglio raggiungere il suo scopo, l’Unione prese stretto contatto con la «Internazionale dei liberi pensatori Proletari» nata nel 1925 e avente la sua sede a Vienna; atea anch’essa, si propose di «lottare per liberare i proletari dalla intossicazione religiosa». Gli elementi estremisti di questa internazionale prevalsero nel IV Congresso tenuto nel 1930 a Bodenbach, si staccarono dagli elementi moderati e si unirono ai comunisti professandosi apertamente bolscevichi e contrari ad ogni libertà di pensiero: «Noi rivendichiamo la gloria di essere atei», proclamarono nel 1932.
• Unitesi, quindi, le due associazioni dei Senza-Dio Militanti e dei Liberi pensatori, dettero nel triennio 1930-33 un impulso tristemente celebre alla campagna antireligiosa: preti o fedeli imprigionati e uccisi, chiese chiuse o distrutte, il Papa divenuto oggetto di scherno, la tiratura del «Senza-Dio» salita a 400 mila copie e le cellule salite a 80 mila con sette milioni di membri. Il secondo piano quinquennale. A questo punto si afferma il proposito di perseguire, nel quinquennio 1933-37, un’intensa attività antireligiosa parallela a quella economica e destinata a sradicare del tutto la religione. Il Jaroslawsky traccia un piano del lavoro da farsi anno per anno e conclude: «Al primo maggio 1937 non dovrà restare sul territorio russo nessuna costruzione destinata al culto e la nozione stessa di Dio dovrà essere cancellata dalla mente del popolo». Intanto la statistica ci dà delle cifre impressionanti sulla strage di sacerdoti e sulla distruzione di locali adibiti al culto nella Russia. Vi erano colà, prima della rivoluzione comunista, oltre 180 mila persone adibite al culto nella chiesa “ortodossa”, delle quali 50 mila sacerdoti; di essi i più sono morti assassinati o sono raccolti come prigionieri nei campi di concentramento. Altri compiono il loro ministero clandestinamente esercitando un mestiere accessorio o vivono come preti nomadi. La Chiesa cattolica contava (su 13 milioni di fedeli) 8 vescovi e 810 sacerdoti: alla fine del 1935 non restavano che 73 sacerdoti, dei quali 14 rinchiusi nei bagni di pena e altri 13 da poco arrestati. Dei locali adibiti al culto pochi restano aperti per tale uso, mentre tutte le scuole e i seminari ecclesiastici, sia “ortodossi” che cattolici, sono chiusi. La chiesa evangelica russa ha subito un analogo trattamento.
• Mentre questo programma viene attuato dai Senza-Dio in Russia, l’Internazionale dei Liberi pensatori si organizza in tutti gli altri paesi e lavora in perfetto accordo con quelli. La sede centrale dell’I.L.P., portata nel 1930 a Berlino, si trasferisce a Mosca nel 1932 perché il governo del Reich la scioglie, e tosto costituisce le filiali nella Svizzera, in Francia e nella Spagna. Allora è che Jaroslavsky proclama: «Ogni nostro lavoro dovrà essere sempre più intimamente legato a quello dell’I. L. P.». Cosicché le cellule di questa Internazionale, spargendosi nel mondo, restano alla stretta dipendenza del Komintern; e nel Congresso della centrale esecutiva riunitosi a Parigi nell’agosto del 1932, l’Internazionale traccia un vasto programma di azione conquistatrice «stampa di un bollettino in tedesco, in francese, in inglese e in russo; invio di istruttori qualificati a tutte le sezioni, diffusione di stampa e films antireligiosi specialmente nell’Inghilterra e nell’America, formazione di piani precisi di azione per ogni nazione con uno scambio di informazioni e di materiale di propaganda per suscitare tra di esse un’emulazione rivoluzionaria».
• Così il lavoro si intensifica e si estende per ogni parte; ma in Russia esso subisce, negli anni 1933-34, una pausa: è una reazione, una vera crisi del movimento antireligioso, alla quale i capi reagiscono, riuscendo a infondere nuovo ardore distruttivo, mentre i Senza-Dio intensificano la propaganda nel mondo e si riuniscono nel maggio 1934 a Parigi per «forgiare nuove armi per la lotta contro la Chiesa e la barbarie culturale fascista». Si decide, allora, di convocare il V Congresso mondiale dell’I.L.P. entro il primo semestre del 1935, che deve riuscire «una manifestazione potente dell’ateismo militante» per l’opera delle organizzazioni del fronte unico anticlericale e antifascista. Poco dopo il convegno di Parigi, i Senza-Dio ottengono una grande vittoria: il 18 settembre i rappresentanti del governo sovietico sono definitivamente ammessi all’Assemblea della Società delle Nazioni, avendo il Consiglio di questa conferito un seggio permanente alla Russia comunista. Vittoria, questa, di grande portata nella politica internazionale dovuta ai Senza-Dio militanti, la cui Unione è organo ufficiale del governo della Russia sovietica e il cui Consiglio Centrale è quasi un «Ministero dell’irreligione» diretto da uno dei più alti funzionari dello Stato.
• La tattica pacifista. Se nella Russia l’attività antireligiosa riprende nel 1935 con l’epurazione dei quadri e l’istigazione dei capi per «vincere definitivamente nelle coscienze delle masse gli ultimi residui del terribile e vergognoso potere della religione» (Senza-Dio del giugno 1935), la propaganda nei vari stati del mondo muta tattica. Le complicazioni sorte e le minacce di un nuovo conflitto mondiale, inducono i dirigenti della Terza Internazionale ad imprimere alla loro opera, sempre intesa a sradicare la religione, una nuova direzione e ad apporvi un’etichetta pseudopacifista. La parola d’ordine dei capi sarà allora questa: «lotta contro la guerra e contro il fascismo» perché, dicono essi, i sostenitori dell’idea religiosa sono anche quelli del fascismo e della guerra. Che i comunisti (semplici) fossero sinceri nel loro attacco contro il fascismo, non c’è dubbio. Ma non era sincero il pacifismo da loro ostentato. I comunisti, mentre fingevano di essere i più zelanti fautori e propagatori del movimento per la pace mondiale, nello stesso tempo eccitavano, e continuano ad eccitare a una lotta di classe che fa scorrere fiumi di sangue. Già il XIII Congresso del Comitato Esecutivo dell’Internazionale Comunista (Dicembre 1933) diceva: «Il grande scopo storico del comunismo internazionale, è di mobilitare il più grande numero di masse contro la guerra... e in questa lotta contro la guerra i comunisti devono preparare fin d’ora la trasformazione della guerra imperialista in guerra civile».
• La guerra mezzo di espansione. Di più, il Komintern niente altro desiderava che una grande guerra mondiale che aprisse la via alla rivoluzione sovietica in tutte le nazioni! Stalin stesso accennò a questo nel rapporto che tenne al XVIII Congresso del Partito Comunista (10-21 Marzo 1939): «Gli uomini politici borghesi sanno benissimo che la Prima guerra imperialistica mondiale ha procurato la vittoria alla rivoluzione in una delle più grandi Nazioni; essi temono che una Seconda guerra imperialista porterebbe la vittoria della rivoluzione in altri paesi». Non basta: nel medesimo rapporto Stalin disse: «La Politica di non intervento significa che si permette l’aggressione, che si lascia sviluppare la guerra sino a divenire una guerra mondiale. Nella politica del non intervento si manifesta il desiderio di non impedire gli aggressori dal compiere il loro attentato...; si procurerà che tutti i paesi belligeranti s’impantanino nella guerra, si procurerà che si esauriscano a vicenda e poi, quando siano quasi sfiniti, si entrerà in scena con delle truppe fresche, — ben inteso, per gl’interessi, della Pace! — e si detteranno ai belligeranti le proprie condizioni» (Lettres de Rome, 1-15 Maggio 1939, pag. 143) In questo tratto Stalin aveva mosso l’accusa contro Francia ed Inghilterra, che non erano intervenute nella guerra di Spagna. Ma, senza volerlo, aveva descritto la politica del Komintern. La prova ne fu il patto di non aggressione germanorusso del 23 Agosto 1939. In esso leggiamo: Art. 2 — Qualora una delle due parti fosse oggetto d’un atto di guerra da parte di un altra potenza, l’altra parte non darà alcun aiuto a questa terza potenza. Art. 4 — Nessuna delle parti contraenti parteciperà a un raggruppamento di potenze diretto in qualsiasi modo contro l’altra. Ecco sancito il non intervento, deprecato pochi mesi prima da Stalin. Eppure egli sapeva benissimo che la neutralità della Russia avrebbe favorito il conflitto germano-polacco. Sapeva benissimo che l’incendio si sarebbe propagato. Vada pure il mondo in fiamme; è proprio quello che si desidera... E intanto si andava armando il formidabile esercito rosso, che sarebbe dovuto intervenire all’ultimo momento, a dettare la pace alle nazioni esaurite. Quest’ultimo punto non si è svolto proprio secondo le intenzioni del Cremlino, ma i fatti dimostrano abbastanza, per chi sa comprenderli, quale fosse il pacifismo bolscevico. E si lasceranno i cattolici adescare da questi uomini, che non rifuggono da alcun mezzo per raggiungere il loro scopo? E crederanno che la guerra condotta dai bolscevichi sia una guerra di liberazione, da cui la religione non avrà nulla da soffrire? Sic!
• La Spagna insegni. Le tragiche vicende della guerra mondiale, hanno fatto quasi dimenticare gli orrori della guerra civile spagnola. Eppure i fatti sono ancora abbastanza vicini a noi per istruirci con la loro muta eloquenza. Ricordiamo: il 14 Aprile 1931 veniva rovesciata la monarchia spagnola, e un mese dopo cominciavano i primi incendi di chiese in tutta la Spagna. In seguito le strade di questo nobile paese furono di tanto in tanto insanguinate da sommosse popolari. Il settembre 1934 vide la violenta insurrezione delle Asturie, in cui furono massacrati alcuni sacerdoti e religiosi. Finalmente nel 1936 gli eventi precipitarono. Nelle elezioni del febbraio, il fronte popolare, costituito con una grande propaganda comunista, riuscì ad avere la maggioranza in parlamento, benché avesse riportato solo 4.556.000 voti contro i 4.950.000 della destra e del centro riuniti. Allora, con l’adesione della massoneria, il carattere antireligioso del Fronte popolare si affermò sempre di più: dalla chiusura delle scuole cattoliche si passò ad incendiare centinaia di chiese e di conventi, finché il 13 Luglio cadde assassinato Don Jose Calvo Sotelo, esponente della destra e temibile avversario del Fronte popolare, del quale denunciava alla Camera, con franchezza ed energia, le violenze e i delitti. Fu il segnale della riscossa; mentre i comunisti stavano per dare l’ultimo colpo, nel Marocco i generali Franco e Mola si rivoltarono ed ebbe inizio la guerra civile. Il comunismo allora rivelò il suo vero volto: incendi e massacri si moltiplicarono in ogni parte. Nella sola Barcellona arsero ben 150 chiese! Preti e fedeli furono uccisi in odio alla fede, tanto che, secondo le statistiche più sicure, risultarono più di 11.000 vittime tra il clero secolare e regolare, e oltre 300.000 i laici uccisi per le loro idee politiche e specialmente religiose. Eppure verso la fine del 1938, quando la situazione dei rossi stava diventando critica, essi fecero uno sforzo di propaganda per provare che la religione, nella Spagna rossa, non era perseguitata, che a Barcellona il culto veniva esercitato regolarmente, che si stavano per ristabilire le relazioni con la S. Sede! (Bugiardi nel midollo, proprio come oggi!) Poche settimane dopo, le truppe di Franco entravano in Barcellona, e si poté constatare che la Chiesa era stata ricacciata nelle catacombe: eccetto una cappella riservata ai Baschi, nessun altro luogo pubblico era aperto al culto. E una delle ultime prodezze dei soldati rossi, prima di sconfinare in Francia, fu l’uccisione del Vescovo di Teruel. Con lui sommarono a dodici i vescovi spagnoli massacrati dai comunisti.
• Nuova propaganda. Anche adesso (l’Autore scrive nel ’44) si ripete che in Russia il tempo della persecuzione religiosa è passato, ed è stata solennemente rinnovata la dichiarazione che viene riconosciuta la libertà di coscienza. Noi non sappiamo con sicurezza che cosa avvenga ora al di là della barriera di fuoco che separa la Russia sovietica, ma poco prima che essa fosse trascinata nel vortice della guerra, la sua politica antireligiosa proseguiva immutata. Ci bastino alcune citazioni: La Pravda, l’organo del governo, nel suo numero del 12 novembre 1940, scriveva: «La propaganda antireligiosa deve pigliare il carattere d’un ATTACCO A FONDO». E il Bezbojnik del 25 Maggio 1940: «Sotto la quotidiana direzione del Partito si svolge l’attività degli atei militanti che da esso ricevono continui e larghi aiuti. Anche la stampa del Partito lavora irreconciliabilmente contro ogni idea di religione. Al Partito inoltre sono affiancati gli undici milioni di giovani Komsomol». E nel numero dell’8 novembre dello stesso anno: «Tutte le condizioni di successo del nostro lavoro in U. R. S. S. sono nelle nostre mani: il Partito e lo Stato ci largiscono ogni giorno aiuto ed appoggio».
• Che dopo il 22 Giugno 1941 la lotta antireligiosa sia stata sospesa, può darsi benissimo, e può spiegarsi con un motivo di opportunità. Nonostante 25 anni di persecuzioni, la massa del buon popolo russo, specialmente nelle campagne, è rimasta tenacemente attaccata alla religione, come ce l’hanno più volte testificato i nostri soldati reduci dal fronte orientale. Nulla di strano quindi che, nel momento del pericolo, si lascino da parte le lotte interne. E infatti gli appelli di Stalin e Molotov alle genti russe, nel 1941, non insistevano tanto sulla difesa del bolscevismo, quanto sul sentimento della patria in pencolo (Cfr. F. Pellegrino, L’attacco a fondo dell’ateismo sovietico in Civiltà Cattolica, 1941, III, p. 181). Ma chi ci assicura che si tratti di una pace duratura, e non soltanto di un tregua? E per la nostra Italia chi ci assicura che il comunismo non sia fedele alla sua dottrina antireligiosa? I capi del comunismo — così avvertiva S. S. Pio XI (Enciclica sul comunismo ateo, Marzo 1937, N. 57) vogliono «far credere che il comunismo in paesi di maggior fede o di maggior cultura assumerà un aspetto più mite, non impedirà il culto religioso e rispetterà la libertà delle coscienze. I fedeli non si lascino ingannare! Il comunismo è intrinsecamente perverso e non si può ammettere in nessun campo la collaborazione con lui da parte di chiunque voglia salvare la civilizzazione cristiana. E se taluni cooperassero alla vittoria del comunismo nel loro paese, cadranno per i primi come vittime del loro errore, e quanto più le regioni dove il comunismo riesce a penetrare si distinguono per l’antichità e la grandezza della loro civiltà cristiana, tanto più devastatore vi si manifesterà l’odio dei senza-Dio». Conclusione. Parrebbe dimostrata l’assoluta opposizione fra comunismo e cristianesimo, se-nonché restano due punti oscuri, due difficoltà da risolvere. La prima è costituita dal fatto che c’è nel mondo di oggi un problema economico e sociale che attende, che esige una equa soluzione: la ineguale distribuzione della ricchezza, che s’è accumulata nelle mani di pochi, mentre c’è tutta una massa di gente disoccupata di poveri, di miserabili: togliere a chi ha troppo per dare a chi non ha, pare l’unico mezzo per ristabilire l’ordine e la pace. D’altra parte — ed ecco la seconda difficoltà — i comunisti tendono la mano ai cattolici e li invitano a collaborare per l’attuazione di questo programma di una maggior giustizia sociale. Se questa intesa non si attuerà, non potrà forse apparire confermato il giudizio che la religione sia solidale con il capitalismo, che la Chiesa favorisca l’ingiustizia o almeno si disinteressi dei problemi assillanti di quest’ora tragica? La risposta può essere breve.
• Soluzione Cristiana. C’è un problema economico-sociale da risolvere: è verissimo, né la Chiesa ha lasciato di richiamare su di esso l’attenzione di tutti, anzi essa ha prospettato l’unica soluzione possibile fin da quando, nel 1891, il Papa Leone XIII lanciava al mondo la lettera enciclica «Rerum Novarum»; e quarant’anni dopo, il Papa Pio XI riprendeva quel tema nella sua enciclica «Quadragesimo anno». In questi due documenti, la Chiesa richiama gli errori di due opposte correnti, il capitalismo e il socialismo; e addita nella carità, ossia nell’amore fraterno per motivi non solo umani ma soprannaturali, il necessario elemento integratore della giustizia senza il quale non sarà possibile risolvere equamente e stabilmente i problemi economico-sociali che attanagliano il mondo moderno. La Chiesa ha attuato l’unica forma possibile ed equa, fin dal suo nascere e questa forma è in atto anche oggi ovunque vivono ed operano i suoi figli; ed è quello di quanti spontaneamente rinunciano a tutto o a parte di quanto legittimamente possiedono per fare del bene al prossimo, per consacrarsi alle varie forme dell’apostolato sociale. Tra questi vi è la schiera eletta di chi, facendo la professione religiosa, rinuncia alla costituzione di una propria famiglia, alla propria indipendenza personale e ad ogni proprietà, con i voti di povertà, castità ed obbedienza volontaria. Ma vi è poi la schiera innumerevole di quanti, pur vivendo nel mondo nel modo ordinario, attuano, come possono, il consiglio evangelico della povertà volontaria e danno... danno non solo il superfluo ma anche il conveniente che loro appartiene a favore di quelli che non hanno o hanno poco. Ma è cosa utopistica ed ingiusta volere imporre a tutti, come obbligatorio, un regime che va contro l’istinto umano di pensare a sé, di costituirsi una famiglia, di conservare ed aumentare onestamente il patrimonio col lavoro, per esigere che ciascuno lavori per la massa anonima e si contenti che da essa sia provveduto al suo sostentamento e alle necessità della vita.
• Pericoli della “mano tesa”. Alla seconda osservazione si risponde che il tentativo di allettare i cristiani degni di questo nome alle associazioni comuniste, anche se fatto in buona fede, è e sarà sempre destinato a fallire. Non è scuotendo le basi del vivere civile, attentando ai diritti inalienabili di Dio fino alla negazione e all’odio di Lui, non è togliendo ad ogni legge morale il suo necessario fondamento, che è la volontà e la legge eterna di Dio creatore, non è gettando le classi sociali le une contro le altre in una lotta inumana fomentata dall’odio bestiale, che si potrà mai lavorare veramente a bene dei lavoratori: i cristiani lo sanno e, docili alle direttive della Chiesa, negheranno sempre ogni solidarietà con i nemici di Dio e di ogni vero ordine sociale. Essi, invece, sono pronti a collaborare ed a prestare tutta la loro opera per l’attuazione delle forme, anche più ardite, promosse da governi saggi e forti, per addivenire a una più equa distribuzione della ricchezza, a una più generosa retribuzione del lavoro nelle sue forme più umili, ma non perciò meno necessarie al benessere del consorzio civile. I cattolici, che conoscono i postulati e i programmi della scuola sociale cristiana, sanno come solo in essi stia riposta la chiave di soluzione degli ardui problemi economici della società moderna. Essi sapranno quindi sempre vedere nel socialismo, e specialmente in quello più spinto di Marx, Lenin e Stalin, il più grande nemico del popolo, il più irriducibile avversario di quella legge evangelica di giustizia e di amore che sola ha salvato e salverà il mondo. Oggi quindi, più che mai, il mondo ha bisogno di santi, e non solo di grandi statisti, di economisti profondi, di uomini di governo oculati ed energici. Oggi contro la Città di Satana, idolatra delle creature fino al disprezzo e all’odio del Creatore, deve levarsi la Città di Dio, che additi agli uomini — nell’amore a Dio fino al sacrificio di sé — il mezzo sicuro per far trionfare nel mondo la giustizia e la pace!
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, nel dicembre 1941 presso il Ministero della Educazione Nazionale si svolse un convegno di studi filosofici. Tra l’altro fu discussa la proposta di introdurre nel nuovo ordinamento della Facoltà di Filosofia una cattedra di Teologia cattolica. La proposta ebbe validi sostenitori e le buoni ragioni per sostenerla non mancavano: pur prescindendo dall’aspetto religioso, è chiaro che non è possibile studiare a fondo il pensiero filosofico italiano ignorando il pensiero teologico cattolico, che ha per lunghi secoli permeato tutta la cultura italiana; eppure l’Università italiana non offre la possibilità di studiare scientificamente il pensiero cattolico [ciò non stupisce, attesa la scandalosa laicità della Repubblica]; di qui la convenienza di introdurvi una cattedra di Teologia. Non mancarono, però, gli accaniti oppositori; la filosofia, l’antica ancella della teologia che a un certo momento aveva cacciato la padrona, si turbò al sentire che la padrona di un tempo chiedeva, per bocca di alcuni, l’ingresso nella facoltà, in un piano non di superiorità, è vero, ma di parità (sic!). «Io domando - disse conchiudendo la discussione l’Ecc. Bottai - se oggi sia possibile creare una convivenza pacifica; e se il risentimento di chi fu padrona e quello di chi si liberò dalla padrona, sia così lontano dalla memoria da non poter per caso rinascere; o se non, invece, l’invocata convivenza non richiami sopiti ricordi e con essi nuovo frastuono di armi. E ieri sera ci fu, se non frastuono di armi, frastuono di voci su tale questione» (Convegno di Studi Filosofici, Archivio di Filosofia 1942, III, pag. 259). In questo frastuono di voci noi fissammo la nostra attenzione sui principali argomenti dell’opposizione e ci parvero provenire da una concezione assai diffusa ai nostri giorni in Italia e fuori d’Italia che cioè la TEOLOGIA CATTOLICA e la FILOSOFIA MODERNA hanno caratteri essenzialmente opposti fra di loro per cui è impossibile ogni accordo ed intesa. Questa concezione ci appare chiaramente dall’esame dei vari atteggiamenti che nel corso della moderna filosofia hanno preso molti pensatori di fronte a quello che possiamo chiamare il «“problema” esterno della teologia» (Vi è un altro “problema” della teologia che potremmo chiamare il «“problema” interno della teologia» che riguarda la natura stessa della teologia e il suo metodo, “problema” che è stato pure oggetto di appassionate discussioni. Cfr. Gregorianum, 1913, I. p. 2s.), cioè dei rapporti della teologia cattolica con la filosofia moderna. In verità la vera teologia non ha nessun problema, bensì è l’uomo moderno, ignorante in filosofia e superbo (cf. Pascendi, S. Pio X) ad avere problemi con la verità, quindi con il pensiero cattolico genuino e verace.
• Nell’odierno approfondimento ci faremo aiutare dal P. Dezza, «Teologia cattolica e filosofia moderna», Collana SOS, imprimatur 1942. Atteggiamento materialista. Il primo tentativo di sciogliere il “problema” della teologia è stato quello più radicale che ha tentato di sopprimere la teologia stessa. Si è negato ogni valore teorico al cristianesimo in quanto religione rivelata, anzi si è negato valore teorico ad ogni religione anche naturale, negando ogni metafisica che è alla base della religione, eliminando le verità più fondamentali della religione e limitando la nostra conoscenza alla semplice constatazione dei fatti materiali. Si è allora cercata una spiegazione naturalistica ed evoluzionistica del fatto religioso, affermando che l’uomo dal primitivo stato di ignoranza di Dio, attraverso l’animismo e poi il politeismo e finalmente il monoteismo è arrivato alla religione cristiana e cattolica, ma per avviarsi di nuovo, seguendo la legge della continua evoluzione, allo stato di ateismo, o negazione di Dio. È questo il pensiero del materialismo degli antichi tempi, da quando Lucrezio scriveva che primus in orbe deos timor fecit (per prima al mondo la paura ha creato gli dèi) fino alle rinnovate forme di materialismo e positivismo; ultima quella della scuola sociologica del Durkeim che ha proposto l’origine sociologica della religione; la religione non sarebbe altro che l’espressione simbolica dei rapporti dell’uomo-individuo con la società di cui fa parte. Già il Comte nell’ottocento affermava che il periodo teologico, cioè delle credenze religiose, dovuto all’ignoranza della spiegazione dei fenomeni naturali, è da tempo sorpassato, anzi è superato anche il periodo metafisico che racchiude la base razionale della religione, e siamo ormai giunti al periodo scientifico, positivo, dell’esperienza, da cui la religione esula, se pur non voglia chiamarsi religione quella morale altruistica detta «religione dell’umanità». Contro questa soluzione del “problema” religioso è insorta la filosofia stessa, dimostrando quanto sia falso il voler limitare la nostra conoscenza alla pura constatazione del fatto materiale, e come l’esperienza ci mostra il finalismo, la vita, il pensiero che l’evoluzione della materia invano tenta di spiegare; perciò in nome dei diritti dello spirito contro ogni forma di materialismo e positivismo è insorto l’idealismo accanto alle varie forme di spiritualismo. Inoltre i recenti studi etnologici hanno dimostrato falso il presupposto di un ateismo iniziale nella storia dell’uomo, mentre vediamo tuttora presso i popoli primitivi forme di religione assai pure ed elevate, e si è ormai dimostrato che non già il politeismo ha preceduto il monoteismo, ma anzi ne è stata una posteriore degenerazione. Finalmente tutti i tentativi fatti per sopprimere ogni forma di religione e strappare dalla mente dell’uomo l’idea stessa di Dio sono riusciti vani: se l’ateismo ha potuto sedurre e conquistare individui, non è mai riuscito a dominare le masse, ed ultima conferma è la recente storia della Russia, dove per venticinque anni un governo ateo ha lavorato sistematicamente per diffondere l’ateismo e per annientare violentemente la religione; mentre nell’anima del popolo è tuttora vivo almeno il sentimento religioso, e spontaneamente si è manifestato appena le circostanze hanno imposto qua e là ai governanti una maggiore tolleranza religiosa. I “problemi” religiosi naturalmente si presentano all’uomo perché lo toccano intimamente nella sua natura, nelle sue origini e nei suoi destini; per quanto si cerchi di sciogliere il “problema” della teologia, sopprimendola, essa risorge sempre più imperiosa di prima.
• Atteggiamento idealista. La seconda soluzione data al “problema” della teologia è stata quella di inquadrarla negli schemi della moderna filosofia. II fallimentare e meschino tentativo fu già fatto da Kant nella sua «Religione nei confini della pura ragione». Coerentemente ai principii stabiliti nelle due Critiche Kant ha tentato d’inquadrarvi la religione: ha dovuto perciò svuotare di contenuto i dogmi rivelati, dando ad essi un’interpretazione naturalistica e simbolica, ha ridotto la religione cristiana a un semplice complesso di massime morali e di esigenze della nostra volontà, ha escluso ogni elemento soprannaturale. [Si noti che tutti questi loschi figuri si interrogano sempre e solamente sul “problema” del Cattolicesimo, mai sui problemi del talmudismo, della setta della mezzaluna, o delle tante pseudo chiese serve dei governi]. • Il tentativo fu rinnovato da Hegel nel suo idealismo, nel quale egli cerca d’inserire la teologia cristiana, coi suoi dogmi fondamentali della Trinità e della Incarnazione, sforzandosi di spiegarli razionalmente, perché, secondo i suoi principii, tutto il reale è razionale e tutto il razionale è reale, e perciò perfetta religione e perfetta filosofia.
• Più recentemente ancora nell’idealismo italiano, il Gentile ha rinnovato lo stesso tentativo. Egli inserisce la religione nella dialettica dello spirito, identificando il momento religioso coll’antitesi, quando cioè lo spirito - secondo la sua concezione - dopo avere creato questo meraviglioso universo che ci fronteggia e ci circonda, dopo averlo disteso nello spazio e nel tempo, obliando per un istante la sua potenza creatrice, assorto nella contemplazione della natura ne cerca una ragione, una spiegazione, un perché, e immagina un Dio creatore dell’universo e dinanzi a questo Dio che la sua mente finge, si prostra nella polvere e adora. «La religione, scrive il Gentile, è l’atteggiamento dello spirito di fronte all’oggetto suo, concepito come puro oggetto, astratto dalla sua relazione essenziale col soggetto» (Discorsi di Religione, Firenze, 1931, p. 97). Ma tosto lo spirito si riscuote, dall’antitesi passa alla sintesi, acquista la coscienza di sé, si accorge di essere lui il creatore dell’universo, per cui «Dio non è tanto Dio che non sia lo stesso uomo» (Teoria Generale dello Spirito come atto puro, Pisa, 1918, p. 146): è il momento della filosofia. La religione ha così una parte importante nell’attualismo gentiliano, rappresenta un momento necessario nella vita dello spirito che non arriva alla sintesi se non passando attraverso all’antitesi, non arriva alla filosofia se non dopo avere creduto ingenuamente alla religione (la filosofia dei fanciulli) momento provvisorio irrazionale, che deve essere superato dalla filosofia (la religione degli adulti). Né solo la religione in genere ha la sua parte nell’idealismo attuale, ma il Gentile tenta di spiegarvi proprio la religione cristiana cattolica fino ad affermare che la concezione immanentistica dell’atto spirituale, come è richiesta dal moderno idealismo, è l’inveramento del cristianesimo, e che l’interpretazione dualistica data da venti secoli di pensiero e di vita cristiana è interamente sbagliata, mentre la concezione attualistica è «la concezione più radicale, logica e sincera del Cristianesimo» (Teoria Generale dello Spirito come atto puro, Pisa, 1918, p. 280).
• Ma anche questo tentativo di inquadrare la religione e la teologia negli schemi della moderna filosofia è riuscito vano, perché praticamente si riduce a negazione della religione e della teologia. Già il Protestantesimo era insorto contro l’interpretazione del cristianesimo data da Kant. Questi infatti aveva iniziato la pubblicazione della sua opera «La religione nei confini della pura ragione» in un periodico: «Berlinischer Monatschrift» ma la censura ne arrestò la pubblicazione dopo il primo articolo nel 1792. Kant allora pubblicò l’anno seguente tutto il volume con l’imprimatur (sic!) di una Facoltà filosofica; ma nel 1794 l’opera veniva colpita perché contraria a molte dottrine fondamentali del cristianesimo e proibita ai professori dell’Università di Konisberg nelle loro lezioni. Kant dovette sottomettersi e solo nel 1798, dopo la morte di Federico Guglielmo II e l’avvento al trono di Federico Guglielmo III più tollerante in fatto di religione, Kant poté liberamente preporre le sue dottrine.
• Come il Protestantesimo aveva condannato l’interpretazione del Cristianesimo fatta da Kant, così ed anzi con vera ragione la Chiesa Cattolica ha condannato i libri del Gentile con la sua concezione attualistica della religione cattolica. Non a torto fu detto che i «Discorsi di religione» del Gentile sono uno dei libri più irreligiosi che siano stati scritti: infatti quando si nega la trascendenza di Dio, ridotto ad una pura autoproiezione dialettica dell’Io, che cosa può restare della religione? Quando poi si interpretano idealisticamente i dogmi della religione cattolica, si dice che rivelazione e grazia non sono che illusioni di ignoranza, per cui l’uomo crede di non poter da sé conoscere quel che conosce (rivelazione), né poter presumere di fare da sé quello che fa (grazia), si ripete che mitica è la dogmatica dei rapporti tra Dio e l’uomo, mitica la creazione, mitica l’immortalità dell’anima, mitica la Chiesa e i suoi insegna-menti, (Sistema di logica, Bari, 1923, II, pag. 157) che rimane della religione cattolica? Se una differenza vi è tra la soluzione materialistica del problema della teologia e quella idealistica, sembra che si riduca a questo: la prima è schietto ateismo, la seconda è ateismo più una menzogna, perché realmente anche l’idealismo è ateo, solo conserva le espressioni della religione per illudere gli incauti e confondere le idee (Cfr. Dezza, L’affermazione di Dio nella moderna filosofia Italiana, Civ. Catt., marzo 1932, V, p. 32). Lo stesso deve ripetersi di altre forme di idealismo, come lo storicismo del Croce nonostante la sua pretesa di dirsi cristiano (Cfr. La Critica, novembre 1912 e Civ. Catt., febbraio 1913), come l’ontologismo critico del Caraballese. Per il Caraballese Dio non è soggetto, ma è puro oggetto, puro essere, immanente a noi, immanente all’universo, che sostanzia il nostro essere e le cose tutte e costituisce l’oggetto necessario del nostro pensiero; ma negata la trascendenza e personalità di Dio è negato il carattere fondamentale della religione, in particolare della religione cattolica.
• Atteggiamento modernista. Riuscito vano il tentativo di risolvere il “problema” della teologia sopprimendo la teologia stessa e vano anche il tentativo di inquadrarla negli schemi della filosofia moderna, si è proposta un’altra soluzione, quella cioè di considerare filosofia e religione come due attività dello spirito indipendenti fra loro, che nascono e si svolgono parallele: mentre la filosofia è razionale, la religione di natura sua è irrazionale, alogica, extrafilosofica. È stato il tentativo del modernismo alla fine del secolo diciannovesimo e agli inizi di ventesimo, tuttora vivo in parecchi pensatori, tentativo sorto nel seno stesso del cattolicesimo, che pretendeva di ripensare il cristianesimo per metterlo in armonia con la mentalità moderna. Le varie forme di modernismo, pur nelle loro differenze, si accordano in due punti. Il primo consiste nel negare ogni valore teorico ai dogmi del cristianesimo, accettando l’impossibilità di conoscere una manifestazione di Dio al mondo per mezzo della rivelazione, anzi l’impossibilità di dimostrare la stessa esistenza di Dio per mezzo di argomenti razionali; il secondo consiste nell’affermazione che la religione nasce da un bisogno del divino, dapprima inconscio, o subcosciente, che diviene poi cosciente, sotto forma di sentimento o esperienza religiosa. Questo bisogno e questo sentimento sono insieme rivelazione e fede, Gesù Cristo non è altro che un uomo il quale ha sentito più vivo e profondo questo bisogno e sentimento religioso, la Chiesa non e altro che un’organizzazione destinata a conservare e promuovere in mezzo agli uomini l’esperienza religiosa, i dogmi si riducono a pure formule, nelle quali si esprime quell’esperienza religiosa, perciò soggetti a modificazioni secondo i vari tempi e secondo la diversa mentalità degli uomini. [Il modernismo è madre e linfa del “cattolicesimo” moderno, ossia dell’ateismo mascherato da religione cattolica. È dal modernismo che scaturisce la sintesi del Vaticano Secondo, con le tragiche conseguenze che tutti ben conosciamo e sulle quali poco si può opinare. Il modernismo ha trasformato la “società Chiesa” (o piuttosto ha rubato edifici e beni della Chiesa) in una o.n.g. vuota di contenuti, in fase di liquidazione, prossima ad essere assorbita dal pantheon della religione universale e falsa per antonomasia. Per grazia di Dio esistono sacche di resistenza cattolica che si oppongono a questa subdola macchinazione, partendo dal presupposto che il modernista non è cattolico, pertanto non può essere né unito con Cristo, né Papa: i suoi atti e fatti, dunque, sono pari al nulla e vanno totalmente ignorati. Solo così si può salvare la fede].
• La religione e la filosofia sono quindi eterogenee, le loro differenze radicali e irriducibili: tutti i tentativi di razionalizzare la religione riescono vani, la filosofia della religione deve abbandonare la pretesa d’inquadrare l’esperienza religiosa in concetti assoluti e definitivi, le varie concezioni teologiche si riducono, sempre per il modernista, a sistemi provvisori di simboli mentali che rappresentano l’incidenza della religione con la ragione in un punto determinato della rinnovantesi spiritualità umana (Maresca, Religione e vita spirituale, Archivio di Filosofia, 1911, 2 pag. 235 e segg.). Non si può neppure parlare di religione vera perché la verità è propria della ragione, mentre la religione deriva da una esigenza originaria del nostro spirito che non è di natura logica, ha le sue radici fuori della ragione e quindi di natura sua è irrazionale [Da qui si spiega lo spirito delle funeste “giornate di Assisi” inaugurate da Wojtyla, arricchite da Ratzinger (che aprì agli atei) e pacchianizzate dal rozzo Bergoglio].
• Ma anche questo nuovo tentativo di sciogliere il “problema” della teologia è fallimentare. Esso infatti non spiega nessuna forma di religione perché ogni religione involve necessariamente una base razionale per quanto il sentimento possa avervi la sua parte; molto meno esso può spiegare la religione cattolica, e risolvere il “problema” della teologia cattolica, perché il cattolicesimo proclama apertamente il suo carattere soprannaturale, ma insieme razionale. Il più grande teologo della Chiesa cattolica, San Tommaso d’Aquino, scriveva nella sua Somma Teologica: «(Homo) non crederet, nisi vieteret ea esse credenda» (2,2 q. I. a. 4 ad 2), non solo la religione cattolica non è opposta alla ragione, anzi è proprio la ragione che deve condurre alle soglie della fede cattolica; e San Tommaso non fa che ripetere quello che parecchi secoli prima scriveva Sant’Agostino: «Non crederemus nisi animas rotionales haberemus» e le frasi di Tommaso e di Agostino non sono che un’eco di quanto al principio del cattolicesimo proclamava San Paolo: «Ralionabile obsequium vestrum» (Rom., 12, l): l’ossequio della vostra fede è perfettamente ragionevole. La Chiesa cattolica è perciò insorta anche contro il modernismo, condannato con l’Enciclica «Pascendi Dominici gregis» di Papa San Pio X, e insorge ogni qual volta si rinnovano simili tentativi che, staccando la religione dalla ragione, cercano di insinuare una qualsiasi forma di agnosticismo religioso.
• La soluzione del “problema” della teologia. I vari tentativi fatti dalla filosofia moderna per risolvere il “problema” della teologia hanno in un modo o nell’altro cercato di distruggere la teologia cattolica: non è dunque possibile risolvere in altro modo il “problema”? La teologia cattolica crede di si, atteso che il problema è dei moderni filosofi: essa pensa che sia possibile risolverlo senza distruggere i due termini: filosofia e teologia; pensa che tali termini si possono conciliare conservando le loro caratteristiche essenziali, che anzi sia possibile non solo un accordo tra la filosofia e la teologia, ma che la filosofia sia utile alla teologia perché le offre gli elementi per la giustificazione razionale della fede e la teologia alla sua volta sia utile alla filosofia perché le schiude nuovi campi di investigazione, donde nasce il mutuo interesse tra filosofia e teologia. Abbiamo detto che la filosofia offre alla teologia gli elementi per la giustificazione della fede di fronte alla ragione: giustificare la fede di fronte alla ragione è un compito fondamentale della teologia che in quanto tale si chiama appunto teologia fondamentale. Nella teologia cattolica si sogliono distinguere due parti: l’una dogmatica, che studia ed espone il complesso dei dogmi, cioè il contenuto della fede; l’altra fondamentale, che espone i preamboli della fede, cioè dimostra criticamente quelle affermazioni che giustificano, vale a dire rendono legittimo e doveroso, l’atto di fede.
• Le due affermazioni che costituiscono i preamboli della fede e sono criticamente dimostrate dalla teologia, non appoggiandosi su alcun presupposto dogmatico, sono una di carattere filosofico (l’esistenza di Dio) e l’altra di carattere storico (il fatto della rivelazione). Il filosofo cattolico, partendo dall’esame della realtà quale ci appare nell’esperienza attuale concreta e cercando di spiegarla, vede che la realtà non può essere solo materia: la materia, come abbiamo detto, non spiega tutta la realtà, non spiega la finalità, la vita, il pensiero. Ha ragione quindi l’idealismo quando condanna il materialismo e proclama i diritti dello spirito. Ma lo spirito che vive e pensa in ciascuno di noi non è lo spirito assoluto, come vorrebbe l’idealista. La nostra intima esperienza ci attesta con evidenza che noi siamo qualcosa di limitato, di finito, di contingente: le miserie e debolezze della nostra vita quotidiana, le incertezze e gli errori della nostra vita spirituale ci confermano che non siamo l’Assoluto e che lo spirito assoluto, necessario per spiegare la realtà del mondo quale ci appare nella concreta esperienza interna ed esterna, è distinto, è superiore, è trascendente al mondo e a noi, ed il filosofo cattolico è così ragionevolmente ed evidentemente condotto all’affermazione dell’esistenza di Dio. Interviene allora la storia ad attestarci che questo Dio, la cui esistenza è criticamente dimostrata dalla filosofia, non è rimasto nascosto a noi nella Sua luce inaccessibile, ma si è rivelato, ha parlato per mezzo del Cristo. La verità storica dell’esistenza del Cristo, la Sua affermazione, sono tutti fatti che la critica storica rigorosamente dimostra. Attraverso questa duplice dimostrazione, che non si appoggia come già dicemmo su alcun presupposto dogmatico, la teologia cattolica dimostra legittimo e doveroso l’atto di fede: se è vero che esiste Dio, se è vero che Dio ha parlato all’uomo, e che la Chiesa cattolica è la depositaria di questo messaggio divino, l’uomo ragionevolmente può e deve credere; e il filosofo può e deve interessarsi del dogma cattolico che apre nuovi orizzonti al suo sguardo indagatore rivelandogli i misteri più intimi dell’essere divino.
• Regione e Fede. In questo modo la teologia cattolica risolve il “problema”. Che in tale soluzione non venga soppressa la teologia, è chiaro; ma potrà qualcuno domandarsi se questa volta non ne soffre la filosofia. Infatti la filosofia di natura sua vede, ragiona, dimostra; mentre la fede cattolica ha gli occhi bendati e crede. Come si conciliano la luminosità della ragione e l’oscurità della fede? Rispondiamo che conciliare non vuol dire identificare e il cattolico nella filosofia vede e dimostra la ragionevolezza della sua fede, nella fede crede e fermamente crede. Non è dunque vero quanto scriveva il Martinetti in «Ragione e Fede»: «Volete essere cattolici? Rinunziate senz’altro all’esame ed alle prove, imponete silenzio alla vostra ragione, abituatevi a credere senza vedere e senza sapere...» (pag. 31); e poco dopo insiste che per credere è necessario rinnegare la propria ragione, rinunziare alla qualità di essere ragionevole (pag. 32). No, non è rinnegando la ragione che si arriva alla fede, anzi ripetiamo, è proprio seguendo la ragione che arriviamo alle soglie della fede; e neppure si rinnega la ragione quando si crede il mistero, perché il mistero è superiore bensì ma non contrario alla ragione. Lasciamo la frase tanto abusata di Tertulliano «Credo quia absurdum» che dal contesto appare un’espressione impropria di un concetto vero, intendendo per assurdo quello che con la ragione non si può dimostrare; ma qualunque sia il pensiero di Tertulliano, certamente il pensiero esplicito della Chiesa è che giammai l’uomo possa o debba credere a ciò che ripugna alla ragione, mentre non c’è difficoltà che Dio riveli all’uomo delle verità superiori alla ragione umana. La nostra ragione ha dunque dei limiti, non è essa infinita? Volentieri concediamo alla ragione umana una certa “infinità” estensiva in quanto è capace di conoscere in qualche modo tutto il reale, ma non è capace di esaurirlo e molti sono i misteri dell’Essere ai quali la ragione umana da sola non arriva.
• La rivelazione non la umilia, ma anzi la eleva, né le toglie quella libertà che la filosofia moderna - la falsa filosofia - così gelosamente vuole rivendicare al pensiero umano. Il pensiero umano è libero nella ricerca della verità, non accetta imposizioni estrinseche che possano intralciargli il suo cammino in tale ricerca: ma la fede lascia perfettamente libero il pensiero umano nella sua indagine filosofica, solo interviene dove il pensiero umano ha terminato il suo cammino per aprirgli nuovi campi d’investigazione; la teologia è Beatrice che aiuta il Poeta a salire di cielo in cielo fino all’Empireo dopo che Virgilio, la filosofia, al solo lume della ragione l’ha condotto attraverso gli altri regni.
• Dogmatismo e criticismo. Contro questa soluzione del “problema” teologico insorge la filosofia moderna con una difficoltà ripetuta nei libri, negli articoli, nei discorsi e sulla quale si è insistito nel già ricordato Convegno Nazionale di Filosofia, quando si discuteva la proposta del Carlini d’introdurre una cattedra di teologia nella Facoltà di Filosofia. La filosofia moderna, si dice, è critica, mentre la teologia cattolica è dogmatica: il dogmatismo è la morte della filosofia come il criticismo è la morte della teologia; un accordo è dunque impossibile. Riflettendo serenamente sull’obiezione essa appare tutt’altro che insolubile; anzi esprimendo la soluzione in una forma un poco paradossale, ci pare di poter affermare che quando la filosofia moderna, in nome della critica, combatte la teologia cattolica perché dogmatica, diviene proprio essa dogmatica e fa meglio risaltare il carattere sanamente critico della teologia cattolica. Infatti che s’intende per filosofia critica? Critica è quella filosofia che non accetta nessun presupposto dogmatico ma inizia la sua indagine sottoponendo all’esame della ragione tutte le affermazioni fino ai loro più remoti presupposti, senza accettarne alcuno ciecamente o per argomenti di autorità, e procede nelle sue affermazioni solo alla luce della ragione ed a tale luce che con evidenza la appaghi. In questo senso, che è il vero senso, la teologia cattolica nella sua parte fondamentale è critica non meno di qualunque filosofia moderna. Il cattolico, difatti, inizia la sua indagine non appoggiandosi su alcun presupposto dogmatico e la prosegue alla luce della sola ragione come ogni vera filosofia [È questo che manca ai moderni filosofi: la luce della ragione, poiché la loro mente è ottenebrata dalle passioni disordinate]. Ora avviene che in questo esame critico della realtà alcuni arrivano alla conclusione che tutta la realtà è materia e solo materia e si proclamano materialisti; altri seguono lo stesso metodo critico arrivando alla conclusione che tutta la realtà, la vera realtà, è spirito, è idea, e si proclamano idealisti; altri concludono la loro indagine critica con l’affermazione che tutta la realtà non è né solo spirito né solo materia, ma è spirito e materia, spirito limitato e contingente come quello dell’uomo e spirito infinito e trascendente come quello di Dio e sono i realisti scolastici. Se critica è la filosofia del materialista e del positivista, se critica è la filosofia dell’idealista perché si vuol negare che sia critica la filosofia scolastica del teologo cattolico? Si potrà discutere sul valore degli argomenti che il cattolico apporta nella sua filosofia, come si può discutere sugli argomenti del materialismo e dell’idealismo, ma escludere a priori che la filosofia scolastica possa essere critica ed escluderlo proprio in nome della critica, vuol dire escludere a priori che l’indagine filosofica possa risolversi nel realismo scolastico, vuol dire pretendere di conoscere le conclusioni dell’indagine critica prima di fare la critica, vuol dire cominciare la filosofia critica con un presupposto dogmatico, il che evidentemente, come fu giustamente osservato, non può essere altro che dogmatismo della peggiore lega. Ma, sussume qualche filosofo, che è dogmatismo non solo il realismo scolastico della teologia cattolica, ma anche il materialismo, l’idealismo, come ogni forma di positivismo o di spiritualismo; perché ogni filosofia che pretende dare delle soluzioni definitive, dei sistemi, delle verità assolute è filosofia dogmatica e non più critica. La filosofia critica è una problematica sempre aperta, una storia di problemi e di esigenze, le cui soluzioni sono sempre provvisorie, è pura ricerca senza conclusioni definitive, è negazione di ogni sistema e di ogni verità assoluta. Che all’inizio dell’indagine filosofica si possa ignorare se essa si concluderà con un sistema, con soluzioni definitive, con verità assolute, ovvero si concluderà con la constatazione che soluzioni definitive ai problemi della filosofia non ne esistono, sia pure; che al termine dell’indagine filosofica qualcuno possa concludere che la verità assoluta non si trova, ma che la filosofia è sempre una posizione di problemi, sia pure; è la conclusione dello scettico. Ma che a priori, all’inizio dell’indagine filosofica, si affermi che questa indagine non può concludersi con una soluzione definitiva, con un sistema, con la scoperta di una verità assoluta, non è un pessimo dogmatismo, un voler fare della filosofia critica partendo proprio da un presupposto dogmatico, un voler fermarsi sulle soglie della filosofia e dogmaticamente precludersene l’ingresso?
• Trascendenza e immanenza. Se la filosofia può criticamente arrivare a soluzioni definitive - dicono altri - questa soluzione non può essere il realismo scolastico perché è la filosofia della trascendenza, mentre tutta la filosofia moderna è filosofia dell’immanenza. La filosofia della trascendenza non è critica, è filosofia dogmatica e ormai superata e chi vuole occuparsene, ancora è simile a colui che volesse insistere nell’astronomia tolemaica dopo parecchi secoli di astronomia copernicana. Non crediamo che il principio di immanenza, che è alla base della filosofia moderna, sia proprio così evidente da non poter essere messo in discussione: è spesso affermato ma non dimostrato; anzi ad un esame approfondito della coscienza, esso ci appare insostenibile e quanto si dice per sfuggire alle critiche, ricorrendo alla distinzione fra il trascendentale e l’empirico (attualismo) e fra oggetto già esplicito o ancora implicito (ontologismo critico) contiene, se ben si riguarda, una implicita professione di quella trascendenza che si vorrebbe negare. Ma, qualunque sia il valore del principio d’immanenza, rimane vero anche in questo caso quanto dicevamo più sopra. Che si possa iniziare l’indagine filosofica non sapendo se essa sfocerà nella filosofia dell’immanenza o in quella della trascendenza, sia pure; che qualcuno possa concludere la sua indagine critica con la filosofia dell’immanenza, sia pure; ma che a priori si affermi, all’inizio dell’indagine filosofica, che se la filosofia deve essere critica, deve essere filosofia dell’immanenza, è, lo ripetiamo, dogmatismo e non criticismo. Ben a ragione il Tarozzi, senza essere filosofo scolastico né teologo cattolico, giunto dopo una indagine veramente critica all’affermazione della trascendenza, lamentava che nel linguaggio filosofico moderno si chiami dogmatico chiunque non rifiuta in limine il reale esterno, e critico invece chi accetta i risultati della gnoseologia kantiana; mentre il significato più esatto, più augusto e più fecondo di filosofia critica è quello d’indipendenza da ogni argomento di autorità e da ogni presupposto non dimostrato (La ricerca filosofica, Napoli, Rondinella, 1936, p. 25). [I tanti documenti eredità di Papa Pio XII ci insegnano quali sono i parametri della vera filosofia]. In questo senso la teologia cattolica è dunque veramente critica e non ci può essere sotto questo a spetto opposizione tra filosofia e teologia.
• Astrazione e concretezza. È stato osservato che la filosofia scolastica, di cui si serve la teologia cattolica, anche se possa dirsi critica, oggi non interessa. La caratteristica della filosofia moderna è la sua mondanità, la sua concretezza e aderenza al nostro mondo, mentre i problemi della teologia sono trascendenti, astratti, extramondani e quindi non interessano. È proprio vero che la trascendenza della filosofia scolastica allontana la filosofia dalla vita, che il Dio degli scolastici è astratto e relegato lontano dal mondo e che la teologia cattolica, la quale tratta di questo Dio, non può interessare l’uomo moderno che vive la concretezza di questa vita, il filosofo che studia la realtà di questo mondo? La teologia cattolica difende, è vero, l’assoluta trascendenza di Dio, ma questo Dio non è il Dio di Aristotele, tutto immerso nella contemplazione di sé, che non conosce il mondo e non si interessa degli uomini: il Dio della filosofia scolastica e della teologia cattolica, pur restando trascendente al mondo, è presente nel mondo così che in Ipso vivimus et movemur et sumus (Act. Ap., 17, 28), non solo è presente, ma operante in noi, nell’intimo dell’anima nostra, sia nella vita naturale sia più ancora nell’elevazione alla vita soprannaturale per mezzo della grazia santificante, fino alla più intima unione mistica che suole spesso accompagnare i gradi più alti della spiritualità cristiana; non solo presente ed operante nel mondo, ma così mondano (passi la parola impropria) che si è fatto uomo come noi assumendo in unità di persona la nostra stessa natura: Et Deus erat Verbum... et Verbum caro factum est et habitavit in nobis (Jo., 1, 1 e 1, 14). Orbene, la storia di questo Dio fatto uomo ha riempito di sé la storia dell’umanità di cui è divenuto il centro: dividendola in storia prima di Cristo e dopo Cristo; l’opera sua che è la Chiesa sopravvive nei secoli in questo mondo ed estende i suoi confini da un capo all’altro della terra; la sua dottrina, la dottrina cristiana si è diffusa ed è penetrata in ogni strato della società, da due millenni ha permeato la nostra letteratura, la nostra arte, la nostra cultura, tutta la nostra civiltà. Come si può dire che la teologia cattolica è astratta, extramondana e non interessa? Se per mondana intendiamo ciò che è materiale e chiuso nel mondo della materia, negando il mondo dello spirito, allora la teologia cattolica non è mondana: ma se per mondano intendiamo tutto quello che appartiene al nostro mondo, mondo della materia e mondo dello spirito, che è pure il nostro mondo, il mondo più perfettamente nostro, di noi uomini che siamo materia e più ancora spirito, la teologia cattolica è veramente concreta e “mondana”, ed astratta diviene quella filosofia che, disinteressandosi della teologia cattolica, astrae da un elemento così vivo nella concretezza di questo mondo. [Fatto sta, e questo è certo come il sole che sorge, che la teologia cattolica ha costruito e costruisce civiltà, mentre la filosofia moderna ha distrutto e distrugge ogni cosa].
• Immobilità e progresso. Un’ultima istanza e poi finiamo. La filosofia scolastica, propria della teologia cattolica, si dice è sistema fatto, chiuso, cristallizzato e il pensatore non può far altro che aggirarsi pigro e inerte: è la morte della filosofia che, per vivere, ha bisogno di sistema sempre aperto, di ricerche sempre nuove. Concediamo che il filosofo cattolico riconosce che il pensiero umano in venticinque secoli non ha pensato invano, ma attraverso il laborioso travaglio di tante generazioni ha raggiunto dei punti fissi, delle pietre miliari, ha gettato delle basi solide per il suo edificio intellettuale; ma aggiungiamo che il sistema non è chiuso, l’indagine non è finita, resta ancora da fare, da progredire: e progredire non significa ricominciare sempre da capo, ma proseguire per la via iniziata approfondendo i veri trovati, scoprendone dei nuovi e non contrastanti, fissando lo sguardo in più vasti orizzonti. Che ci possano essere dei pigri tra i filosofi scolastici, che si adagiano nelle affermazioni già dimostrate e le ripetano senza saper dire alcunché di nuovo, è possibile, e non fa meraviglia: i pigri ci sono sempre e dappertutto, numerosi anche tra i cultori di altre filosofie, come certi idealisti che ci vanno ripetendo a sazietà il ritornello della tesi, dell’antitesi e della sintesi. Tra gli stessi filosofi più critici che affermano l’assoluta problematicità della filosofia, se per alcuni la negazione d’una verità assoluta è assillante stimolo a nuove ricerche, per altri invece è facile tentazione ad adagiarsi in un comodo agnosticismo. Ma che la filosofia scolastica e la teologia cattolica portino naturalmente alla pigrizia o all’inerzia del pensiero, è tutt’altro che vero. Chi così afferma ci sembra simile a colui che dal fondo della valle guarda l’amico che faticosamente ha salito l’erta del monte vicino e ne ha raggiunto la cima indorata dal sole: per te, sembra dirgli, l’ascesa è finita; non puoi far altro che scendere per ricominciare a salire, o adagiarti pigro e inerte sulla vetta raggiunta. Ma l’amico risponde: L’ascesa non è finita; questa che, dalla valle, sembra la vetta, non è la vetta, bisogna salire ancora più su. E a mano a mano che l’alpinista sale, si rinnova l’illusione frequente per chi sale in montagna, che crede di aver raggiunto la vetta e poi s’accorge che essa è ancora lontana: e continua a salire e l’orizzonte s’allarga e nuove vette scintillanti di neve lo invitano a salire sempre più su, e cala la sera e la cima più alta forse non è ancora raggiunta e l’alpinista attende che domani il sole risorga per riprendere il suo cammino. Così nell’ascesa spirituale alla ricerca della verità; di vetta in vetta l’uomo ascende e gli orizzonti dello spirito si allargano e la luce della ragione e poi il raggio della fede illuminano vette sempre più alte. E cala la sera, tramonta la vita dell’individuo senza che sia esaurita la conoscibilità dell’essere. Ma il lavoro non è stato vano, domani il sole risorgerà, nuove generazioni si affacceranno alla vita e, sfruttando il lavoro già fatto, ripiglieranno il faticoso cammino e penetreranno sempre più a fondo nella cognizione della verità. La filosofia scolastica della teologia cattolica è dunque un sistema, ma non un sistema chiuso, in essa c’è sempre da progredire [ma nello stesso senso e nello stesso significato, cf. Dei Filius], sempre da costruire senza bisogno di cominciare da capo né di distruggere il lavoro già fatto. Ecco il compito della filosofia che nella teologia cattolica non trova ostacoli ma compimento, perfezionamento, incoraggiamento.
• Conclusione. Fra la teologia cattolica e la vera e sana filosofia, anche moderna, non c’è opposizione, ma accordo e mutuo interesse... La teologia cattolica getta potenti fasci di luce ove la ragione umana da sola non arriva...
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, il 13 Maggio 1917, nel cuor della guerra, diventava Vescovo Eugenio Pacelli per svolgere in Germania una missione di assistenza spirituale e materiale fra i colpiti del flagello. Il 25° anniversario lo ha trovato Vescovo dei Vescovi, nel cuore di un’altra guerra, a svolgere un uguale ministero di conforto, ma sui più diversi punti del globo. Ed Egli era ben preparato a questa missione di carità. Dolori, aspirazioni, necessità, viltà, angosce, ingiustizie ed eroismi, tutta la tragedia insomma del mondo moderno ha parlato a quest’uomo, cui sono famigliari le lingue e i volti del vecchio e del nuovo continente. PIO XII: tutte le intelligenze non passionate si chinano riverenti: ma ciò si spiega e non è singolare. Milioni di cuori a questo nome dolcissimo trasaliscono di commozione: ecco il fatto unico, misterioso. Ma chi è dunque il Papa? Rispondiamo utilizzando anche il volumetto SOS «Il Papa» del P. Giorgio Flick, imprimatur 1943.
• Il Papa e i protestanti. Obiezioni: «Io penso che per la salute delle anime mi è permesso tutto, contro la perversità del Papa»; così scriveva il dannato Martin Lutero nel 1520. I protestanti d’Inghilterra si esaltavano al grido di: — fuori il Papa! — e squartavano come traditore della Patria chi gli ubbidiva. Oggi l’insegnamento ufficiale del protestantesimo nei riguardi del Papa è, almeno in apparenza, molto mutato. Egli resta tuttavia un intruso. Dicono i protestanti che Dio comunica liberamente alle anime con la Scrittura o con le sue ispirazioni; il Papa, si è messo in mezzo non chiamato e non desiderato da nessuno, ha nascosto la Bibbia ai fedeli, e ha piantato una bancarella da mercante mettendo in vendita le grazie e le indulgenze. E perciò il Papa se per i vecchi protestanti era dichiaratamente «anticristo, signore di Babilonia, verme divoratore delle nazioni» per i moderni, più moderati almeno in apparenza, il Papa è un’istituzione sopportabile, ma umana. Quando mai Gesù Cristo ha pensato di farsi rappresentare da un uomo? Dato però che anche tra i cristiani ci sono anime deboli, personalità fiacche, stracci di uomini, tollerano che ci sia un Papa che si occupi di questi rifiuti. Ma chi vuole vivere e pensare da uomo deve emanciparsi ed evadere da Lui. Niente Papa, quindi, almeno per le persone capaci e coscienti. Al più accettarlo come autorità morale umana, la più alta in questo mondo di passioni e di odi: mai però come vicario di Cristo. Fede, ragione e storia hanno dimostrato che un cristianesimo poggiato su questo piano doveva finire con un fallimento. Così, piò meno, dicono i protestanti.
• Il Papa e i sedicenti Ortodossi. Come se un Apostolo, sparito Cristo, avesse salutato gli altri e se ne fosse andato dicendo: «lo ho il potere di consacrare e di assolvere, ho la dottrina e l’esempio di Lui; statemi bene, ci rivedremo in cielo!» — Cosi ha fatto la Chiesa separata, di Oriente. Ha detto: — chiesa una sì, ma nell’altro mondo, in questo, unione mistica e, si capisce, reciproca stima (anche in questo caso la stima è sovente solo apparente). Ma l’unione gerarchica, cioè con uno che comanda e gli altri che ubbidiscono: no! Al più, sono pronti a concedere al Papa un primato d’onore. Primo fra i pari e basta. Ma se e egli se ne approfitta per comandare, deporre e innalzare: allora niente! neppure il primato di onore: ognuno per sé e Dio per tutti ! — Naturalmente l’insegnamento di Cristo non è conservato dai sedicenti Ortodossi, che oltre ad essere scismatici sono anche eretici ... Fra le altre cose, i cattolici ribattono che i primi cristiani già riconoscevano al Papa qualche cosa di più di un primato di solo onore, ricordando immediatamente la sentenza di Gesù: «e su di te [Pietro] edificherò la mia Chiesa». Rispondono che i Papi delle origini, abbagliati dallo splendore di Roma, si credevano legittimi successori dei Cesari, ma che poi la luce di Roma è passata a Bisanzio, e che allora, caso mai, toccherebbe al Patriarca di Costantinopoli di tenere il limone... Ma no: tutti liberi, e tutti uguali! Come i tasselli dei mosaici d’oro delle chiese orientali. E non vedono che se sotto non c’è un muro solido, il mosaico si riduce a un vano luccichio senza solidità e consistenza. Ciò sono, difatti, le cosiddette «Chiese ortodosse», delle Chiese nazionali separate, spesso al soldo dei governi, che non professano la dottrina di Cristo e dove si consumano sacrilegi: il tutto in contesti talvolta maestosi e di tanta solennità. Fra i moderni divulgatori di eresia merita una particolare menzione J. Ratzinger. Nel suo «Principles of Catholic Theology», 1982, dopo ampollose introduzioni dense di sofismi e, diciamolo con sincerità, di modernismo, alle pagine 216 e 217 afferma: «Il patriarca Athenagora parlò ancor più fortemente allorquando egli accolse il Papa [Paolo VI, Sic!] a Fanar: Contro tutte le aspettative il Vescovo di Roma è fra noi, il primo fra noi in onore, colui presiedente nella carità. È chiaro che nell’affermare ciò il patriarca non abbandonò le rivendicazioni delle chiese Orientali né accreditò il primato dell’Occidente. Piuttosto, ha dichiarato chiaramente che l’Oriente ha compreso come l’ordine, il rango e il titolo, dei vescovi eguali nella Chiesa – e varrebbe la pena per noi considerare se questa antica confessione, che non ha nulla a che vedere con il “primato di giurisdizione”, ma confessa un primato di “onore” e di amore [agape], non potrebbe essere riconosciuta come una formula che adeguatamente riflette la posizione che Roma occupa nella Chiesa – il “santo coraggio” richiede che la prudenza sia combinata con l’“audacia”: il regno di Dio soffre violenza […] in altre parole, Roma non deve richiedere dall’Oriente, riguardo alla dottrina del primato, più di quanto è stato formulato e vissuto nel primo millennio». Contento lui! A poco gli serviranno le cattedre umane al giudizio di Dio
• Il Papa nei primi tempi. Fuori del campo cattolico è opinione corrente che l’autorità suprema del Papa su tutti i fedeli e su tutti i vescovi sia il risultato di secoli di mène e di intromissioni. È falso. Sapendo cercare, si trovano chiarissime tracce dell’esercizio di questo supremo potere anche nei tempi più antichi della Chiesa. Ci basti studiare gli Atti degli Apostoli e prima ancora le sentenze di Gesù a riguardo. Ciò premesso, già nell’anno 97, per esempio, il Papa Clemente scrive con autorità alla Chiesa di Corinto per ristabilirvi la pace. Nel 107 Sant’Ignazio di Antiochia scrive alla Chiesa romana che, presiede alla adunanza della carità. Dal 100 al 200 è continuo il venire a Roma di buoni e di cattivi per avere, dal suo Vescovo, luce e giudizio. Prima del 200 Ireneo scrive che nella Chiesa di Roma è conservata, per i fedeli sparsi dovunque la tradizione apostolica. Nello stesso tempo il Papa Vittore I agì da supremo giudice nella questione intorno al giorno nel quale celebrare la Pasqua. Nel secolo terzo, sorta una controversia sulla validità del battesimo dato dagli eretici, il Papa romano giudicò e decise. Tutti i concilii, furono presieduti dai legati del Papa, o almeno a lui furono mandati gli atti per averne l’approvazione. Nel 451 al concilio di Calcedonia i Padri, sentendo la lettera di San Leone Magno contro Eutiche, acclamarono in piedi: «San Pietro ha parlato in Leone». Giulio I ristabilì nella sua sede Sant’Atanasio. Innocenzo I e Zosimo Papi giudicarono contro Pelagio e seguaci. Dopo il quinto secolo i documenti diventano valanga. Segno chiarissimo del pieno potere, non usurpato col passar dei secoli, ma esercitato dai Papi fin dai primi tempi, ed accettato senza difficoltà da tutta la Chiesa.
• Il Papa nella storia. Alcuni si scandalizzano perché il Papa abbia rivestito apparenze tanto diverse secondo i tempi. Il fatto non si può negare. Il Papa di oggi si mostra non come nel 700, nel rinascimento, nel medioevo, o alle origini. Sono mutate le forme di vita e a questa mutazione si è adattato naturalmente anche il Papa. Dalle pergamene e dal corriere a cavallo è passato alla radio e al cablogramma, dalle carrozze dorate all’automobile. C’è stato un tempo in cui era quasi impossibile far sentire la propria voce se non c’era un esercito e una flotta, e il Papa ho assoldato compagnie di ventura ed armato galere e triremi. Oggi un vasto territorio non sarebbe più per il suo ufficio un sostegno, ma un impaccio, e il Papa, come ha detto Pio XI, nel dominio temporale si è ristretto come San Francesco a quel tanto di corpo necessario per sostentare l’anima. Agli inizi, col numero non grandissimo di fedeli e con la immediatezza della tradizione apostolica, non era necessario far troppo sentire il Primato, e il Papa, lasciava alle singole Chiese una grande autonomia. Quando invece fu necessario,egli strinse le file del suo governo e rese più rigidi i quadri. Però non è il caso di scandalizzarsi per questo, ma piuttosto di ammirare. A una istituzione umana la immutabilità avrebbe ben presto dato la rigidità delle mummie dei musei, l’adattamento ad ogni nuova forma di pensiero, l’avrebbe svuotata del suo contenuto. Al Papa invece no. Si vede che sotto i vestiti che mutano col mutare dei tempi pulsa la vita perennemente giovane del Cristo. Non uno iota di dottrina di Cristo è mai stato cambiato dai Papi, né un Papa, se tale, potrebbe mai farlo.
• Ma San Pietro era povero. E invece il Papa oggi ha la corte, e vive nella reggia più bella del mondo, e si muove in uno sfarzo orientale. All’ingenuità del sempliciotto che vorrebbe vedere oggi un Papa ridotto, se non proprio alle reti di San Pietro, almeno alla povertà di un prete di campagna, si potrebbe rispondere rimandandolo alla novella di Soffici, in cui un Papa lascia ricchezza e fasto per correre il mondo evangelizzando all’apostolica. All’entusiasmo del primo giorno ben presto segue l’imbarazzo e il tedio. E giustamente. Difatti, senza preconcetti più o meno interessati, bisogna ragionare così: è opportuna per il Papa quella forma di vita, che gli offre le più grandi facilità per assolvere, oggi, nelle circostanze concrete, la sua alta missione di Vicario, di Maestro e Guida. Ebbene, ora che i fedeli sono centinaia di milioni, e che il Papa ha rapporti ufficiali con quasi tutti gli Stati anche non cattolici, ora che moltissimi vengono attratti anche dallo splendore esterno dell’autorità e delle cerimonie cui Egli prende parte, come farebbe un Papa « alla San Pietro» a fare a meno di una reggia e di un cerimoniale, di divise e di automobili, di cardinali, di nunzi, di delegati, di consultori, d’impiegati e ili guardie? E come manterrebbe gli impiegati delle Congregazioni romane necessarie per il governo della chiesa universale? Senza dire che i flabelli e i parati d’oro possono benissimo coprire la povertà francescana di San Pio X, le due patate lesse delle quaresime di Benedetto XV, e il lettuccio di ferro sul quale è spirato Pio XI. Chi sfamerebbe i poveri? Chi pagherebbe le spese di mantenimento di ospedali, orfanotrofi, ospizi, scuole e tante altre attività benefiche? Anche questa obiezione è risibile e perversa come chi la professa.
• Il Papa nel cristianesimo. Chi volesse di una macchina prendere soltanto una ruota e qualche leva, si troverebbe in mano solo rottami inutili. Così avviene a coloro che nella religione spizzicano qua e là, come se si trattasse di un campionario di stoffe. Anche il Papa non deve essere considerato da noi come una realtà a parte, magari interessante, e che ci distingue dal resto dei nominalmente cristiani. La sua presenza è invece affondata nel nostro dogma. Si connette a tutte le sue parti in modo che isolandolo non si fa che guastarlo. La realtà è questa: — Dio ha parlato agli uomini. Li ha adottati per figli ed ha insegnato loro i segreti del Padre. Cristo, l’unico che li conosceva, è venuto e li ha detti. Dopo di che, ogni uomo poteva andarsene per le molte strade del mondo, portando la fiamma nel cavo del cuore, per accenderla nei solitari focolari che gli fosse piaciuto. Invece no. Come la rete che raccoglie e rinserra, come l’ovile che protegge e unisce, come il banchetto che nutre e affratella, Cristo ha fondato una Chiesa. E Chiesa in greco vuol dire riunione. Per le anime, ma anche per i corpi. Interna, ma anche esterna. In essa la grazia fluisce, ma in segni esterni: i sacramenti. Lo Spirito Santo parla, ma spesso per le bocche di uomini use alle parole della vita di ogni giorno. Ed è chiaro allora che ad unire le membra visibili era necessario un Capo visibile; a tenere sul filo della verità i cervelli era necessario un Maestro, a condurre le volontà era necessaria una Guida, a scaldare i cuori era necessario un Padre. E Capo, Maestro, Guida e Padre è il Papa nel cristianesimo.
• Capo visibile. Gesù non ha abbandonato la sua Chiesa. Ha detto: sarò con voi fino alla fine dei secoli. Ed è rimasto fra noi. Ma invisibile. Sui nostri altari, di Lui vediamo e tocchiamo solamente le apparenze del pane e del vino. Ora, se in alcuni momenti ci pare che questa presenza potrebbe bastare, sposso sentiamo che alla nostra natura sensibile converrebbe una presenza sensibile di Cristo. E sappiamo pure che Cristo tornerà visibile a giudicare le azioni di tutti alla fine del mondo. Spesso però sentiamo la necessità anche di un giudizio immediato. Vediamo deviazioni, che hanno urgente bisogno di essere raddrizzate subito; sentiamo parole che devono essere smentite senza ritardo. E sul nostro fronte ci sono settori dove forse nessuno andrebbe se non ci fosse la parola di un capo che manda e sostiene. Coll’istituzione del Papato, Dio ha risposto meravigliosamente bene a questo nostro desiderio. Il Papa è por noi il Cristo presente, Capo vicario di Cristo. Egli perciò rappresenta Cristo in tutto quello che, nella vita del a Chiesa, richiede una azione di presenza. Per questo il Papa può fare leggi che obbligano tutti i battezzati, e può togliere tutti gli obblighi che non siano stati imposti direttamente, davanti a Dio, al di sopra di tutti gli uomini. E scioglie o lega, perdona o scomunica, come Capo che provvede alla salute di tutto l’organismo.
• Maestro. L’insegnamento di nuove verità agli uomini da parte di Dio è finito da venti secoli. Alla morte dell’ultimo Apostolo si è chiusa la Rivelazione, e si è chiusa per sempre. La Chiesa non deve fare altro che conservarla intatta e distribuirla fedelmente agli uomini. Questa missione di insegnamento è stata affidata da Cristo a tutti gli Apostoli e ai loro legittimi successori: andate e insegnate a tutte le genti. Siccome però il Papa è il capo supremo dei vescovi, come lo era San Pietro per gli altri Apostoli, è chiaro che Egli deve avere in sé tale potestà in modo supremo, indipendente cioè da ogni altro. Ma se la Rivelazione è chiusa e la Chiesa deve solo ripetere agli uomini verità vecchie di venti secoli, a che si riduce in fondo la missione del Papa? Anzitutto si deve pensare che se le verità sono sempre le stesse, gli uomini cambiano. Inoltre il ricavare autorevolmente la verità da insegnare dalle fonti della Rivelazione non è un lavoro così facile. La Bibbia poi è scritta in una lingua difficile, e ci è stata tramandata da uomini che hanno potuto, almeno nelle cose accidentali, oscurarne la chiara luce. Basta poi un po’ d’esperienza per sapere come il testo più chiaro può venire oscurato da chi lo legge, se non v’è una autorità magistrale che ne determini il senso. Serva d’esempio la babele protestante che proprio per aver negato al Papa il potere d’insegnare, è giunta col libero esame della Rivelazione a non sapere più che cosa sia rivelato o no. Il Papa maestro è dunque una delle più grandi grazie che Dio ha fatto agli uomini per la tutela della Sua verità.
• La vera infallibilità. Il vero Papa non insegna agli uomini belle teorie per tenerli tranquilli un momento. La sua parola, come la parola di Dio, scende profonda nelle anime e ne determina i destini eterni. Andate e insegnate ...; chi crederà sarà salvo e chi non crederà sarà condannato, sentenzia Gesù Cristo. Non si scherza. Alla fede nella parola del Papa Dio ha unito la nostra salvezza e la nostra condanna. E allora è troppo evidente che questo maestro, al quale Egli ci ha spinto, non può sbagliarsi. È mai possibile infatti che la Verità increata voglia obbligare tutti gli uomini a credere nella parola di un altro uomo, e sotto la minaccia delle pene più gravi, e poi lasci quest’uomo in balia del capriccio e della sua ignoranza? No! Difatti Cristo gli ha dello: sarò con voi fino alla consumazione dei secoli! Questa, dell’infallibilità pontificia, non è una novità dei tempi nostri. Quando il concilio Vaticano nel 1870 la fissò come verità di fede, non fece che applicare le chiare parole di Gesù Cristo a San Pietro: e tu, una volta con convertito, conferma i tuoi fratelli. Fu la eco definitiva di mille voci che fin dai primissimi tempi si erano rivolte a Pietro nei suoi successori per essere confermati nella fede. Ala come può essere questo? Con assistenza speciale di Dio che guidi e illumini il Papa, e gli impedisca di dire quello che sarebbe errore. Lo Spirito Santo che Lo dirige nella ricerca della Rivelazione, quale la tradizione l’ha tramandata, Gli dà le parole per definirla infallibilmente.
• La falsa infallibilità. Ma allora il Papa non potrà mai dire un errore, in nessun caso, né mai commettere un peccato? Piano! Non confondiamo! Infallibilità non vuol dire impeccabilità. Infatti anche il Papa, come un semplice fedele si inginocchia avanti al Sacerdote, e si confessa, e gli domanda umilmente l’assoluzione. Certo non delle opere buone, ma dei peccati. Né infallibilità pontificia significa infallibilità su tutta la linea. Perché se Dio non è avaro dei suoi doni, non è neanche sprecone! Le grazie le dà proporzionate allo scopo e non buttandole senza ragione. Ora, se è necessario che il Papa, come Papa, sia in fallibile, non è però necessario che sia infallibile anche come persona privata, e perciò come tale potrà sbagliare come lutti gli altri uomini, i quali contano solamente sulla propria scienza, forse deficiente e erronea, e non su la specialissima assistenza di Dio. E anche come Papa, l’infallibilità è legata a queste due condizioni. Prima condizione: che parli come maestro universale il quale intenda con una sua definizione obbligare tutta la Chiesa; Seconda condizione: che definisca o una verità da credere (fede), o una norma di costumi da seguire (morale). Sono appunto le condizioni sottolineate nella celebre definizione del Concilio Vaticano. Queste due condizioni sono contenute nella notissima e compendiosa formola: quando il Papa parla ex cathedra. Per approfondimenti dettagliati sull’infallibilità del Papa e della Chiesa consultare questo approfondimento: https://cutt.ly/mYgWFVc.
• Dunque docilità. Il Papa è maestro di tutti. Tutti allora saranno discepoli suoi. Ma la prima virtù dei discepoli è di essere docili. Chè docile, dal latino, significa: che si lascia istruire. È giusto voler conoscere con esattezza i limiti della infallibilità del Papa. Sarebbe tuttavia almeno ridicolo e addirittura disastroso, farci colla ricerca di limiti un coltello, e con questo andar rifilando al possibile l’ossequio della nostra mente, tutti preoccupati che non ci sfugga un millimetro di più di quel che è strettamente dovuto. Il maestro non è un grammofono e il discepolo non è un barattolo da riempire: tanto e non più. L’uno e l’altro sono anime che devono comprendersi e penetrarsi; la sapienza del primo deve riversarsi nell’altro secondo giustizia. Questo appunto è quello che fa il Papa. Non sta continuamente a definire, condannare, bruciare e distruggere. Ma parla semplicemente ed insegna. In quello che egli dice vi sono a volte ripetute verità già prima solennemente definite; vi sono conseguenze logiche tratte da esse e applicazioni ovvie del dogma. L’anima del discepolo deve ricevere tutto ciò e assimilare. Il non essenziale gli serve a capire il necessario nel suo vero valore; il dogma s’illumina e si fa più comprensibile nelle sue applicazioni; tutto l’insieme l’ammaestra e lo nutre. È chiaro che solo quello che il Papa definisce solennemente ci obbliga all’ossequio della fede; ma è inumano limitarsi ai nudissimi dogmi, nel resto allontanandosi dalle vie segnate dal Papa, bene inteso: dal legittimo Papa. • Il Papa è guida. Sarebbe errore madornale pensare che la vita cristiana sia una bella autostrada: liscia, diritta, o con curve insensibili e sopraelevate, e il segnale di via libera: e che tutto possa andare da sé. Nulla di più falso. Le autostrade sono strade uniche, senza incroci e senza traverse: la vita cristiana è una vita, e la vita è fatta di mille strade incrociate, di mille sentieri, di abissi, di cime, di boschi. Il cammino si deve trovare tra tutto questo. La religione cristiana, poi, è una cosa perfetta; e le cose perfette, fuori di Dio, la perfezione la trovano nell’equilibrio. Per capire questo basta guardare la storia. Ogni eresia che ha strappato membra vive alla Chiesa è l’applicazione unilaterale di un certo principio. Allora è necessaria una guida. Perché gli uomini non sempre l’hanno voluta, ora a milioni hanno smarrito il cammino. La guida è il Papa. Egli ha avuto da Cristo l’ufficio di condurci a Lui; non solo di indicarcelo da lontano, ma di condurci. E condurre vuol dire guidare. Fra tante verità che possono essere male applicate egli c’indicherà il giusto mezzo e l’applicazione sapiente; a passi che ci sembra impossibile fare Egli ci anima mostrandoci, oltre l’ostacolo, il cammino. Il Papa proclama le verità e condanna gli errori. Il Papa esalta ciò che è bene e biasima ciò che è male. Ecco perché il Papa segue da vicino la vita cristiana in tutte le sue forme, non curando viaggiatori o miopi o in malafede, che si lamentano e si ribellano.
• Dunque fiducia. Teoricamente la cosa è assai facile. Abbiamo una guida? Seguiamola e tutto andrà bene. La pratica però è più difficile le della teoria. Dandoci il Papa per Maestro e per Guida, Dio non ci ha tolto la testa e gli occhi nostri vedono; e a volte il frutto di questo lavoro non combina con quello che il Papa ci dice. Egli ci indica una strada e a noi pare che sarebbe assai meglio seguirne un’altra; dice al mondo cristiano di fare una cosa, e ci viene in mente che sarebbe più opportuno fare il contrario. Allora dobbiamo risolverci a fare la cosa più ragionevole. E la cosa più ragionevole, per uno che si trova in una via difficile ed ha accanto a sé una guida, seguirla anche se si è perduta la bussola e non si capisce neanche più se si va avanti o indietro; anzi proprio per questo. I motivi per farlo sono due, il primo è naturale. Un poco d’esperienza. Quante volte abbiamo preso una strada che ci pareva scorciare il cammino e ci siamo trovati poi in un vicolo cieco? Questi passi inutili servono oggi a farci capire che è meglio seguire una guida che sa di più e vede più lontano e più giusto. Questa guida è il Papa, che ha l’esperienza dei secoli e dall’alto del Vaticano vede cose che noi, discenti, non vedremo mai. II secondo motivo è soprannaturale. Quando la guida ci è data da Dio, i motivi umani spariscono. Ci suona agli orecchi la voce di Quello (di Dio) a cui vogliamo arrivare: chi ascolta voi ascolta Me! Ciò disse Gesù agli Apostoli, in particolare a Pietro.
• Il Papa è padre. La Chiesa non è soliamo un esercito dove ci vuole un capo, né solo una scuola dove ci vuole un maestro. È anche una famiglia, dove ci vuole un padre. Il Padre di questa famiglia, che conta a milioni i suoi figli, è il Papa. È un nuovo avveramento della promessa consolatrice del Signore: non vi lascerò orfani! I protestanti e i sedicenti Ortodossi vedono nel Papa solo uno che impone limiti e chiede danaro e ubbidienza: ma i cristiani veri sanno che Papa significa Babbo. E non fanno gli spiriti forti. Non vanno dicendo di aver solo bisogno di verità e di fare a meno dell’amore. Gustano invece questo tepore della casa. Perché se ci sono delle ore in cui abbiamo bisogno della certezza, e di quelle in cui si cerca la mano che governi, ce ne sono anche delle altre, molto più frequenti, in cui abbiamo bisogno di sentirci amati. Dal Padre del cielo, certo; ma anche da uno che Lo faccia visibile agli occhi nostri materiali, qui in terra. Ed ecco il Papa. Basta rileggere le parole degli ultimi Papi e seguire il loro accoramento nelle nostre disgrazie e la loro gioia nelle nostre gioie, per vedere che il Papa è e si sente padre di tutti noi. Nelle guerre poi il Papa soffre come un Padre che si vede uccidere i figli, e la sua voce cerca di pacificare e riunire, come fa sempre un padre quando i figli litigano tra di loro. San Pio X è morto di dolore per la guerra mondiale. Pio XI ha offerto la vita per evitarci quella di oggi. Pio XII soffre di questa. Da Padre.
• Dunque amore. A un padre i figli devono ubbidienza e rispetto: ma soprattutto amore. E perciò il Papa lo dobbiamo amare. Anche perché solamente nell’amore si troverà forza per ubbidirGli e per rispettarLo sempre, anche quando l’ubbidienza e il rispetto possono costare un poco. Purché l’amore sia vero amore. Si manifesti cioè non a sole parole ma anche coi fatti. Perché se è bello pensare e parlare bene del Papa, e se è bene accorrere alle sue funzioni solenni, magari per acclamarlo e applaudirlo, è anche meglio difenderlo contro certi cristiani che dicono di amarlo, il Papa, ma che poi sembra che vadano a caccia di colpe da rimproverargli, come se fosse un segno di amore il ricantare ai quattro venti insinuazioni e affermazioni su presunti errori e presunte indebite ingerenze del Babbo. Peggio ancora chi, per ciò stesso palesemente errante e ribelle, dice di amare il Papato ed il Papa per poi accusare il Papa di ogni genere di errore ed eresia, nella losca ambizione di rendersi autonomo e superiore: per “erigere” a Papa se medesimo. Segno di amore è anche soccorrere il Papa. Nella sua povertà, sempre enorme date le enormi miserie degli altri, uomini e nazioni, che oggi è chiamato a soccorrere. E finalmente, per amarlo gli saremo vicini nel modo migliore: pregando per lui e con lui. Come un giorno, quando San Pietro era in prigione, si faceva per lui orazione da tutta la Chiesa, bisogna che sempre questa invocazione per il Papa salga al trono di Dio. Il peso della triplice corona che il Papa porta per amore di noi è tremendo, e la sua umanità ne dovrebbe naturalmente essere schiacciata. Per questo i figli non cessano di chiedere a Dio forza e luce che si riverserà su di loro in grazie di benedizione.
• Sua Santità. Questo titolo si dà al Papa, come ai Re si dà quello di Sua Maestà, certamente per indicare che come è propria del Re la maestà così è propria del Sommo Pontefice la santità. Si può dire che i Papi hanno portato con onore questo titolo. Dei 262 Papi, bene intendiamo fino a Pio XII legittimo Pontefice, 82 sono sugli altari: 31, come martiri, hanno suggellato col sangue le verità che avevano insegnato, e 51 ne hanno dato testimonianza con l’esercizio eroico delle virtù come Santi Confessori. Anche gli altri, quasi tutti, hanno ben meritato di Dio e della Sua causa: nei primi secoli curano di evitare scismi ed eresie; lottano poi per difendere la purità della fede e dei costumi; segue l’opera di ricostruzione dopo la decadenza frutto del rinascimento paganeggiante e la lotta contro l’Islam e il protestantesimo; in tempi più recenti, insorgono contro il pestifero illuminismo, la rivoluzione, il liberalismo, il comunismo. Il cuore di alcuni Papi è restato leggendario: San Leone Magno contro Attila, Gregorio VII contro Enrico IV, Clemente VII contro Enrico VIII, Pio VI contro Napoleone. Gli ultimi Papi poi sono una vera corona di santi. Pio IX, uomo di Dio anche nelle vicende più dolorose del suo regno tribolato; Leone XIII vegliardo di roccia e d’acciaio; il mite Pio X, martello di Dio contro il modernismo, morto di dolore nel vedere la strage delle sue pecorelle; Benedetto XV, dalla carità inesausta ed eroica; Pio XI, al cui zelo era troppo piccolo il mondo... Veramente si vede che Dio ha partecipato al suo Vicario non solo il potere, ma anche la bontà e lo splendore del Cristo.
• E Alessandro VI? Questo è il razzo finale dei giochi pirotecnici antipapali. Chi lo lancia ha l’aria di dire ai cattolici: — con un mostro siffatto come potete ancora parlare di santità dei Papi? I cattolici rispondano che per difendere la fama e la gloria del papato non hanno bisogno di nascondere e di falsare la storia. E perciò riconoscono che il Borgia, dissoluto da cardinale, divenuto Alessandro VI, non si corresse, ma a quanto sembra continuò a dare pubblico scandalo. Questi sono fatti, sebbene tanto ci sarebbe da epurare dalle menzogne dei falsi storici. Per essere obiettivi bisogna aggiungere che i suoi vizi furono smisuratamente esagerati da contemporanei e posteri, ai quali gli storici seri ormai non credono più; e che ad ogni modo, egli fu cattivo come uomo e non come Papa: in materia di fede si portò in modo correttissimo, né pensò mai a sancire con la sua autorità i disordini morali che la coscienza rimproverava. Ma la macchia resta! E purtroppo non unica! chè altri nomi di Papi si potrebbero fare, che non furono certo modelli di virtù. È questo un motivo per disprezzarLi e negare ubbidienza? No. Ma per piangere l’influsso laico e mondano nelle cose di chiesa. Del resto non sarebbe procedimento di storico spassionato, né segno di amore, il voler giudicare e condannare per le colpe di pochissimi indegni, tutta una dinastia di santi e di eroi, e di voler strombazzare ai quattro venti le vergogne, anche vere, di uomini, che non cessano di far parte della nostra famiglia, e che ci hanno lasciato un’eredità che nessuna colpa può intaccare o annullare.
• Padrone dei padroni. Non è un’accusa: è una realtà. Il Papa è un vero Capo; ha quindi un vero dominio ed è veramente padrone, come un pastore è padrone del suo gregge. Lo diciamo nelle forme ufficiali: nostro Signore il Papa felicemente regnante. Il suo dominio si mostra energicamente nei segni esterni. Egli chiama fratelli i Vescovi, ma essi si riconoscono suoi servi, ed è una grazia essere ammessi a baciarGli il piede, e Gli si parla in ginocchio. Quando entra in San Pietro è portato sulle spalle di uomini; porta manto e corona. Principi della terra ritengono titolo ereditario la sua Messa; i Re della terra sono ricevuti da Lui in udienza, più solennemente nella forma, nella sostanza come gli altri. E questo dominio che si mostra nei segni esterni, non è che il riflesso di un potere ben più profondo e intransigente. Una sua parola può far legge, e non obbliga solo a piegare la schiena, ma la mente. Roma lui parlato la causa è finita! Non discute: ordina! Non deve darci ragioni e giustificare le sue decisioni, ma comandare; e chi non vuole piegarsi avanti a Lui mette se stesso fuori della casa di Dio sulla terra. Ci sono, e non potevano mancare, anime ribelli e anime pavide, che si sono indignate ed hanno gridato alla tirannia, o hanno parlato di prudenza... Ma sono grida e timori inutili. Dio ha pieno dominio su di noi. Cristo è Dio e può trasmettere questo Suo dominio all’uomo che è Suo Vicario. E quello che poteva fare l’ha fatto. A noi non resta che ubbidire in umiltà.
• Servo dei servi? Così scrive il Papa dopo il suo nome nei documenti. Dove gli antichi re moltiplicavano i nomi di terre conquistate e tenute con la forza e l’orgoglio, Egli scrive un titolo di umiltà e di amore: servo dei servi di Dio. E non lo scrive per fare un bel gesto. Il Papa è veramente il servo dei servi di Dio, ed i servi di Dio siamo noi. Come Gesù è stato il Servo fedele, che è venuto non per essere servito, ma per servire... Già dal primo mattino il Papa è in preghiera, anche per sé, ma molto per tutta la terra. Poi riceve il Segretario di Stato, che gli presenta molti, a volte delicatissimi problemi. E il Papa non può, come immaginano gli ingenui, contentarsi di sorridere e di benedire, ma deve studiare, pensare e risolvere. Poi le udienze ufficiali che gli portano ancora problemi; e le udienze pubbliche, faticosissime, col cuore angosciato dai dolori intravisti, dalle pene portate, mute, per essere benedette da lui. E il lavoro delle Congregazioni Romane, da seguire e spesso da dirigere con iniziativa personale, e la preparazione delle Encicliche laboriosissime, per dire la parola attesa da tutti i fedeli. Se questo non si chiama servire? !... Alla sera tardi il Papa è ancora davanti al Signore. Ha lavorato tutto il giorno avanti a Lui e per Lui, ma ora gli si fa più vicino: è solo con Lui. Gli riferisce quanto ha fatto, e Gli chiede forza e luce per ricominciare domani. Questa è la realtà. E lo spirito che l’anima è quello delle parole di Cristo: chi e più grande tra voi sia come il minore, e chi è a capo sia come uno che serve.
• Il Papa e il mondo. Il Papa è un valore troppo universale per far sentire i suoi effetti soltanto sulle torre più vicine a lui. Quindi la sua azione s’estende al mondo intero. Come? Organizzando una specie di Komintera cattolico a base di cellule, di agitatori e di spie? No. Ma piuttosto richiamando l’umanità ai valori della natura umana e del soprannaturale voluto da Dio in noi. Questi valori il Papa li ha sempre presenti. Sotto i suoi occhi gli scienziati lavorano quasi unicamente per rendere più piacevole la vita all’uomo; economisti o industriali lanciano metodi e capitali per far rendere sempre più la macchina-uomo; reggitori di popoli inquadrano energie e vite umane per raggiungere ideali di patria... Egli invece sente e sa che questo al mondo non basta. Prevede per l’avvenire gli stessi disordini, arresti e fallimenti e le stesse crisi che periodicamente si succedono. Crisi di anime e di idee prima che di interessi e di corpi. Perciò Egli, preoccupato dei valori dello spirito più che di quelli della materia, dell’eterno più che del transitorio, indica la soluzione di tutti i problemi del mondo nei principi troppo sposso dimenticati di morale e di religione: nozione di male e di bene, di giusto e di ingiusto, dignità dell’individuo e doveri della società, carità e sacrificio, grazia e Provvidenza, coscienza e vita futura. Il mondo purtroppo non l’ascolta. Qualcuno lo perseguita. Come non ascoltò o perseguitò Gesù. Perciò il mondo soffre. Ma il Papa continua a insegnare, a supplicare...; sperando.
• Il Papa e l’eternità. Ti darò le chiavi del Regno dei cieli: a chi aprirai sarà aperto, a chi chiuderai sarà chiuso. Parola del Signore. Tulli gli uomini nella loro vita sostano avanti a una porta, che da soli non riescono ad aprire, e che tuttavia bisogna aprire per non morire asfissiati. Questo avviene quando, stanchi della vita piatta e vuota di tutti i giorni, cercano la risposta di quelle due o tre domande che dormono nell’animo di tutti, ma che anche dormendo pesano e danno travaglio. La chiave di questa porta è nelle mani del Papa. Molti veramente provano ad evadere dal chiuso che soffoca, ma sbagliano il modo. Credono che la liberazione si trovi nel romperla con tulle le leggi, e spezzando ogni legame d’ordine e di tradizione. Il Papa è lì per chiudere le vie false e indicare l’unica buona: quella che passa dal mondo all’eternità. E dice: rompete la catena dei sensi! Vivete di fede e di speranza nella Patria che vi aspetta! Vivete nella carità. E, aperta la via, il Papa apre i suoi tesori per offrirci i mezzi per percorrerla. Egli, Pontefice Massimo, comunica ai Sacerdoti e ai Vescovi colla giurisdizione il modo di dare la grazia. Egli colle indulgenze disserra i tesori della Comunione dei Santi. Ecco cos’è il Papa. A chi possiamo essere più obbligati? Per lui dunque pregheremo così: Da a Lui, o Signore, te ne preghiamo, di aiutare con le parole e con l’esempio quelli a cui comanda, in modo che arrivi, insieme col gregge affidatogli, alla vita eterna.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, nell’ultimo periodo, come a voi ben noto, il settimanale Sursum Corda non è stato pubblicato. Vogliate accettare le mie più sincere scuse, ma una serie di ostacoli mi hanno impedito di lavorare al progetto con la abituale cadenza fissa. Oggi rivolgeremo le nostre attenzioni allo studio della Prudenza secondo i dettami della retta ragione e della dottrina cattolica. La prudenza è una virtù fondamentale.
Le virtù naturali sono molteplici. Alcune inclinano l’intelligenza alla ricerca e alla comprensione della verità e sono le virtù intellettuali (intelletto, scienza, sapienza, prudenza, arte); altre perfezionano la volontà inclinandola in modo costante al bene, migliorando i costumi, e si chiamano morali (dal latino «mores»: costumi): tali sono la giustizia, la fortezza, la temperanza, che con la prudenza sono la base o cardine, che regge tutte le altre virtù morali. Tutte le virtù naturali si acquistano ripetendo atti buoni.
Papa San Pio X ci insegna che ci sono due specie di virtù: le virtù naturali che acquistiamo ripetendo atti buoni, come quelle che si dicono morali. La prima specie è quella delle virtù naturali, così chiamate perché non eccedono le forze della natura umana e si possono acquistare con l’esercizio e lo sforzo naturale.
Il bimbo, ad esempio, è pieno di paura: teme le tenebre, la solitudine, il pericolo. A mano a mano che cresce, si sforza per vincere la paura, diventare coraggioso e ci riesce. Dapprima è spinto ad essere coraggioso dalla paura di essere canzonato dai fratelli. A poco a poco il coraggio si fortifica per un senso di dignità personale. Fatto giovanotto e portato dalle circostanze sul fronte di guerra, al primo scoppio di bombe è ripreso dalla paura ed è tentato di fuggire, di nascondersi, ma si domina, e dopo un breve tempo non prova più paura e il suo coraggio ormai è a... prova di bomba. Con lo sforzo e con ripetuti atti ha acquistato la virtù naturale della fortezza. Chi ripete spesso atti di obbedienza acquista, a poco a poco, la virtù dell’obbedienza. Invece ripetendo atti contrari alla virtù, si acquista il vizio opposto, per esempio il vizio della disobbedienza.
Abbiamo imparato che tutte le virtù naturali si acquistano ripetendo atti buoni, mentre le virtù soprannaturali, che non possiamo acquistare e nemmeno esercitare con le sole nostre forze, ci vengono date da Dio. Il pesce, per quanto veloce e agile nell’acqua, non può volare. Per slanciarsi in volo nell’aria libera è necessaria una trasformazione radicale. Al posto delle pinne laterali deve mettere le ali, al posto della pinna caudale una coda di piume, al posto delle branchie i polmoni... Prima dovrà essere trasformato in uccello e poi potrà volare. Finché resta pesce, il volo è sempre superiore alle forze e capacità naturali. Finché noi siamo soltanto dotati di anima e di corpo, d’intelligenza, volontà, sensi interni ed esterni, per quanto siamo perfetti siamo incapaci a compiere certi atti, che sono superiori alle nostre capacità e possibilità naturali. Per compiere un atto di fede nel mistero trinitario, per amare Dio come figli... occorre che siamo elevati al di sopra della nostra natura di uomini e trasformati in figli di Dio, mediante la grazia santificante e aiutati dalla grazia attuale. Solo allora potremo compiere atti soprannaturali di fede, di speranza, di carità e delle altre virtù.
La grazia santificante eleva il nostro essere. Le capacità o disposizioni delle virtù infuseci direttamente da Dio ci rendono capaci di compiere atti soprannaturali. Queste, buone disposizioni infuse da Dio si chiamano virtù soprannaturali. Con le sole forze naturali non riusciremo mai ad acquistare le virtù soprannaturali, che ci vengono infuse assieme alla grazia santificante. Ma neppure dopo che ci sono state infuse da Dio, possiamo esercitare con le sole nostre forze le virtù soprannaturali e fare, ad esempio, atti di fede, di speranza, di carità soprannaturali. Occorre l’aiuto della grazia attuale. Le virtù naturali rendono facile il compiere gli atti loro corrispondenti. Invece le virtù soprannaturali ci danno la capacità, ma non ancora la facilità di compiere i loro atti, che ci è data dalla grazia attuale.
A tal proposito sempre il P. Carlo Dragone, nel suo Catechismo commentato, ci riporta due esempi altrettanto significativi. Carlo IX Re di Francia domandò un giorno a Torquato Tasso: — Chi è il più felice? — Dio — rispose il poeta. — Questo lo sanno tutti, replicò il Re. Io non domando di Dio, ma degli uomini. Al che Torquato Tasso: — Colui che più di ogni altro si è reso simile a Dio, cioè l’uomo virtuoso. Demetrio Falereo per le sue eccellente doti e virtù fu eletto capo di Atene, vi restò dieci anni e governò tanto bene da meritare che gli venissero erette tante statue quanti sono i giorni dell’anno. Gl’invidiosi però lavorarono contro di lui, e a poco a poco gli alienarono l’animo del popolo, il quale finì con l’abbattere le statue di Demetrio e privarlo del potere. A chi aveva chiesto che cosa pensasse di un tale mutamento di fortuna, Demetrio rispose: «Hanno rovesciato le mie statue, ma non potranno mai abbattere le virtù alle quali furono innalzate le statue».
Le virtù proprie del cristiano sono le virtù soprannaturali e specialmente la fede, la speranza e la carità. Saremo tanto più cristiani quanto più perfette saranno in noi la fede, la speranza e la carità. Noi riceviamo le virtù soprannaturali insieme con la grazia santificante, per mezzo dei sacramenti o per l’amore di carità, e le esercitiamo con le grazie attuali dei buoni pensieri e delle ispirazioni con cui Dio ci muove e ci aiuta in ogni atto buono. Per agire e compiere gli atti di virtù abbiamo bisogno della grazia attuale, come la lampadina elettrica ha bisogno della corrente, e la lampada dell’olio. Il complesso delle virtù cristiane, di dice il P. Dragone, è come un meraviglioso albero, che produce i frutti più vari e più squisiti. Il naturalista romano Plinio racconta di aver visto a Tivoli un albero meraviglioso, innestato in tutti i modi possibili, che portava ogni genere di frutti. Un ramo era carico di ciliege, un altro di noci, un terzo di uva, altri di fichi, pomi, melograni e altre specie ancora. San Francesco di Sales paragona il complesso delle virtù a quest’albero, che ha la fede come radice, la speranza come tronco, la carità e le altre virtù come rami, le opere virtuose come frutti.
Papa San Pio X ci insegna che la virtù morale è l’abito di fare il bene, acquistato ripetendo atti buoni. Le virtù che hanno Dio per oggetto e per motivo si chiamano teologali; quelle che hanno per compito di togliere gli ostacoli a fare il bene e regolano i costumi secondo la legge di Dio si chiamano virtù morali. Nel Battesimo vengono infuse le virtù teologali e le virtù morali, che però danno soltanto la capacità di compiere atti soprannaturali e virtuosi. La facilità si acquista ripetendo gli atti buoni, in modo che si formano le buone abitudini o abiti virtuosi acquisiti. Perciò le virtù morali (che rendono buoni i nostri costumi), sono inclinazioni buone, abitudini di fare atti buoni, acquistate con l’esercizio. Ad esempio: la virtù morale dell’obbedienza si acquista ripetendo spesso atti di obbedienza, finché si giunge ad avere la facilità ad obbedire con costanza e prontezza.
Chi non si esercita nelle virtù con gli atti, non solo non acquista gli abiti morali virtuosi, ma perde anche l’abito soprannaturale virtuoso, che gli è stato infuso nel Battesimo assieme alla grazia. San Giovanni Climaco racconta che, a un convento che ospitava trecento monaci, si presentò un cittadino di Alessandria, chiamato Isidoro, e domandò di essere accolto tra i religiosi. Il superiore gli domandò se fosse disposto all’obbedienza, in tutto. «Padre mio, voglio essere nelle vostre mani come un pezzo di ferro nelle mani del fabbro ». L ’abate lo ricevette e gli assegnò l’ufficio di portinaio, ingiungendogli inoltre che si prostrasse ai piedi di chiunque si presentava, dicendo: «Fatemi la carità di pregare per me, perché sono un povero peccatore!». Per sette anni Isidoro esercitò quell’ufficio ed eseguì esattamente quello che gli aveva prescritto l’abate. Come confessò egli stesso, il primo anno gli costò grande sacrificio e gli pareva di essere uno schiavo, condannato alla catena per i suoi peccati. Ma ripetendo gli atti di obbedienza imposti a poco a poco li trovò meno difficili. Gli diveniva sempre più facile obbedire, finché ebbe acquistato l’abitudine buona dell’obbedienza, che gli faceva provare gioia e pace nel fare quello che gli aveva ingiunto il superiore. Isidoro giunse così a tal grado di perfezione, che l’abate aveva deciso di fargli ricevere gli ordini sacri, ma non riuscì a vincere l’umiltà del santo religioso, che gli domandò come favore insigne di poter continuare a fare il portinaio.
Le virtù morali sono molte. Alcune sono più importanti e altre meno. Quelle che hanno maggior importanza nella vita cristiana e che principalmente regolano i nostri costumi, rendendoli onesti e conformi alla legge divina, sono le quattro virtù cardinali, che sono il fondamento e la base di tutte le altre. Le virtù teologali ci uniscono direttamente a Dio come a loro oggetto creduto, sperato e amato. Le virtù cardinali regolano i nostri costumi in modo che possiamo esercitare le virtù teologali e aderire a Dio con tutto il nostro essere. Tutte le altre virtù morali dipendono dalle quattro cardinali, o come loro parti soggettive (aspetti particolari di esse), o come parti integranti, che le completano e perfezionano, o come parti potenziali. Tra le virtù dipendenti dalla giustizia ha particolare importanza la religione, che il Catechismo considera prima tra le virtù morali. La religione regola i nostri rapporti con Dio, conforme agli obblighi che ci derivano dai primi tre comandamenti del Decalogo.
Le virtù cardinali sono cosi chiamate, perché sono il cardine, cioè il sostegno delle altre virtù morali. I cardini sorreggono le imposte delle finestre e i battenti delle porte. Le virtù cardinali sorreggono tutte le altre virtù morali, che poggiano tutte quante sulla prudenza, sulla giustizia, sulla fortezza e temperanza e dipendono da esse o come parti soggettive, o come parti integranti, o come parti potenziali. Le virtù morali sono molteplici e si distinguono dall’oggetto cui inclinano, cioè dalla specie di bene che ci fanno praticare e secondo le facoltà umane che perfezionano e regolano nei loro atti.
I principi interni dai quali procedono tutti i nostri atti (attività morale) sono quattro: intelletto, volontà, appetito concupiscibile e appetito irascibile. Ognuna delle quattro virtù cardinali regola uno di questi principii delle nostre azioni. La prudenza regola e perfeziona gli atti dell’intelligenza in quanto si riferiscono alla moralità e ai costumi; la giustizia governa la volontà e ne dirige gli atti in modo che dia a ciascuno (Dio, se stessi, il prossimo) ciò che gli è dovuto; la fortezza regola l’appetito irascibile, facendo sì che le passioni che da esso procedono (ira, audacia, timore, speranza, disperazione) non trascinino la volontà al male, ma la spingano alla scelta del bene; la temperanza fa altrettanto riguardo alle passioni dell’appetito concupiscibile (amore, desiderio, gaudio, odio, fuga, tristezza). Tutta la perfezione della vita cristiana consiste nell’esercizio delle virtù teologali, morali e intellettuali.
La prudenza è la virtù che dirige gli atti al debito fine, e fa discernere e usare i mezzi buoni. «Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali, prese le loro lampade, mossero incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque prudenti. Le cinque stolte presero sì le lampade, ma non portarono l’olio con sé. Le prudenti invece presero con le lampade anche l’olio nei loro vasetti. Ritardando a venire lo sposo, tutte si assopirono e dormirono. Ma sulla mezzanotte s’alzò un grido: Ecco, viene lo sposo; uscitegli incontro . Allora tutte le vergini si alzarono, misero in ordine le loro lampade, e le stolte dissero alle prudenti: Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le prudenti risposero: Perché non ne manchi né a noi né a voi, andate piuttosto da chi ne vende e compratevene. Ora mentre andavano a comprarne, venne lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. All’ultimo giunsero anche le altre vergini e gridarono: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi conosco. Vegliate adunque, perché non sapete né il giorno, né l’ora» (San Matteo, XXV, 1-13).
Nostro Signore in questa meravigliosa parabola descrive il modo di agire di chi ha la virtù della prudenza e di chi ne è privo. Le fanciulle prudenti si propongono un fine: attendere lo sposo dell’amica e fargli onore. Scelgono i mezzi adatti: prendono le lampade, si provvedono d’olio, appena sentono il grido di gioia, che le avverte dell’arrivo dello sposo, accendono prontamente le lampade e si guardano bene dal privarsi dell’olio dandone una parte alle compagne imprevidenti. Così sono pronte, ricevono lo sposo con onore, sono ammesse al banchetto nuziale e conseguono pienamente lo scopo proposto. Invece le fanciulle stolte o imprudenti si propongono lo stesso fine di quelle prudenti, ma trascurano un mezzo indispensabile: l’olio. All’ultimo momento chiedono alle compagne parte del loro olio; avuto un rifiuto corrono a comprarne, ma è notte, stentano a trovarlo e quando giungono è troppo tardi: non hanno agito con prudenza, perché hanno trascurato i mezzi atti a raggiungere lo scopo.
La prudenza è la virtù che dirige gli atti al debito fine e fa discernere e usare i mezzi buoni. (NB: il fine NON giustifica mai i mezzi). La prudenza è una virtù soprannaturale, che viene infusa con la grazia e si rafforza con l’esercizio, diventando acquisita. La prudenza inclina prima di tutto a proporre un fine soprannaturale alle proprie azioni; proposto il fine fa ricercare, scegliere e usare i mezzi adatti per raggiungerlo. Chi, nelle sue azioni, non si propone un fine soprannaturale (per esempio. la gloria di Dio, la salute delle anime, la riparazione dei peccati propri e altrui, ecc. ) o, pur proponendosi un fine buono, non sceglie e non adopera i mezzi adatti per conseguirlo, è stolto. Lo stolto del Vangelo, che cominciò a edificare senza calcolare le spese necessarie, trascurò di ricercare i mezzi adatti e si rese degno delle derisioni altrui.
La prudenza è assolutamente necessaria per salvarsi, perché non si può meritare la vita soprannaturale se non si agisce con un fine retto e non si usano i mezzi di grazia indispensabili. La prudenza ha molte, virtù morali che le fanno corona. Virtù o parti integranti della prudenza. Per guidare al retto fine; nella scelta dei mezzi la prudenza si serve di parecchie virtù, che la integrano e completano: a) la memoria, ricordando esperienze, consigli, letture, ecc., li. offre alla prudenza perché se ne serva; b) l’intelligenza fa conoscere i principii secondo i quali la prudenza si deve regolare e le circostanze di cui deve tener conto; c) la docilità rende pronti a seguire i buoni consigli altrui; d) la solerzia trova subito i mezzi adatti per agire; e) la ragione trae con prontezza le conseguenze utili per agire; f) la provvidenza fa antivedere ed evitare gl’inconvenienti e gli ostacoli all’azione : g) la circospezione tiene conto di tutte le circostanze perché non vi siano deficienze nell’onestà dell’azione; h) la precauzione fa evitare ciò che può ostacolare l’onestà dell’azione.
Virtù o parti soggettive della prudenza. Sono i vari modi o aspetti con cui si esplica la prudenza: a) prudenza naturale, che si serve dei soli lumi dell’intelligenza naturale; b) prudenza soprannaturale, infusa nel Battesimo, si rafforza e perfeziona con l’esercizio e si serve soprattutto dei lumi della fede; c) prudenza monarchica (da «monos: uno solo»), o personale, che inclina l’uomo a ben governare e guidare se stesso; d) prudenza governativa (che può essere domestica, sociale, pastorale, giudicatrice) guida gli uomini nel governare gli altri.
Virtù o parti potenziali della prudenza. Sono come le ancelle o aiutanti al servizio della prudenza: a) eubulia: inclina a consigliarsi nei casi dubbi; b) sinesi: inclina a vagliare attentamente i mezzi proposti dall’eubulia, giudicando secondo le leggi comuni; c) gnome: fa giudicare rettamente nelle circostanze straordinarie, ma sempre secondo la mente del legislatore. Per esempio: la legge comune proibisce di rubare; ma la gnome mi dice che Dio non intendeva proibire di prendere ad altri quanto mi è necessario per non morire di fame.
Vizi, opposti alla prudenza. Si può peccare contro questa virtù, (come contro qualsiasi altra), o per mancanza di prudenza (peccati per difetto) o per un eccesso di prudenza (peccati per eccesso). Si oppongono per difetto i seguenti vizi: a) la precipitazione spinge ad agire senza prima aver riflettuto e deliberato sul fine e sui mezzi; b) l’inconsiderazione non tiene conto delle circostanze che possono viziare la bontà dell’azione; c) l’incostanza inclina a mutare fine e mezzi senza motivo; d) la negligenza fa trascurare i consigli dell’intelletto. Sono vizi contrari alla prudenza per eccesso: a) la prudenza della carne, che cerca con cura i mezzi e li fa usare per soddisfare le passioni cattive; b) l’astuzia, che si serve di mezzi ingiusti, come l’inganno e la frode, per conseguire uno scopo cattivo. Sempre il P. Dragone riflette: L’uomo prudente pensa e riflette prima di parlare e di agire. Abituiamo i giovani alla riflessione.
Il patriarca Giacobbe, fuggito in esilio per salvarsi dall’ira del fratello Esaù, al quale aveva carpito il diritto di primogenito, quando volle tornare in patria agì con grande prudenza, per vincere l’ostilità del fratello. Quand’ancora era lontano spedì alcuni messi per saggiare gli umori di Esaù, che non diede alcuna risposta e radunò quattrocento uomini per andare incontro a Giacobbe e fare le sue vendette. Temendo sempre più, Giacobbe divise i suoi greggi in due squadre, facendone precedere una, in modo che se il fratello avesse preso con la violenza la prima, egli potesse fuggire e salvare l’altra. Mandò anche ricchi doni al fratello, che consistevano in duecento capre e venti capri, duecento pecore e venti montoni, trenta cammelli con i loro piccoli, quaranta giovenche, venti asine, dieci buoi e dieci asini. Divise poi la sua famiglia in tre gruppi, facendo precedere i servi, poi i figli e infine seguiva egli con la moglie Rachele e il figlio prediletto Giuseppe. Esaù restò abbagliato da tanta ricchezza, commosso da tanti doni e onori, specialmente quando vide il fratello avvicinarsi e prostrarsi sette volte. Vinto e commosso Esaù depose ogni proposito di vendetta, abbracciò il fratello, lo baciò e pianse di contentezza.
Tra i monaci della Tebaide era sorta una disputa per sapere quale fosse la virtù più necessaria a progredire nella perfezione cristiana. Alcuni assegnavano il primo posto alla penitenza con le astinenze e i digiuni, altri al distacco dalle cose mondane, altri alla solitudine, altri alla misericordia... Sant’Antonio concluse la disputa dicendo: «Tutte le virtù che voi esaltate meritano grandissima lode. Ma l’esperienza di tanti errori e passi falsi, che ho veduto commettere da molti, mi persuade che la virtù più necessaria di tutte a progredire nella perfezione è la prudenza, che è come la direttrice e la guida di tutte le altre. Quando manca la prudenza non tardano a giungere l’errore e il peccato».
Le passioni sono commozioni o moti violenti dell’anima che, se non sono moderati dalla ragione, trascinano al vizio e, spesso, anche al delitto. In noi vi sono forze o inclinazioni potenti che ci spingono alla ricerca del bene che ci può fare felici. Le inclinazioni o appetiti fondamentali sono due: l’appetito concupiscibile o propensione al godimento del bene, e l’appetito irascibile, o propensione che riguarda gli ostacoli che si oppongono al conseguimento del bene, cioè il bene in quanto è arduo. Dall’appetito concupiscibile nascono queste passioni o moti dell’anima: amore per il bene in generale, desiderio del bene quando è lontano, gaudio per il bene presente, odio per il male in genere, fuga del male assente, tristezza per il male presente. L’appetito irascibile dà origine a queste passioni: ira o indignazione per il male sensibile, audacia nell’affrontare il male presente, timore del male assente, speranza di vincere il male e conseguire il bene, disperazione di vincere il male e di conseguire il bene. Le passioni sono forze potenti, che hanno il compito di aiutare e potenziare la volontà nella ricerca del bene e nella fuga del male. Prima del peccato erano un aiuto prezioso, perché spingevano la volontà verso il vero bene e l’allontanavano dal vero male. Dopo il peccato originale l’intelligenza si oscurò e spesso erra ritenendo come bene il male e come male il bene; la volontà è stata indebolita, e facilmente può essere sopraffatta dalle passioni, che inclinano più al male che al bene, più al bene apparente che a quello vero. Le passioni sono così diventate un incentivo al male e spesso sono causa di peccato. Le passioni devono essere regolate dalla ragione e dominate dalla volontà, la quale, con l’aiuto della grazia, riesce, non a distruggerle, il che sarebbe impossibile, ma a contenerle e a dirigerle al bene e a servirsene come di un mezzo efficace e potente. Per esempio, i ragazzi che NON sono abituati a dominare la gola e l’ira, molto facilmente da adulti diventano sensuali e rissosi.
Chi vuol vivere la vita cristiana e praticare le virtù deve prima di tutto combattere le passioni cattive. Però sarebbe sforzo vano e inconcludente attaccare tutte le passioni assieme. Occorre combatterle ad una ad una, cominciando da quella che è predominante, che anima e guida tutte le altre. Ciascuno di noi ha una passione che è più forte delle altre. Per molti è la superbia, per altri la pigrizia, per altri la gola... Nel combattere le passioni è indispensabile prenderle ad una ad una, abbatterle e domarle separatamente, come si racconta che fece l’unico superstite dei tre fratelli Orazi contro i Curiazi. Narra la leggenda che, per evitare una guerra imminente, i Romani e i loro nemici si accordarono di affidare le sorti della guerra a un combattimento singolo fra tre fratelli romani, detti Orazi, e tre fratelli avversari, detti Curiazi. Nella lotta erano già caduti due degli Orazi e restavano ancora i tre Curiazi. L’unico Orazio superstite ricorse allora all’astuzia e si diede alla fuga. I tre avversari lo rincorsero, distaccandosi imprudentemente l’uno dall’altro. Il romano, quando si avvide che erano sufficientemente distanziati, si volse indietro, affrontò il primo dei Curiazi e lo uccise. Quindi riprese la fuga e l’inseguimento. Voltosi nuovamente e d’improvviso vinse, uccise il secondo avversario e infine anche il terzo.
Saul era stato eletto da Dio re d’Israele per le sue ottime qualità e virtù. Ma non seppe reprimere alcune passioni, che lo condussero alla rovina. Dapprima fu preso dalla gelosia verso Davide, che si era acquistato grande popolarità uccidendo il gigante Golia. Dalla gelosia passò alla diffidenza, che lo spinse a spiare tutti i passi di Davide. Infine divenne ingiusto e, spinto dall’odio, tentò ripetutamente di uccidere Davide. Riprovato da Dio per la superbia e per le disobbedienze agli inviati del Signore, morì suicida, dopo aver perduto la battaglia. Il suo regno fu dato da Dio a Davide. Giuda non represse in tempo la passione dell’avarizia, cominciò con i piccoli furti, la passione crebbe sempre più, finché lo spinse a vendere il Maestro per trenta vili monete. Non volendo resistere alla disperazione, quando vide il Maestro condannato andò a impiccarsi. Fin qui i preziosi insegnamenti del P. Carlo Dragone.
Studiamo, adesso, la medesima voce nella teologia morale, dal Roberti-Palazzini. Intesa in senso largo, la prudenza consiste nell’escogitare, scegliere ed attuare i mezzi adatti per raggiungere qualunque fine o evitare qualunque male. Così si parla di un industriale o di un commerciante prudente, e il Signore ha detto che i figli del mondo sono più prudenti dei figli della luce. In senso stretto e eminente, la prudenza consiste nell’investigare, proporre alla volontà, ed ingiungere alle potenze esecutive, ciò che è adatto per raggiungere il nostro fine ultimo vero, che è Dio. Intesa in questo senso, la prudenza è un atto virtuoso.
Entro l’ambito della prudenza strettamente detta, bisogna distinguere: un giudizio bensì pratico, ma non ancora ultimo-pratico, il giudizio ultimo-pratico, e il dettame imperativo che dirige le potenze esecutive. Prima di porre un’azione, è necessario infatti investigare e giudicare se è moralmente buona: cosa da fare senza ingiustificate esitazioni o ansie, ma anche con diligenza proporzionata alla gravità della cosa e alle condizioni soggettive. Per potersi formare bene la coscienza, prima di agire, bisogna considerare attentamente le norme generali della moralità e i particolari del caso presente. Nei casi più complessi, sarà a volte necessario interrogare la propria esperienza ; prevedere le difficoltà che possono sorgere nell’eseguire una cosa, e le conseguenze che può avere un’azione, per noi stessi e per altri; consultare con docilità uomini savi e sperimentati, in specie il proprio direttore spirituale, senza dimenticare di ricorrere al migliore dei consiglieri, lo Spirito Santo.
Siccome siamo ordinati a un fine soprannaturale, la nostra prudenza deve attingere luce dalle verità rivelate, e non dalle sole verità di ragione. La volontà può impedire il portare, secondo le regole della prudenza, ossia nel modo dovuto, un giudizio circa la moralità di un nostro atto. Distinto da questo giudizio, non ancor ultimo-pratico vi è il giudizio ultimo-pratico, che consiste nel giudicare puramente buono, al momento presente (simpliciter bonum, hic et nunc), quello che è onesto, e quindi adatto per raggiungere il nostro fine ultimo: giudizio da emettere, senza esitazioni o indugi, qualora si tratti di una cosa che apparisce doverosa. Questo giudizio è il principale, tra gli atti della prudenza. È, però, sotto un certo aspetto, dipendente dalla volontà: l’intelletto, infatti, non potrebbe giudicare meramente buona una cosa, che si manifesta inadeguata all’oggetto della volontà, se questa non si arrendesse alla medesima cosa, con una autodeterminazione per la quale esistono ragioni sufficienti, ma non ragioni costringenti, poiché l’oggetto della volontà è il bene senza limiti. Siccome, però, la volontà non vuole se non ciò che le viene presentato come puramente buono, la suddetta scelta dipende, sotto un altro aspetto, dal simultaneo giudizio ultimo-pratico. Questi due atti, dipendenti uno dall’altro, formano un tutto completo, sotto l ’aspetto morale. All’ultimo giudizio pratico segue, quando è d’uopo, da parte dell’intelletto mosso dalla volontà, il dettame imperativo, che dirige le altre potenze, nell’esecuzione di ciò che è voluto.
Siccome non vi è peccato senza un giudizio ultimo-pratico in opposizione con le regole della prudenza, ogni peccato è contro la prudenza. Questo difetto generale non costituisce, tuttavia, un peccato specificamente proprio. Vi sono però peccati che consistono nella trascuranza o nell’abuso di elementi propri alla prudenza; essi costituiscono una propria specie: sono peccati contrari alla prudenza, sia per difetto, sia per eccesso. Poiché però la colpevolezza suppone la libertà, è evidente che essa non può esistere se non nell’atto della volontà; mentre gli atti delle altre potenze, anche dell’intelletto, possono essere peccaminosi soltanto per partecipazione, in quanto, cioè, dipendenti da un atto inordinato della volontà, con il quale formano un tutto, sotto l’aspetto morale. Per difetto, sono opposte alla prudenza: l’inconsiderazione e la precipitazione, che consistono nell’emettere un giudizio pratico e nell’agire, senza aver considerato sufficientemente tutto ciò che è necessario prendere in considerazione, prima di giudicare e di decidersi: la colpa è mortale, qualora si incorra un serio pericolo di trasgredire una legge, in materia grave, o si disprezzino addirittura le regole prudenziali o un precetto grave; la esitazione, che è la mancanza di dovuta prontezza nel giudicare puramente buono e nell’eseguire ciò che è apparso doveroso: di per sé, è colpa veniale; sarebbe tuttavia una colpa mortale l’applicare l’intelletto a deliberare seriamente intorno alla convenienza di compiere un dovere grave; l’inconstanza, ossia il desistere, senza motivo sufficiente, dal proseguimento di una cosa buona, anteriormente voluta: di per sé, è colpa veniale, può essere però colpa mortale, a ragione di ciò che viene tralasciato; la negligenza, che consiste nel tralasciare l’ingiunzione e l’esecuzione di una cosa doverosa: il grado di colpevolezza dipende da ciò che viene omesso.
Per eccesso, sono opposte alla prudenza false somiglianze di essa: l’escogitare, lo scegliere e l’eseguire mezzi opportuni per appagare l’immoderata brama dei beni materiali, degli onori e dei piaceri (prudenza della carne): il grado di colpevolezza dipende dalle disposizioni d’animo e dalla natura dei mezzi scelti; l’escogitare e lo scegliere mezzi scaltri per conseguire un fine sia buono che cattivo, in particolare mezzi che sembrano onesti e che non manifestano nessuna intenzione cattiva, affine di danneggiare il prossimo (astuzia), e il mettere in opera, a parole o a fatti, mezzi astuti (inganno e frode): la colpa è più o meno grave, a seconda delle disposizioni d’animo e dell’entità del danno cagionato; l’eccessiva sollecitudine per l ’acquisto e la conservazione dei beni temporali, o per cose che possono accadere nel futuro: la colpa è grave, quando si fa di queste cose il fine ultimo, e quando la sollecitudine è tale da far trascurare qualche dovere grave. Vi è però una moderata sollecitudine intorno alle cose temporali, che non è peccaminosa, ma prudente.
Ognuna delle virtù cardinali è come un centro, attorno a cui si muove un corteggio di virtù, in certo senso minori e che quindi si sogliono chiamare parti di quella virtù, parti soggettive, integrali o potenziali.
Parti soggettive della prudenza. Sono le specie minori in cui si distingue. Esse possono ridursi: alla prudenza monastica o personale, che riguarda il governo del singolo, e alla prudenza governativa o collettiva, che riguarda il governo della comunità; questa a sua volta può suddistinguersi in economica o domestica, se riguarda la famiglia o comunità minori, e politica, se riguarda la società perfetta, sia civile che ecclesiastica; alla politica si riduce la prudenza amministrativa, la militare, la internazionale e così via.
Parti integrali della prudenza. Sono le attitudini che concorrono a perfezionarla. Di esse alcune mirano a perfezionare l’aspetto conoscitivo, e cioè la memoria del passato, l’intelligenza del presente, la docilità, la solerzia e la ragionevolezza; alcune a perfezionare l’aspetto precettivo, e cioè la provvidenza, la circospezione e la cautela. La memoria del passato è il tesoro delle esperienze che orientano e danno norma per regolarsi sul presente. L’intelligenza è la retta conoscenza e valutazione pratica delle circostanze, nelle quali ci si trova attualmente ad agire. La docilità dispone a ricevere e far tesoro delle lezioni proprie ed altrui del presente e del passato. La solerzia o sagacia anima e sprona e sorregge nella vigile esplorazione del da fare. La ragionevolezza pondera e valuta a fil di logica tutti questi elementi. La provvidenza spinge innanzi quanto può l ’attenzione, come per prevedere il futuro che è conseguenza del passato e del presente, e predispone i mezzi. La circospezione gira tutta intorno il lungo raggio della provvidenza. La cautela o accortezza considera attentamente i pericoli o i danni che possono venirne e predispone efficacemente i mezzi preventivi.
Parti potenziali della prudenza. Sono le virtù minori, che da essa, come da matrice, germogliano e ad essa a loro volta servono: stanno ad essa come le potenze all’anima, che delle potenze stesse si serve per agire: esse sono il buon consiglio, il buon senso, il senso dell’eccezione. Il buon consiglio è l ’abito di ben ricercare e trovare a tempo e luogo opportuno i mezzi convenienti al fine. Il buon senso è l ’abito di ben giudicare e valutare secondo le regole comuni. Il senso dell’eccezione è l’abito di saper distinguere i casi che esorbitano più o meno dalle norme comuni e saperne tenere il giusto conto, secondo l ’esigenza di superiori principi; esso guida e modera la retta applicazione della norma e la giusta applicazione dell’equità e dell’epicheia.
Il Dizionario di teologia dommatica Piolanti-Parente-Garofalo aggiunge importanti nozioni sulla prudenza e sulle virtù più in generale. La virtù è un abito operativo che San Tommaso, sulla traccia di Aristotele, definisce: «Buona qualità della mente, per cui si vive rettamente e di cui nessuno può servirsi per il male». Alla virtù si oppone l’abito cattivo che è il vizio. Le virtù naturali si acquistano con la ripetizione costante degli atti buoni e si distinguono in virtù intellettuali e virtù morali. Quattro sono le virtù fondamentali dette anche cardinali (da cardine): 1) Prudenza: «recta ratio agibilium» = scelta ed ordine dei mezzi al fine. Regina delle virtù cardinali propria dell’intelletto. 2) Giustizia: abito che inclina la volontà a fare quel che si deve, secondo la ragione. È virtù sociale (in rapporto ad altri). 3) Temperanza: modera l’appetito concupiscibile (la passione del piacere sensibile). 4) Fortezza: modera o corrobora l’appetito irascibile contro le difficoltà.
Le virtù soprannaturali sono abiti infusi da Dio nelle facoltà insieme con la grazia santificante che è infusa nell’essenza dell’anima. Secondo la dottrina comune tra queste virtù si pongono anche le cardinali qui sopra elencate, che perfezionano ed elevano quelle naturalmente acquisite. Ma le principali virtù infuse sono quelle teologiche perché hanno Dio come oggetto formale (mentre le cardinali hanno per oggetto un bene finito). Le virtù teologiche sono tre: 1) Fede: inclina l’intelletto (e la volontà) ad aderire fermamente alla parola rivelata da Dio. 2) Speranza: inclina la volontà a confidare in Dio buono ed onnipotente per ottenere da Lui la vita eterna (bene sommo difficile) e le grazie per meritarla. 3) Carità: inclina la volontà ad amare Dio per se stesso, e noi e il prossimo per Dio. È la regina delle virtù teologiche, che fa unire a Dio come Dio e come presente. Essa, avendo per oggetto proprio e formalissimo Dio, fine supremo, è, secondo San Tommaso, forma, madre, radice, motore di tutte le altre virtù. Pensiero ampiamente sviluppato in San Paolo nel bellissimo cap. 13 della la Lett. ai Corinti. La carità è intimamente connessa con la grazia santificante e però insieme sono infuse, insieme si perdono col peccato. La fede e la speranza invece possono rimanere nel peccatore senza la grazia e la carità: in questo caso si chiamano fede e speranza informi, mentre con la carità si dicono formate. Al momento dell’infusione della grazia sono infuse anche tutte le virtù e i doni dello Spirito Santo [Cfr. Conc. Vienn. (DB, 483) e Conc. Trid. (DB, 800)].
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, è nostra intenzione condividere la Lettera Pastorale «Smascheriamo le calunnie e rivendichiamo la verità» di S. Em. Carlo Salotti, anno 1947.
Al venerabile clero e al diletto popolo della città e diocesi, salute e benedizione. Stringiamoci attorno a Cristo. Napoleone Bonaparte, malgrado i suoi difetti, le sue in temperanze, i suoi errori, usciva talvolta in giudizi così recisi, da lasciare una traccia profonda nei ricordi del suo tempo. Una delle sue espressioni più tipiche fu questa: «Un popolo senza Dio non si governa; bisogna mitragliarlo». Dio è la sola entità e la sola forza, che può frenare le passioni incomposte degli uomini, richiamandoli alle norme del dovere e della rettitudine. Ma se un popolo, ingannato da falsi filosofi o da avventurieri politici, vuol fare a meno di Dio, o negandolo o bestemmiandolo, allora non rispetterà più alcuna legge umana, si ribellerà a qualsiasi autorità non solo religiosa ma anche civile, e si abbandonerà a tutti gli eccessi. Eccoci così al disordine sociale, alla rivoluzione, all’anarchia. In questo caso ai Capi responsabili di governo non rimarrebbe altro mezzo di difesa, che quello della mitraglia e del cannone. Ma con le mitraglie e i cannoni si potrà forse ristabilire l’ordine materiale attraverso il sangue e le stragi, che lasceranno sempre traccio di nuovi odi e di efferate vendette?
Il vero ordine morale e sociale sarà conseguito soltanto, quando nella coscienza delle masse venga ripristinato il concetto di un Dio, che ha diritto di essere amato, onorato e adorato dall’umanità da Lui creata e redenta. Non aveva dunque torto l’Onorevole Lucifero, allorché con atto veramente coraggioso auspicava che nel progetto della Costituzione si introducesse un articolo per invocare la protezione di Dio. La proposta sembrò strana al Capo del comunismo, il quale per confutarla fece appello al primo Comandamento: «Non nominare il nome di Dio invano». Ma, col porre Dio come base della legislazione, non si fa cosa vana ed inutile, poiché, nella storia dell’umanità e nelle tempeste dei secoli, Dio è sempre la luce che illumina i popoli e li guida sulle vie del progresso; è l’amore che si trasfonde nelle creature, le quali debbono aiutarsi e non sopraffarsi a vicenda; è la giustizia che deve rispecchiarsi nelle nazioni in guisa, che le più potenti non abusino della forza per annientare le più deboli, strappando loro quei diritti che Dio stesso consacrò.... Sia dunque Dio il principio della nostra Repubblica italiana, se vogliamo che questa prosperi e fiorisca.
È sempre quel Dio che poi assunse forme di uomo per riscattare l’umanità da tutti gli obbrobri nei quali era caduta; e a questo scopo fondò quella religione che in Roma doveva avere il suo centro propulsore e una Cattedra infallibile di verità. Da questa Cattedra sono scaturiti insegnamenti preziosi, i quali, se da una parte hanno illuminato e diretto la società per le vie del bene, dall’altra hanno costantemente condannato tutte quelle aberrazioni, che la spingevano verso la decadenza morale e civile. Cristo! Eccolo il nostro Dio. Tutta la sua vita, la sua predicazione evangelica, la sua passione, la sua morte, la sua risurrezione sono le prove più evidenti della sua divinità. Operaio autentico, lavorando pazientemente nella officina, ha redento e santificato il lavoro. Apostolo ha scolpito nelle coscienze le massime di una morale nuova, che aborre dalle nefandezze del vecchio paganesimo. Maestro ha insegnato dottrine, che elevano e nobilitano la dignità umana. Angelo di consolazione ha confortato i più atroci dolori della vita con le promesse immancabili di un premio ultraterreno. Ministro della carità più squisita, si è prodigato generosamente verso i malati, i poveri e i derelitti. Flagellatore implacabile di tutte le iniquità, si è fatto araldo di giustizia in favore dei perseguitati. Assertore di fraternità ha sancito un patto, col quale uomini di lingua e di stirpe diversa debbono ritenersi membri di una grande famiglia, il cui Padre è lo stesso Iddio. Esempio fulgidissimo di vita esente da qualsiasi minima colpa, si è rivelato come il tipo della più assoluta perfezione morale. Operatore di portenti, che trascendono tutte le forze della natura, ha dimostrato di avere sull’universo un dominio che nessuna creatura può arrogarsi. Martire sale il Calvario, sottoponendosi agli strazi più orrendi; e col suo sacrificio riscatta le anime da un servaggio brutale. Trionfatore della morte rovescia la pietra del suo sepolcro, e, levando in alto la croce, segna il passaggio tra un decrepito mondo agonizzante nelle sue turpitudini, e un mondo nuovo sfolgorante nella luce della civiltà cristiana. Se esiste un Dio, come effettivamente esiste, non può essersi manifestato se non nella persona incomparabile di Cristo. Venti secoli di storia si sono inchinati dinanzi a Lui, e lo hanno adorato.
Il suo messaggio è penetrato negli angoli più remoti della terra, suscitando dovunque consensi e ammirazione; e, se ha trovato ostacoli nelle persecuzioni, i martiri li hanno infranti col coraggio e col sangue. Le legislazioni dei popoli si sono ispirate a quel messaggio, e ne hanno tratto lumi e stimoli per una elevazione morale e civile. La scienza, il diritto, l’arte, la letteratura, le scoperte hanno inneggiato al Suo Nome divino. La nostra Italia in maniera particolare si è consacrata a Cristo; e non vi è pagina della sua storia, che non ne porti scolpita la immagine santa... Prosegue qui:
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «La Religione. Obiezioni e risposte» del P. Giulio Monetti, imprimatur 1942.
• Ma perché una religione a preferenza di un’altra? Affermano gli illogici: «Bene; sia pure, quanto alla Religione in genere ed alle sue esigenze. Non so tuttavia capire perché deve proprio praticarsi una Religione a preferenza di un’altra; e quindi perché si voglia ad ogni costo che si vada in chiesa, mentre Dio è in ogni luogo e in ogni luogo lo si può onorare e pregare: — che si assista alla Messa, esteriorità che può ben essere compensata con culto interno intensissimo, elevatissimo: — che ci s’inginocchi innanzi al prete per riceverne l’assoluzione e la Comunione, mentre è ben più presto fatto l’intendersela direttamente con Dio». Rispondiamo: Ho capito, si pretende di passare per buone tutte le Religioni, indistintamente; sicché significa poi lo stesso il professare l’una piuttosto che l’altra, ed anche si possa mutare a capriccio quella che si ha, come si farebbe con un abito che si mette o si ripone secondo le circostanze.... Siamo pratici: questo pregiudizio dove conduce in realtà? A non praticare proprio nessuna religione; sotto pretesto che l’una non obbliga, l’altra non obbliga... l’ennesima non obbliga; — lo dice l’esperienza di tutti i giorni, e pressoché di tutti gli indifferenti. Dunque abbiamo una nuova maschera contro il gas asfissiante (purtroppo per molti è così) della Religione! — Una nuova gretola per svignarsela, di fronte agli obblighi positivi della Religione!
• Ma l’intende proprio così quel Dio, che per mezzo della Religione DOBBIAMO onorare, e col quale avremo poi un giorno, ciascuno per parte sua, a fare i conti? — Anche nell’ipotesi più benigna che tal gente si faccia alcuna volta a pregare Iddio, ad onorarlo, a ringraziarlo, a domandargli perdono dei falli commessi, ecc. — tutte cose che sono gli atti più elementari della Religione? Ritorniamo al principio fondamentale in questa materia, ricordando che la Religione è un debito, la somma dei nostri debiti diretti con Dio Creatore, Conservatore, Cooperatore, Legislatore.... Dunque non tutte le religioni sono buone, né è indifferente l’attenersi all’una piuttosto che all’altra, bisogna vedere quella che tra l’altre sia la vera, l’accettata da Dio. È Lui, il Creatore, e non già la creatura, che deve fissare le condizioni e il protocollo delle udienze divine e dei divini ricevimenti — quali sono le celebrazioni religiose! Pertanto la sola vera Religione sarà la moneta verace, legale, ammessa da Dio a saldo del debito che hanno verso di Lui le creature razionali; le altre religioni, per quanto possano essere “speciose”, per quanto antiche e diffuse, per quanto largamente accreditate, per quanto siano «la religione degli avi», non saranno che moneta falsa, contraffazione della Religione vera...
• Facciamo ancora un paragone. Quale è quel padrone che si accontenterebbe di un servo, che fa tutt’altro di quello per cui fu assunto ed è pagato? Tizio s’accontò come cameriere: ma.... non sostenendo il chiuso delle camere vuole di suo capriccio uscire fuori all’aperto, e fare il fattorino: — Caio, l’ortolano, invece di respirare l’aria aperta, vuol godersi il caldo e le fragranze appetitose della cucina, dando una mano al cuoco, — quell’altro, dattilografo, tediato della sua taciturna solitudine, passa le ore dal portinaio, sia pure aiutandolo nelle sue faccende, invece di spenderle allo scrittoio: — che modelli di servi, non è vero? — Come il padrone se ne avrà a lodare! — Eppure possono essere proprio brava gente, nel senso che “non fa proprio male a nessuno”!
• Non altrimenti si porta con Dio chi vuole scegliersi a talento la religione da praticare, vale a dire il modo pratico di onorare e servire il Signore. — Per quanta volontà si mostri esternamente di rendergli omaggio, c’è però sempre in questo procedere un vizio latente radicale; ed è l’assurda pretesa che Dio si accomodi a noi, accontentandosi di quanto a noi piacerà di dargli, e rinunziando al resto: mentre invece sta a noi, servi, di dipendere in tutto dal gran Padrone, Iddio. Ed ecco spiegato perché Dio vuole più specialmente essere onorato in chiesa, come luogo più adatto, piuttosto che in altri luoghi meno convenienti (quale sarebbe un campo sportivo), per quanto anche in questi luoghi Egli sia presente per la sua immensità.
• Come in antico nell’unico tempio di Gerusalemme, così oggi nelle sue chiese moltiplicate Egli ha eretto il suo trono di misericordia; ed è là specialmente che vuol essere onorato e pregato. Là solamente accetta il santo Sacrificio, che è l’atto precipuo della Religione; là pure soltanto rimane Gesù presente, nella SS Eucaristia, con la presenza anche corporea della sua adorabile Umanità. Che ci starebbe a fare, se non si andasse in chiesa?
• Abbiamo accennato al santo Sacrificio, cioè alla S. Messa, dicendolo l’atto precipuo della Religione. È noto il proprio simbolismo del Sacrificio: — Dio Creatore è Padrone assoluto della nostra vita, e noi, a riconoscere tale sua assoluta padronanza, dobbiamo essere pronti a sacrificarla in suo onore, a un suo semplice cenno. — Ma Dio, buon Padre, si accontenta che sostituiamo a noi stessi un’altra vittima, testificandogli, con l’immolazione rituale di essa, la nostra piena ed assoluta sudditanza; ciò che avviene nel legittimo Sacrificio. Oggi, dunque, che l’unico Sacrificio legittimo, riconosciuto ed accettato da Dio è la S. Messa, ogni buon servo di Dio vi deve partecipare nella misura prescritta: cioè con l’assistervi nei giorni festivi: — ecco il perché del positivo precetto della Messa domenicale. Chi non l’osserva per sua cattiva volontà, trascura la Religione nel punto suo principale, né mai tributa a Dio nella sua integrità l’ossequio caratteristico che gli è dovuto, e che Egli rigorosamente richiede. Religione senza sacrificio è un controsenso; e tal controsenso commette quel cristiano che pretende di praticare la Religione senza partecipare alla S. Messa, unico sacrificio ora accetto a Dio.
• Resta da dire dell’obbligo della Confessione sacramentale annuale, e della Comunione Pasquale. Potremmo qui fermarci a dimostrare la necessità nostra soggettiva (di purificarci l’anima con la Confessione — di nutrirla, sovrannaturalmente, almeno una volta all’anno col Divino Pane Eucaristico) alla quale detti obblighi intendono soddisfare, tutto per nostro bene: ma ci basti per ora solo la seguente riflessione. Se Dio, il gran Padrone, vuole così, che farci? Possiamo chiedergli conto? Possiamo noi negarci ad obbedirlo anche in questo? — E chi è che comanda? Noi a Dio o Dio a noi? — Dio vuole che noi andiamo a confessarci dai suoi Sacerdoti? Non c’è rimedio! Bisogna andarci! — Dio vuole che ci comunichiamo almeno a Pasqua? Neanche qui c’è rimedio (posto che ci si richiedesse con ciò una gran servitù, mentre dovremmo riguardare la S. Comunione come il massimo onore, e la nostra massima felicità qui in terra!): a Dio che ci chiama alla Sacra Mensa dobbiamo senz’altro rispondere: «presente!». Diversamente ce la vedremo poi con Lui un giorno: nel giorno del pareggio dei conti, innanzi al Divin Giudice!
• Quant’altro dovremmo ancora aggiungere riguardo alla preghiera — praticamente ed abitualmente negletta — da chi pretende che tutte le Religioni sono buone, per credersi autorizzato a non averne nessuna! — E intendiamo la «preghiera quotidiana», la quale, senza essere ancora né sacramento, né sacrificio, è pure concreto contrassegno per distinguere chi viva da cristiano e chi vive da bestia. Sentiamo che quest’ultima frase è un po’ forte: ma che farci, se essa è vera? Essa è del grande Emiro Abd-el-Kader l’eroe sfortunato dall’indipendenza araba. Egli disse un giorno che «il cristiano è inferiore di molto al maomettano (perdoniamo al povero seguace di Maometto il suo errato apprezzamento contro il Cristianesimo, del quale né conobbe le bellezze, né le avrebbe potute apprezzare degnamente, finché rimaneva l’animalis homo cresciuto fra le sozzure del Corano): — il giudeo è peggio di un cristiano: — l’idolatra è peggio del giudeo: — la bestia è peggio dell’idolatra: — ma chi non prega è peggio di una bestia!».
• Sollevando il tono della musica, diceva parimenti il Guizot, scrittore e statista protestante: «Solo l’uomo, tra tutti gli esseri della terra, prega. E l’istinto della preghiera è tra i suoi istinti morali l’istinto più naturale, più universale, più ineluttabile... Ogni età della vita umana, ogni popolo dell’umana specie, ha le sue invocazioni; e vi si ricorre da tutti in certi casi, sotto certe impressioni... L’uomo sente allora che SIAMO IN MANO DI DIO ...». Amico mio, se non preghi, non saresti tu forse MENO CHE UOMO?
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «La Religione. Obiezioni e risposte» del P. Giulio Monetti, imprimatur 1942.
Obiettano gli sfortunati: «Quanta gente onesta, fiore di galantuomini, che non va in Chiesa! Ora ciò non sarebbe, se fosse da prendersi alla lettera tutto quello che s’è detto. Diciamo dunque che bisogna prendere le cose “cum mica salis”, con un tantino di buon senso e di discrezione! Non tutto quello che è bello, utile, simpatico, fiore di ragionevolezza, è poi da esigersi come necessario! Se se ne può far senza....».
Rispondiamo: — Discrezione, dici? — Ma che cosa c’è di più discreto della Religione, intendo della vera e autentica? Moltissime cose le inculca, e cerca di persuaderle a tutti, perché davvero lo meritano, tanto sono sublimi e proficue: ma è essa la prima a non comandarle; con ciò stesso le lascia alla nostra discrezione! Altre le comanda: ma quanto poche esse sono, e meravigliosamente discrete, se già non appartengono alle precise prescrizioni della legge naturale! Si tratta della Santa Messa festiva? Con quella viene riservata a Dio non più che una mezz’oretta alla settimana, mentre tutto il resto del tempo viene lasciato per noi, alla nostra discrezione! Si tratta del riposo festivo? Esso è opera della massima discrezione, in favore tanto dell’anima quanto del corpo: — del corpo, imponendoci di dargli requie almeno un giorno la settimana, invece di farlo faticare indiscretamente; — dell’anima, per la quale non si richiede certo troppo indiscretamente se le si rivendicano le cure di un giorno su sette, mentre alla cura del corpo sono lasciati gli altri sei giorni! Si tratta della frequenza ai SS. Sacramenti? In rigore, essa è frequenza obbligatoria soltanto una volta all’anno! Proprio cosa indiscreta, da rompere davvero le ossa! Indiscreto l’esigere che, almeno una volta l’anno, si rediga il proprio bilancio spirituale, che pur converrebbe fare tutte le sere... e si torni a cibarsi del Pane Eucaristico, datoci dal suo Divino Istitutore per pane quotidiano dell’anima. Trattasi dei digiuni e delle astinenze ecclesiastiche? Sono così poca cosa, e d’altronde così igienica, ch’è una vergogna il lagnarsene! La guerra c’impone ben altro! E devesi poi aggiungere che, per quanto i suddetti obblighi religiosi siano gravi, tutti, quando esiste veramente proporzionata ragione, restano come neutralizzati, com’è noto dalla pratica approvata dalla Chiesa: dov’è dunque l’indiscrezione, se non dalla parte di chi, né per Iddio né per l’anima, né per l’eternità non vuol proprio far nulla..., mentre in vece lì dovrebbe concentrare i pensieri e le attività migliori?
Ed ora dal tema della discrezione passiamo al tema del «galantuomo.... che non va in chiesa». Se un tal galantuomo se ne stesse zitto, né ostentasse punto il suo galantomismo areligioso, pazienza. L’avrei per un galantuomo... deficiente, di scarto, che troverà — se continua così — chiusa la porta del Paradiso; dato che roba di scarto lassù non ce ne entra. Quindi tal galantuomo che da Dio, infinitamente giusto, si farà condannare all’Inferno. E quest’osservazione già da sé basterebbe: mi pare! Se invece è un galantuomo che ostenta il suo galantomismo che... non va in chiesa, per me colui o è un fatuo che non sa quel che si dice. Allora «non ragionar di lui, ma guarda e passa»: ovvero è un ipocrita del galantomismo. Il suo posto è tra la gente scellerata nemica di Dio e dell’onestà. È infatti evidente che non può dirsi onesta quella persona che manca abitualmente a qualcuno dei suoi stretti doveri, per quanto suppergiù osservi gli altri suoi obblighi. Per essere deferito ai tribunali come malfattore e farabutto, non c’è niente bisogno di violare tutti gli articoli del codice; basta l’averne violato quel tale — anche uno solo — che ti manda in galera: la quale non è precisamente il ritrovo abituale dei galantuomini autentici. E così nessuno chiamerà galantuomo chi sia in provata opinione di ladro, per quanto non uccida, non si ubriachi, non sia calunniatore del prossimo, non sia uno del gregge immondo di Epicuro. Parimenti nessuno vorrebbe avere che fare con galantuomini che, per quanto non uccidano e non rubino, pure o insidiano all’altrui virtù, o sono continuamente impegnati nello straziare l’altrui fama; — ed ognuno arrossirebbe di avere in famiglia un crapulone che si ubriacasse obbrobriosamente ogni giorno, sebbene egli fosse per ogni altro verso irreprensibile.
Quand’è così, è assurda la pretesa di essere e di parer galantuomo, quando non si abbia nel dovuto conto, e teoricamente e pratica- mente, l’obbligo tanto principale della religione; ancorché si possa sinceramente asserire che non si ammazzi, non si rubi, non si pregiudichi ingiustamente o malevolmente alla fama del prossimo, né in altro sinistro modo si faccia parlare di sé. Non è davvero un galantuomo chi non paga i suoi debiti, specialmente i suoi debiti verso Dio, dando a Dio quello che è di Dio: — né è cosa da poco o trascurabile il non volere rendere a Dio l’onore che gli è dovuto, i ringraziamenti che gli sono dovuti, le riparazioni che gli sono dovute, la servitù di intima disposizione di animo, e insieme di fatto, che gli è dovuta. E tale è appunto il non andare in chiesa, il non volerne sapere di pratiche religiose: delitto gravissimo di lesa Maestà Divina, e ingiuria sanguinosa fatta a Dio sempre presente, che viene trattato dall’irreligioso come.... quantità trascurabile, mentre Dio è tutto per lui!
Replicano i cocciuti «Esagerazioni! Chi pensa mai ad insultare Iddio? Può esserci questione di altro che di negligenza, d’irriflessione, d’incomprensione più che spiegabile per chi conosca un poco il mondo contemporaneo?».
Rispondiamo: Verissimo: nel più dei casi non ci sarà l’insulto formale, cioè intenzionale, contro Dio; sarebbe il colmo della perversione e protervia. E ringraziamo il Signore che non siamo ancora a questo punto, nelle nostre popolazioni, almeno là dove non sia peranco arrivata l’onda infernale bolscevizzante dei «senza Dio»: ne dovremmo pronosticare ben male per l’avvenire della nostra Patria e della società, quando vi dovessimo assistere a così dirette provocazioni dei fulmini dell’ira divina! Più ancora: ammettiamo, in casi isolati e sporadici, una mentalità tanto inferiore, che non si renda ragione dell’insulto che l’irreligione fa a Dio Creatore; colpa della materializzazione della vita, dell’abbruttimento dell’uomo in certi lavori da schiavi, in certi ambienti moralmente viziati, di propaganda esiziale sovversiva dei principii fondamentali della coscienza umana, di fatale indebolimento delle forze dello spirito di fronte ad una quotidiana lotta della vita assolutamente sfibrante. Tali casi esorbitano dal giro della normalità sociale, rientrando nell’ambito della patologia morale. Quando invece si tratta dell’irreligiosità di certa gente — irreligiosità sotto forma di opposizione astiosa a quanto sa di religione; — oppure irreligiosità sotto forma di indifferenza ai pensieri di Dio ed ai propri religiosi doveri; — oppure irreligiosità determinatamente ammessa, adottata fors’anche come sistema, seguita come una moda in voga, allora le cose cambiano!
Abbiamo infatti gente che resiste ai precisi voleri di Dio — e gli resiste in faccia dacché Iddio è presente dappertutto, in ogni istante, a qualsiasi creatura. Dio vorrebbe quel Tizio alla Messa festiva: ed egli non se ne dà per inteso, rimanendosene a letto, od al suo tavolo di studio, o cogli amici, o sfaccendato addirittura a fumarsi il suo sigaro, a leggersi la sua corrispondenza o il giornale, o a sorbirsi il suo caffè. Dio lo vorrebbe ai SS. Sacramenti alla Pasqua, ed egli non se ne cura, continuando a fare il suo comodaccio, come dicendo a Dio col fatto, se non colle parole: «Strepita quanto vuoi: che io non mi muovo! E minacciami pure le tue tremende sanzioni, il tuo Inferno: io me ne infischio!». Se questo non è già da sé un insultare Iddio anche senza la satanica formale intenzione di vilipenderlo e di fargli dispetto, non se ne capisce più nulla! C’è forse bisogno di un attentato in stile, o di una ribellione armata, o di un tradimento premeditato e qualificato, per raggiungere gli estremi giuridici dell’offesa all’autorità? Basta qualsiasi violazione della legge: quando questa sia provata, il giudice procede alla condanna. Così avviene tra gli uomini; così pure avviene nelle nostre relazioni con Dio, quanto al decadere dalla sua grazia, e quando al meritare l’ira terribile. Che se Egli, infinitamente misericordioso e misteriosamente longanime, non fulmina subito i temerari suoi offensori, ma dissimula e tollera, e continua loro i suoi benefici, non per questo i violatori della sua legge ne restano scusati. Se non approfittano dell’immeritata indulgenza per convertirsi, se anzi perfidiano in aggiungere offese ad offese, se continuano a sfruttare i divini benefizi (vita, forze, sostanze, occasioni ecc.) proprio a «ufo», cioè senza venire una volta al pagamento dei propri debiti verso Dio, verrà poi bene l’ora del pareggio dei conti!
Passata l’ora utile, concessa all’uomo per disporre di sé medesimo e per scegliersi la sua eternità, — la «hora vestra» cui accennò Gesù ai giudei al momento della sua cattura, — la «dies tua», accennata dallo stesso Gesù a Gerusalemme nel rimproverarle la sua cieca ingratitudine, — sopravverrà la «dies irae, calamitatis et miseriae, dies magna et amara valde» l’ora del Signore, nella quale Egli rivendicherà appieno tutti i suoi diritti «usque ad novissimun quadrantem». Vedranno allora gli spiriti forti, gli indifferenti, i galantuomini che non vanno in chiesa, tutti coloro che protestano di non aver tempo per pensare ai debiti che hanno con Dio e pagarli, lo sbaglio enorme da sé fatto nel trascurare la Religione e le sue pratiche assolutamente vitali per l’anima, valevoli tanto efficacemente per assicurarci l’eternità beata! Ed essi lo confesseranno: «Erravimus!». E apparirà ancora con quale ragione o sincerità una tal gente andasse ripetendo: «Ma io non ammazzo e non rubo... Che male faccio?». Chè tutti quegli infelici appariranno evidentemente come veri suicidi dell’anima propria, quanto alla vita soprannaturale; — veri ladri di ciò che spettava a Dio di suo pieno diritto; — veri assassini delle anime altrui, tratte con sé in perdizione per mezzo del pessimo esempio d’irreligiosità dato a tanti pusilli che vi si conformarono.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi parleremo di Angeli con il grande Cornelio Alapide.
• 1. ESISTENZA E MOLTITUDINE DEGLI ANGELI. La Sacra Scrittura attesta l’esistenza degli Angeli e molti luoghi, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, ne fanno fede. Se si riuniscono insieme questi passi, si vedrà che nove sono i cori degli Angeli, così distinti e chiamati: Angeli, Arcangeli, Troni, Dominazioni, Virtù, Principati, Potestà, Cherubini e Serafini. Che il numero, poi, di queste angeliche creature sia straordinariamente grande, i Padri lo deducono da quella parabola che si trova al capo XVIII di San Matteo, dove Gesù Cristo dice che se alcuno ha cento pecore, ed una di esse si svia, lascia certamente le novantanove sulla montagna per mettersi alla ricerca di quell’una che si è smarrita. Nelle novantanove vedono gli Angeli che hanno perseverato, nell’una perdutasi riscontrano il genere umano. Come dunque è grande il numero degli Angeli, se è paragonato alle novantanove pecore!
• 2. GLI ANGELI SONO GIUSTIFICATI PER LA FEDE IN GESÙ CRISTO. Gli Angeli sono anche pecorelle del Figliuolo dell’uomo: perché, quantunque Gesù Cristo non sia loro Redentore come lo è degli uomini, perché gli Angeli non hanno peccato, è tuttavia loro Salvatore in questo senso, che Egli ha loro meritato tutte le grazie che hanno ricevuto e tutta la loro gloria, cioè la loro elezione, predestinazione e vocazione, e tutti gli aiuti prevenienti, concomitanti, efficaci; Egli è il principio del loro merito e dell’aumento della loro grazia e gloria. Gli Angeli ebbero una fede viva in Gesù Cristo fatto uomo, e furono giustificati per questa fede. Così parlano i teologi.
• 3. BELLEZZA E FELICITÀ DEGLI ANGELI. Tobia, essendo uscito di casa, s’incontrò con un giovane raggiante di bellezza e con sopra le vesti una cintura, come un viaggiatore che sta per mettersi in cammino (TOB. V, 3). Anche nei Libri dei Maccabei troviamo descritto lo splendore degli Angeli: ed essendo nell’antico patto comparsi molte volte gli Angeli, tanto apparvero belli agli uomini, che questi li scambiavano per Dio medesimo, e volevano adorarli. Nel Cielo gli Angeli compongono la corte del Re dei re e vi appaiono circondati di gloria e di bellezza, come d’un loro proprio vestimento. La loro felicità non potrebbe essere più grande, dal momento che si specchiano di continuo nel volto del Padre celeste (MATTH. XVIII, 10). «Sembrava agli occhi vostri, diceva l’Angelo a Tobia, ch’io mangiassi e bevessi, ma io mi nutro di una vivanda che gli uomini non possono vedere» — Videbar quidem vobiscum manducare et bibere; sed ego cibo invisibili et potu, qui ab hominibus videri non potest, utor (TOB. XII, 1-3).
• 4. UFFIZI DELL’ANGELO CUSTODE. Il ministero degli Angeli custodi consiste: 1° nell’allontanare i pericoli e dell’anima e del corpo...; 2° nell’illuminare, istruire e invitare a buoni pensieri, a pii desideri, a sante opere...; 3° nell’impedire che i Demoni insinuino malvagie idee, nel tenerci lontani dalle occasioni del peccato e nell’aiutarci a vincere le tentazioni...; 4° nell’offrire a Dio le preghiere dei loro protetti...; 5° nel pregare per loro...; 6° nel correggerli se peccano...; 7° nell’assisterli in punto di morte, fortificarli, aiutarli, consolarli...; 8° nel condurre dopo morte le anime al Cielo e, se sono condannate al Purgatorio, accompagnarvele e dare loro conforto, finché ne siano liberate. L’universo ha il suo Angelo custode; così pure ha il suo ciascuna nazione, città, parrocchia, famiglia, e individuo. Il Signore, come ci afferma il Salmista, ha comandato ai suoi Angeli, di stare sempre ai fianchi d’ognuno e vegliarci amorevoli d’attorno: Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis (Psalm. XC, 11); ed essi, obbedienti, ci sosterranno con le loro mani affinché il nostro piede non inciampi e noi non cadiamo: In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum (ibid. 12). «Ecco, disse il Signore nell’Esodo, ch’io invierò il mio Angelo a precedervi, a guardarvi lungo il cammino, e introdurvi nel luogo che vi ho preparato. Rispettatelo, ascoltate la sua voce e guardatevi attentamente dal disprezzarlo» — Ecce ego mittam Angelum meum, qui praecedat te et custodiat in via, et introducat in locum quem paravi. Observa eum, et audi vocem eius, nec contemnendum putes (Esod. XXIII, 20-21). Tobia augura a suo figlio ed alla sua guida, che sia prospero il loro viaggio, che Dio vegli sui loro passi e che l’Angelo suo li accompagni, — et Angelus eius comitetur vobiscum (TOB. V, 21); e confortava sua moglie, desolata per la partenza del figlio, a non piangere, nella speranza che questo sarebbe giunto al termine del suo viaggio, e ritornato a loro in buona salute; perché egli credeva che l’Angelo di Dio l’avrebbe accompagnato e avrebbe disposto tutto in suo vantaggio, così che l’avrebbero rivisto pieno di vita e di gioia (ibid. V, 26-27). Quando poi questo figlio di Tobia fu in procinto di ritornarsene al padre, l’augurio di Raguele fu questo: «L’Angelo santo del Signore vi assista nel viaggio e vi scampi da ogni pericolo» — Angelus Domini sanctus sit in itinere vestro, perducatque vos incolumes (lbid. X, 11). Dice la Scrittura che gli Angeli stanno ritti in piedi innanzi al Signore; e questo vuol dire: 1° che gli Angeli si volgono a Dio e gli chiedono la sua luce divina, per conoscere la sua volontà riguardo le loro funzioni...; 2° che gli presentano le buone opere, i sacrifici, le limosine, le preghiere degli uomini...; 3° che si tengono pronti a servire il Signore, come servi ai cenni del padrone e come soldati preparati al combattimento...; 4° che assistono ai giudizi di Dio sostenendo la causa degli uomini contro le accuse dei Demoni e ne aspettano la sentenza...; 5° che stanno in faccia a Dio per lodarlo, per contemplarlo e per attingere, da questa contemplazione, la felicità suprema. Essi stanno di continuo davanti al Signore, in quanto che non cessano di bearsi in Lui... Notate qui: 1° la dignità dell’anima, dal fatto che un Angelo le fu assegnato per guardiano...; 2° l’umiltà dell’Angelo, nell’abbassarsi fino all’uomo; 3° la sua carità...; 4° la nostra fortuna...; 5° la bontà di Dio...
• 5. VANTAGGI E FELICITÀ CHE CI PROCURANO GLI ANGELI. La presenza degli Angeli santi è dolce ed amabile, dice S. Antonio; essi non altercano, non gridano, non parlano, ma in silenzio, con bontà e dolcezza sono solleciti di spandere nei nostri cuori la gioia, l’allegria, la confidenza, perché il Signore, che è la sorgente d’ogni gioia, si trova con loro. Allora il nostro spirito, senz’affanno, ma sereno e tranquillo, viene illuminato dalla loro luce: allora l’anima, piena del desiderio delle ricompense celesti, desiderando di rompere, se potesse, la prigione del suo corpo e gemendo sotto il peso delle membra, ha fretta d’andarsene con gli Angeli in Cielo. La bontà degli Angeli è tanta che se taluno, attesa la fragilità umana, è spaventato dal loro splendore, tolgono via ben tosto ogni timore e spavento. Il medesimo Santo indica poi ancora i segni da cui si può riconoscere la presenza degli Angeli cattivi che sono i Demoni. Quando i maligni spiriti sono presenti, egli dice, si vedono visi malinconici; si odono orribili rumori; ci assalgono pensieri abominevoli; ci molestano passioni disordinate, l’anima sente un tremito e rimane come intorpidita. Essi eccitano l’odio, la noia, il dispetto; evocano il ricordo del mondo; svegliano il disgusto di averlo abbandonato; mettono raccapriccio della morte; infiammano la concupiscenza e fanno che la virtù ci stanchi; essi snervano il cuore. Ma se al timore sottentra la confidenza in Dio, il gaudio e la carità, sappiate che il vostro buon Angelo vi sta vicino, che vi porta soccorso, e che è esso che v’ispira e vi dirige (In Vita Patr.). Giuditta, dopo aver reciso il capo ad Oloferne, chiamava in testimone Iddio, che l’Angelo di lui l’aveva custodita e conservata senza sozzura e macchia, sia nell’uscire della città, sia durante il suo soggiorno nel campo nemico, sia nel ritorno (IUDITH. XIII, 20). Mentre Giuda Maccabeo andava con i suoi a combattere sotto le mura di Gerusalemme, apparve davanti alla schiera un cavaliere con le vesti bianche, le armi d’oro e con una lancia in mano. A quella vista benedissero tutti ad una voce la misericordia del Signore, pieni di confidenza e pronti ad affrontare non solamente gli uomini, ma le belve più feroci, e ad assaltare mura di ferro. Essi camminavano baldi dell’aiuto del Cielo, e sotto l’occhio del Signore infinitamente buono verso di loro. Giunti dai nemici, si avventarono loro addosso come leoni, e ne fecero strage (II Mach. XI, 8-10). Non vi è infatti ostacolo insuperabile, nessun essere invincibile, niente di difficile, niente d’impossibile per un Angelo. Un Angelo discese ai fianchi di Azaria e dei suoi compagni nella fornace ardente, ne spartì le fiamme, e impedì al fuoco di recare alle loro persone la minima scottatura o pena. Rompendo allora il silenzio, Nabucodonosor disse: «Sia benedetto il Dio di Sidrach, di Misach e d’Abdenago, il quale mandò l’Angelo suo a liberare i suoi servi che in Lui hanno creduto» (DAN. III, 50-95). Ed anche Daniele nella fossa dei leoni lodava Dio, perché gli aveva mandato il suo Angelo che chiudeva la bocca ai leoni, e impediva che gli recassero nocumento (ibid. VI, 22). S. Pietro è in carcere; l’Angelo suo vi discende, illumina la segreta, spezza le catene al principe degli Apostoli, spalanca le porte e gli dice: «Togliti di qui e va a predicare Gesù Cristo». Pietro tornando in sé dallo stupore dice: «Ah! ora conosco che il Signore mi ha inviato il suo Angelo, il quale mi ha tolto alle mani d’Erode ed al mal talento della plebe giudea» (Act. XII).
• 6. DOVERI NOSTRI VERSO L’ANGELO CUSTODE. Su quelle parole del Salmo XC: Angelis suis Deus mandavit de te — «Il Signore ha ordinato ai suoi Angeli d’aver cura di voi»; così parla S. Bernardo: «Quanta riverenza ti deve incutere, quanta riconoscenza suggerire, quanta confidenza insinuare, questa disposizione! Rispetto per la sua presenza, gratitudine per la sua benevolenza, fiducia nella sua custodia. Guardati dall’osare in faccia sua, quello di cui ti vergogneresti in faccia mia [Quantum tibi debet hoc verbum inferre reverentiam, afferre devotionem, conferre fiduciam! Reverentiam pro praesentia, devotionem pro benevolentia, fiduciam pro custodia. Tu ne audeas illo praesente, quod vidente me non auderes (In Psalm. XC, Serm. XII)]». «Onorate, ci dice Iddio nell’Esodo, l’Angelo ch’io manderò a precedervi, ascoltate la sua voce e guardatevi dal disprezzarlo, perché egli non vi risparmierà quando farete del male ed è in lui il mio nome. Ma se darete ascolto alla sua voce... io vi vendicherò dei vostri nemici e castigherò quelli che vi tormentano» — Ego mittam Angelum meum, qui praecedat te... Observa eum, et audi vocem eius, nec contemnendum putes; quia non dimittet cum peccaveris, et est nomen meum in illo. Quod si audieris nomen eius... inimicus ero inimicis tuis, et affligam affligentes te (Exod. XXIII, 20-22). Quindi il Salmista diceva a Dio: «Io canterò inni alla vostra gloria in presenza degli Angeli» — In conspectu Angelorum psallam tibi (Psalm. CXXXVII, 2). Oltre a questi, abbiamo un altro non meno importante dovere verso i nostri Angeli, ed è che per corrispondere alla bontà con cui c’illuminano, ci purificano, e si prendono cura di renderci perfetti, noi dobbiamo fare una vita santa; avere costumi puri, vivere nel nostro corpo come se vivessimo in un corpo estraneo; essere, insomma, angeli su la terra, per meritarci di essere riuniti agli Angeli nel soggiorno della gloria. S. Paolo ce lo dice: «Non siete ormai più ospiti e stranieri, ma abitatori della città dei santi e famigliari della casa di Dio» — Iam non estis hospites ed advenae, sed cives sanctorum et domestici Dei (Eph. II, 19). Non bisogna mai dimenticare la presenza dei nostri Angeli custodi, ma pregarli, parlare loro sovente, ringraziarli... Badiamo di non contristarli e affliggerli con i nostri peccati... «Gli Angeli della pace, dice Isaia, piangevano amaramente» — Angeli pacis amare flebant (ISAI. XXXIII, 7). Risparmiamo loro queste lagrime amare, ma siamo cagione di gioia per loro. È sentenza di San Basilio che il peccato, questa piaga schifosa e ributtante, allontana da noi l’Angelo custode, come il fumo mette in fuga le api, ed il fetore le colombe [Sicut fumus apes, et fetor columbas fugat, sic miserabile et putidum peccatum repellit vitae nostrae custodem Angelum (In Psalm.)]. Evitiamo, dunque, e fuggiamo a tutta possa il peccato che è il mortale nemico di Dio, degli Angeli e degli uomini (Dai Tesori di Cornelio Alapide, v. Angeli).
• Gli angeli sono puri spiriti, non purissimi, perché, essendo creati, sono limitati; solo Dio è spirito purissimo da ogni limite e difetto, perché in creato e semplicissimo. L’angelo dopo che è stato creato non può morire e cessare di esistere. Lo spirito, che comincia ad esistere per creazione e non finisce più, è immortale. Sono esseri immortali gli angeli e l’anima dell’uomo, che hanno principio ma non fine. L’angelo, come essere intelligente e sussistente, è una persona. Gli angeli sono dotati d’intelligenza acutissima, che comprende istantaneamente le cose senza bisogno di ragionamento e dell’aiuto dei sensi. L’intelligenza degli angeli ammessi alla gloria del cielo, oltre che dalla grandissima potenza intellettiva propria della loro natura, è illustrata dal lume della gloria nella visione beatifica, che svela loro Dio e tutte le sue opere, rispecchiandole nella divina Essenza.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «La Religione. Obiezioni e risposte» del P. Giulio Monetti, imprimatur 1942. Nemici e falsi amici di Cristo asseriscono: «Si vorrebbe arrivare a tutto: ma francamente, come si fa? Si hanno tante brighe di negozi, di corrispondenza, di doveri di società, di sollecitudini famigliari, ecc., che ci vorrebbero ben quarantotto ore al giorno, e non so lo ventiquattro, per venir a capo di ogni cosa: e Dio lo sa!... per fortuna, c’è ben un proverbio che dice: Chi lavora prega».
Rispondiamo: Ripiego magnifico! Come se il protestare che non si ha tempo per pensare al pagamento dei nostri debiti, bastasse a cancellare questi stessi debiti dal libro di Dio, che ne è il creditore! Sta invece il fatto che tali nostre partite restano sempre accese, finché o in un modo od in un altro non le pareggiamo: giacché, per quanto le nostre occupazioni siano moltiplicate ed assorbenti, dobbiamo sempre trovare il tempo necessario per porgere a Dio i nostri doveri, per indirizzarGli le nostre preghiere, per mostrarGli la nostra riconoscenza, per professarGli - anche in opera - la nostra servitù incondizionata, per darGli soddisfazione per le offese fatteGli, ecc., ecc. E poco giova appellarsi al citato proverbio: il lavoro è preghiera. Sì, il lavoro è preghiera, ma come? Quando? Nel senso, forse, che possa sostituire senz’altro la pratica religiosa? Nel senso che il badare agl’interessi del corpo scusi dal badare agl’interessi dell’anima, e tanto valga il badare egoisticamente a sé quanto il sacrificarsi per Dio, e il mandare innanzi a tutto i negozi e le preoccupazioni del tempo sia un bel prepararsi la propria casa nell’eternità? Proporre tali questioni è risolverle! «Lavorare e pregare» in quanto l’uomo veramente religioso, dopo avere fedelmente sciolto a Dio il proprio debito, sa che può tranquillamente passare al lavoro a sé necessario o conveniente, senza scapito dell’anima; che può, anzi, santificarlo, se è in grazia di Dio, col farne al Signore l’offerta, tramutandoselo in merito soprannaturale, proprio come farebbe con la preghiera: ma ciò vale anche del riposo, dei pasti, delle oneste conversazioni e ricreazioni, ecc., senza che alcuno possa presumere che tutte queste cose possano semplicemente sostituirsi alla Religione.
Tolto di mezzo quest’equivoco, veniamo al pretesto della mancanza di tempo. In questa materia, «volere è potere!». Basta volerlo seriamente: il tempo da dedicare ai doveri religiosi si troverà! L’esperienza di tanta gente, sovraccarica quanto si vuole di faccende e faccende, ma di buona coscienza cristiana, ce lo dice continuamente; e la vediamo fedelmente in chiesa alla Messa festiva, ai SS. Sacramenti, alle prediche, alle Sacre Funzioni, senza pregiudizio dei lavori, degli affari, dei suoi impegni sociali. Quelli il tempo voluto lo trovano: perché non dovremmo trovarlo anche noi? E poi, ragioniamo: dovessero pure, per trovare tal tempo da praticarvi la religione, Sacrificarsi altri interessi, bisognerebbe ben rassegnarsi! Prima il dovere: poi le ricchezze! Prima il dovere: poi le amicizie! Prima il dovere: poi le sollecitudini per la propria fama e per i propri avanzamenti! Prima il dovere: poi gli spassi, i diporti! Prima il pensiero di Dio, dell’anima e dell’eternità: poi gli altri pensieri, della sanità, della famiglia, della posizione sociale, ecc. Questa è ragionevolezza ed onore! Non dobbiamo mica essere gli eterni miopi che non vedono oltre la punta del loro naso, ma dobbiamo essere lungimiranti; non gli uomini del solo presente che passa; ma gli uomini anche dell’avvenire oltremondano che resta! Là sono i veri nostri interessi supremi, le nostre ricchezze, le nostre glorie legittime ed immortali, le nostre posizioni magnifiche, le nostre non passeggere fortune! Il che non toglie che la pratica della Religione possa essere - e sia senz’altro - immensamente giovevole anche al presente: dov’è pratica religiosa sincera, viva, completa, c’è la benedizione di Dio!
Un padre di famiglia, sinceramente religioso, avvantaggerà col risparmio il suo patrimonio: avvezzando, altresì, la crescente figliolanza alla equilibrata parsimonia ed alla sana frugalità. Un operaio esemplarmente religioso, sarà perciò stesso altrettanto diligente nell’opera sua, pieno di rispetto ai soprastanti, moderato nelle sue richieste: sarà perciò preferito dai padroni, più facilmente gratificato e promosso, più largamente soccorso nel caso d’improvvisa strettezza. La pratica della Religione impedirà altresì ai professionisti, agli studiosi, ad altre persone più agiate, di contrarre abitudini nocive non meno alla borsa che alla salute ed all’anima: così può dirsi in generale che quel poco tempo sottratto agli interessi materiali per darlo alla vita devota rientra, per altra via, a guadagno dei medesimi. Oltreché Iddio si occuperà con speciale provvidenza del benessere di colui che cura di pagarGli esattamente i suoi debiti di adorazione, di servitù, di riconoscenza. L’ha promesso solennemente e lo farà!
Ciò detto da «La Religione. Obiezioni e risposte» del P. Monetti, vediamo dal Dragone chi merita il Paradiso. Merita il Paradiso chi è convinto che il lavoro sia preghiera? Chi lavora senza pregare? Il «Catechismo» di Papa San Pio X insegna che «merita il Paradiso chi è buono, ossia chi ama e serve fedelmente Dio, e muore nella sua grazia». Commenta il P. Dragone: Nostro Signore, nella parabola evangelica dei talenti, ci dice che i servi fedeli (coloro che avranno fatto gl’interessi del padrone) nel giorno del rendiconto sa ranno premiati e fatti partecipi della felicità del padrone (v. Mt. XXV, 14-24). In questa parabola Gesù volle raffigurare la sorte che attende gli uomini buoni. Il merito è il diritto alla ricompensa, annesso all’opera buona fatta in favore di chi assegna il premio. Il lavoratore che compie bene l’opera pattuita ha diritto alla ricompensa. Il merito è detto «de condigno» quando vi è parità tra l’opera meritoria e il premio, e dà un diritto di giustizia alla ricompensa. Il merito è «de congruo», o di convenienza, quando non vi è parità fra il servizio reso e la ricompensa. Noi meritiamo il Paradiso «de condigno» solo perché Dio ha promesso di compensare così le nostre buone opere: giacché Gesù Cristo, con la sua Passione e Morte, meritò «ex justitia», cioè «de condigno» la nostra salvezza.
Dio ha diritto alla nostra obbedienza, conforme alla Sua legge. A chi Lo ama e Lo serve facendo la Sua divina volontà, Dio ha promesso il premio eterno del Paradiso. Al giovane che gli chiedeva che cosa dovesse fare per avere la vita eterna Gesù rispose semplicemente: «Osserva i comandamenti». Dio non può ammettere in Paradiso, dandogli come premio la vita eterna e il Suo gaudio, colui che muore in peccato mortale, cioè privo della Sua amicizia. Se qualcuno non resterà in me, dice Gesù, sarà gettato via, come un tralcio che si dissecca, si raccoglie e si butta sul fuoco, dove brucia (Gv. XV, 6). Per meritare il Paradiso occorre vivere secondo Dio, cioè credere a ciò che Egli ha rivelato, praticare la Sua legge, con l’aiuto della Sua grazia, che si ottiene mediante i Sacramenti e l’orazione (cf. n° 27). Gesù Cristo, Uomo-Dio, come uomo sofferse la povertà, la fatica, la fame, la sete, gli strazi della passione e della morte; lavorò, faticò, pregò. Gesù Cristo con la sua parola e con il suo esempio c’insegnò a credere e a osservare la divina legge, e con la sua passione e morte ci meritò la grazia per cui possiamo credere e osservare la legge divina e vivere secondo Dio. Che cosa ci gioverebbe conquistare il mondo Intero con la nostra intelligenza o la nostra potenza, se poi non salvassimo la nostra anima? Se ci mettessimo in condizioni di non ricevere nessuna utilità dalla venuta di Nostro Signore sulla terra per essere nostro Maestro, Redentore e Mediatore?
Nostro Signore prima di cominciare la vita pubblica trascorse quaranta giorni e quaranta notti nel digiuno e nella preghiera. Prima di cominciare la passione pregò a lungo nel Getsemani. I Santi compresero bene questa lezione e, prima d’intraprendere qualche cosa d’importante, davanti alle tentazioni e ai pericoli, sempre pregarono, per avere l’aiuto indispensabile della grazia divina. È necessario onorare Dio con atti di culto esterno. Ma l’uomo, assorbito nelle occupazioni e necessità materiali, dimentica molto facilmente questo dovere. Per richiamarlo a questo dovere fondamentale Dio addirittura fissò alcuni giorni, riservandoli unicamente al culto divino...
a cura di CdP

- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «La Religione. Obiezioni e risposte» del P. Giulio Monetti, imprimatur 1942.
• «Mi dai tutta l’aria di un arretrato, che ti gingilli ancora in superstizioni, in vane sollecitudini di donnicciùole, in preoccupazioni metafisiche superate... Indugiarmi in simili malinconie? Ma neanche per sogno! Ti pare? Mi sembrerebbe di non progredire con la scienza e di farmi compatire dal mondo degli eruditi, perché uomini bene eruditi e scienziati, salvo certe convenienze esterne bene comprensibili, della religione se ne infischiano allegramente!».
• Rispondiamo. I dotti non credono? Ne sei proprio persuaso? Ed io invece te lo nego decisamente! Mi rincresce di non poterti, oggi, seguire su questo terreno magnifico, interessantissimo, per non sviarci dalla nostra presente questione. Ma sarà per un’altra volta! Quando ti faccia comodo, sono pronto a dimostrarti precisamente il contrario: e che c’è da commuoversi dinanzi allo spettacolo di fede religiosa datoci dai grandi luminari dell’umanità in ogni tempo, non escluso il nostro (cf. SOS, Scienza e fede, n°5, ediz. 3). Per ora ti basti questo predicozzo del Pasteur, il celebre padre della microbiologia moderna, da lui fatto nientemeno che agli Accademici di Francia nel suo discorso di ricevimento nel seno di quest’Assemblea scientifica: senti come ribatte proprio in pieno il pregiudizio - questo, sì, è pregiudizio! - «i dotti non credono». «Io mi domando in nome di quale nuova scoperta, o filosofica o scientifica, si possono sradicare dall’anima umana le preoccupazioni religiose. Per me, esse hanno una natura perenne, dacché il mistero che cinge tutt’attorno l’universo - del qual mistero esse sono un’emanazione - è perenne esso stesso di per se. Si racconta che l’illustre fisico inglese Faraday, nelle lezioni che teneva alla Società Reale di Londra, non pronunciava mai il nome di Dio, benché egli fosse profondamente religioso. Ma un giorno, eccezionalmente, questo nome gli uscì dalle labbra, suscitando d’improvviso nell’uditorio un movimento di simpatica approvazione. Accortosene il Faraday, interruppe la sua lezione con queste parole: “Vi ho fatto stupire adesso per avere pronunziato il nome di Dio. Non vi meravigliate se non l’ho mai pronunziato prima: non sono altro che un rappresentante della scienza sperimentale. Però sappiate che la nozione e il rispetto di Dio giungono al mio spirito per vie altrettanto sicure quanto quelle che ci conducono alle verità d’ordine fisico!”». Fin qui il Pasteur: e tu puoi ben acquietarti all’autorevole parola di questo principe degli scienziati....
• E veniamo adesso al nucleo della tua replica: vedrai che la religione non è poi superstizione o pregiudizio o preoccupazione vana, come tu pensi. Che cos’è infatti la Religione? Riconoscere in modo pieno e solenne i diritti di Dio sulla mente, sul cuore, sull’attività, sulla vita stessa dell’uomo, onorandoLo insieme nella forma a Lui conveniente ed accetta: - ringraziarLo dei perpetui ed immensi benefici; - domandarne l’aiuto; - prestarGli la servitù che richiede per cento e cento giustissimi titoli; - ricercarGli perdono delle offese fattegli, offerendogliene la soddisfazione voluta.... C’è niente di più ragionevole? Di più degno e di più doveroso, per qualsiasi uomo, fosse pure il dotto fra i dotti? Vorrei vederlo quell’uomo che osasse tacciare di sciocca superstizione l’adempimento di sì precisi doveri! Superstizione e sciocchezza l’onorare le persone come si meritano? Il ringraziare convenevolmente il proprio supremo e perpetuo Benefattore? Il servire con affettuosa diligenza il proprio Padrone? Il provvedere prudentemente ai casi propri, sia col placare l’offesa Giustizia Divina, sia col conciliarsi le larghezze della Divina Onnipotenza? Non oserei certo profferire simili proposizioni in pubblico, per timore di farmi... ricoverare con violenza pietosa in una casa di salute!
• E c’è anche qualche altra cosa in simile condotta, oltre l’irragionevolezza: c’è la più ingiuriosa temerità! Il Profeta Daniele ripeterebbe a simili insensati, che vorrebbero con la loro posa spregiudicata contro la Religione passare per evoluti, la tremenda requisitoria da lui fatta (Dan. V, 23) là, in Babilonia, al Re Baldassarre, in quel famoso convito che fu l’ultimo eccesso di quel monarca: «Tu non hai onorato quel Dio che ha in sua mano il tuo alito, tutto il tuo essere!». E Dio non voglia che si scriva anche a loro danno la stessa sentenza inesorabile: «Mane, Tecel, Fares!» - che apparve quella sera ai convitati sulla parete, e che segnò la condanna del Re di Babilonia, servo infedele di Dio! Davvero che costerebbe molto a Dio lo stringere il pugno, a stritolare l’abbietto provocatore!
• E che se ne fa Iddio dei nostri ossequi? Proseguono i detrattori: «Com’Egli è troppo in alto perché la freccia dell’empio lo possa ferire, così è troppo in alto perché possano interessarlo i nostri omaggi, i nostri ringraziamenti, le nostre scuse, le nostre suppliche.... Siamo noi altro, sulla bilancia di Dio, che “una formica nera su la lavagna nera” - come direbbe Victor Hugo - o la proverbiale “stilla di rugiada mattutina” del linguaggio biblico? E se è così, io trovo logico che, senza negare alla Religione ogni pregio e convenienza, possa alcuno scusarsi dal praticarla, come cosa di minore importanza, almeno di fronte ad altri interessi che tutta ne assorbono la attenzione e l’attività. Nel febbrile agitarsi della vita moderna, un uomo d’affari, che deve pur muoversi con la società progrediente senza posa, non ha tempo da dedicare alla cultura ed alle pratiche della Religione!».
• Rispondiamo: Nel tuo modo di vedere c’è un grosso errore di prospettiva: quello di prendere la Religione come «vantaggio» che noi rechiamo a Dio; quand’è verissimo che a Dio, infinitamente perfetto e beato in se medesimo, noi non possiamo arrecare vantaggi di sorta. Tutt’altro è il punto di vista giusto: noi dobbiamo stimare la Religione come un debito sacrosanto, inviolabile, che noi abbiamo verso Dio. Ai giorni nostri s’è molto parlato dei diritti dell’uomo, del lavoratore, del cittadino, dello Stato: viceversa poco o nulla si parla dei diritti di Dio, supremi, intangibili! Ed è proprio per questo che le cose, un po’ dappertutto, vanno male, molto male! Troppi ci sono che vogliono vivere, per dir così, a spese di Dio, senza poi renderGli ciò che Gli spetta! Proprio come diceva quel nullafacente: «Bere, mangiare, godersela e non pagare!». Francamente, il sistema sarebbe comodo per noi; ma per gli altri, chi lo troverebbe simpatico?
• Orbene: se la ragione trova tale sistema quanto mai irragionevole, ingiusto e provocatore per le nostre relazioni sociali, non c’è motivo di giudicarne altrimenti riguardo alle nostre relazioni con Dio. Dio è nostro creatore, non meno creatore di tutte le cose che ci circondano, e che ci servono di sostentamento, di aiuto e di diletto: con ciò stesso ne è Padrone assoluto, e tal Padrone che, anche se lo volesse, non potrebbe rinunziare al Suo diritto. Infatti a prò di qual persona Egli rinunzierebbe, che non Gli fosse assolutamente soggetta? E non rivivrebbe rinnovellato ad ogni istante il Suo diritto, dato che ad ogni istante noi e il mondo ricadremmo nel nulla se Dio non ci conservasse perennemente con rinnovata creazione? Per noi, per ogni creatura, la continuità del contatto con Dio è cosa indispensabile all’esistenza stessa, oltreché all’attività creata; a quel modo che cessa di botto l’energia elettrica per il movimento delle macchine o per l’accensione delle lampade, non appena sia tolta la comunicazione della lampada o delle macchine con la sorgente di forza, così ogni forza mancherebbe in noi, ogni vita, ogni sussistenza, quando Dio non più concorresse ai nostri atti, più non conservasse il nostro essere fisico.
• Ciò premesso, giustizia vuole che noi ci regoliamo in tutto e per tutto secondo il volere di Dio, il gran Padrone dell’Universo. Siamo in questo mondo come ospiti in una casa che appartiene a Dio: ci serviamo continuamente, e per vivere e per operare, di energie e di strumenti che appartengono a Dio; noi stessi siamo tutti cosa di Dio; è dunque ragionevole che noi non facciamo nulla contro i Suoi ordini. Quindi, se ci comanda qualche cosa, Gli dobbiamo obbedire, dacché tutta la nostra attività appartiene a Lui: se ci vieta questa o quell’azione, noi dobbiamo astenercene, perché i nostri sensi e le nostre facoltà, il nostro tempo e la nostra vita sono cosa di Dio, e non possiamo davvero abusarne a capriccio. Se infine ci domanda sacrificio di sostanze, di tempo, di sanità, e persino della vita - lo domandò bene ai Martiri! - non possiamo rifiutarci; non faremo che restituirGli quella vita, quella sanità, quel tempo, quelle sostanze, ch’Egli c’imprestava per Sua mera benignità!
• Per conseguenza, chi coscientemente - cioè sapendo quel che fa - nega a Dio l’ossequio religioso, cioè la riconoscenza che Gli deve come a Benefattore supremo, e la servitù che Gli conviene come a Padrone assoluto, non può non aversi per uno sleale, un usurpatore, un ribelle degno del più alto disprezzo e delle più terribili sanzioni: vero prepotente, che vuole spadroneggiare in casa altrui: vero parassita, che vuole scialare e scialacquare a spese altrui: ingrato per giunta, e della peggior specie, che giovasi dei benefici ricevuti per insultare protervamente al suo Benefattore, non fosse altro che col fingere di non conoscerlo o di non tenerne conto, di non preoccuparsene.
• Per quanto sia vero che noi, nella nostra infinitesima piccolezza, non possiamo all’Infinito Iddio né recare svantaggio né vantaggio, è assurdo che Dio sia indifferente alla nostra condotta verso di Lui, vale a dire alle nostre ribellioni od alla nostra fedeltà, al nostro disprezzo od alla nostra venerazione, e proprio mentre Egli è presente in ogni luogo; mentre perpetuamente si occupa di noi, conservandoci, cooperando ad ogni nostra azione, provvedendoci paternamente di tutto, mentre dalla mera e nativa condizione di servi ci ha elevati alla condizione di amici e di figli, protestandosi di avere le Sue delizie nel trovarsi con noi! Altro che indifferenza! Non è interesse, è vero, che Lo piega verso di noi: è tenerezza! E alla tenerezza è brutale rispondere con l’indifferenza!
a cura di CdP
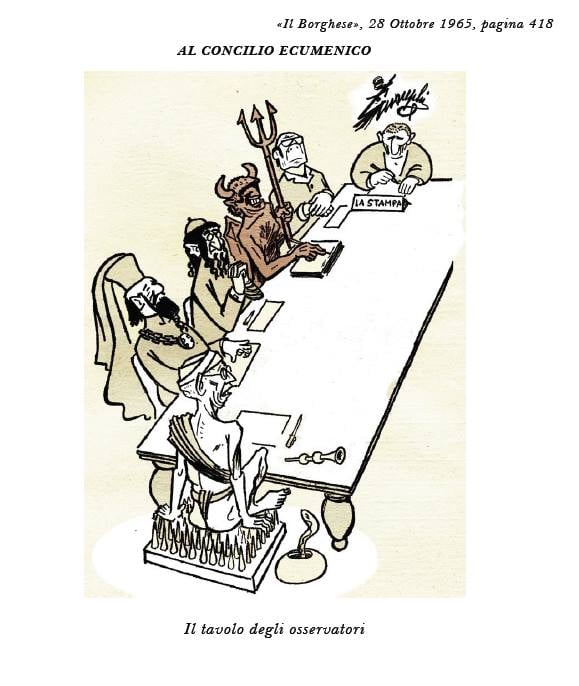
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «La Religione. Obiezioni e risposte» del P. Giulio Monetti, imprimatur 1942.
• Asserisce il nemico del vero Dio: «Rispetto tutte le opinioni, non vado a cercare quello che fanno gli altri, ammiro anche quanto c’è di bello nell’arte religiosa, mi compiaccio persino di quanto ha di simpatico, a volte, l’altrui religiosità; ma, per conto mio, non ho scrupoli religiosi, né ubbie pietiste, né preoccupazioni puritane. Quella roba lì la lascio a chi la vuole; né troverei ragionevole che, mentre io lascio che ciascuno faccia la sua strada, non mi si lasciasse fare tranquillamente la mia, con l’impormi la Religione quando non la sento... Meglio rimanere senza religione, che praticare una religione non sentita....».
• Rispondiamo: Caro amico! Non è per toglierti la tua libertà, del cui uso, non io, ma tu sei responsabile, che ti avverto del tuo grosso sbaglio: — intendo invece renderti un servizio come un altro, anzi il più prezioso di tutti i servizi, con l’avvisarti che vai fuori strada, proprio completamente. E perché? Nel tuo modo di pensare e di condurti, sei senz’altro — scusami la parola, che non ha per nulla l’intenzione di offenderti — un anormale! Lo vuoi vedere? Guarda attorno: tanto nel mondo contemporaneo, quanto nel mondo di ogni altro tempo storico, la Religione è nella pratica di tutti i popoli, anche più rozzi e degradati. E dico «nella pratica»: che non si tratta soltanto di un’affermazione speculativa, che non trascenda i termini della conoscenza: si tratta di un’affermazione che comincia, sì, con la cognizione, ma passa poi all’azione. Si svolge nell’intimo della vita individuale in timore riverente, ed in possente speranza, riguardo alla Divinità che a suo senno governa il mondo; — ispira poi nella vita sociale la varia maestà dei riti, circonda di rispetto e di servitù il ceto sacerdotale o dei ministri del culto, innalza al cielo le torri delle basiliche, i minareti delle moschee, le cupole dei santuari, le fronti storiate delle pagode, e brucia gli incensi, e sparge del sangue delle vittime l’are fumanti dei sacrifici....
• Non c’è popolo che non abbia onorato Iddio; tra i Cinesi egli era Tieng, tra gli Indiani era Brama, tra gli Assiri era Assur, tra i Caldei era Belo, tra gli Egiziani era Ammon Ra, Zeus tra gli Elleni, Giove tonante tra i Romani, tra i Germani era Thor, nelle savane e nelle foreste americane era il Grande Spirito. Dappertutto il divino si sente, come dici tu: «Si fa sentire». Il fenomeno religioso è realtà storica, universale, cosa di tutti i luoghi e di tutti i tempi, non escluso il presente. Vedi bene che anche adesso — come osserva il Balmes (Filosofia Fondamentale, III. 33) — «chiunque misconosca la Religione, od anche si provi a combatterla, l’incontra all’entrata e all’uscita delle vie misteriose dell’esistenza; essa è là, alla culla del bimbo; ed è ancora là sotto i portici della morte, tra le arcate del cimitero e tra i suoi tumuli; essa domina il tempo e illumina l’eternità; risponde con divina parola ai semplici che l’interrogano sui veri fondamentali; ascolta impassibile le divagazioni dell’ignoranza e le bestemmie dell’empietà; e resta in attesa tranquilla e sicura che il corso dei secoli venga a rivendicare le ragioni di Colui che, prima ancor d’ogni secolo, già era la Ragione stessa».
• E deve essere così! «L’umanità ha bisogno di sapere da dove ella venga, dove ella vada, e che cosa ci stia a fare in questo mondo... L’umana coscienza — che non sia già fuori della normalità — non può quietare innanzi a siffatti misteri: sente che il penetrare simili enigmi è cosa del suo più alto interesse: vi è legata la sua sicurezza, la sua felicità! Disinteressarsene sarebbe un tarpare le ali alla propria intelligenza, condannandola a radere basso basso la terra, senza volate, senza slancio, senza larghi orizzonti... senza risorse allo spirito per i momenti difficili». (Poulin, La Religion, XXVII), soprattutto in faccia alla morte, all’al di là.
• È vero: il fenomeno religioso ci è mostrato e dall’etnografia e dalla storia, ora più spiccato ora meno; ora misto ad errori palmari, a grossolane superstizioni, fors’anche a crudeli costumi, ora più scevro d’aberrazioni. Soprattutto stupisce il vedere che, mentre la religione è in pacifico possesso pressoché in lutti i regni, che ne hanno fatta come una istituzione nazionale, essa al contrario vive in una perpetua atmosfera di lotta quando si mostra sotto la forma vera: la Religione cattolica. Tuttavia queste dissomiglianze non tolgono nulla all’università del fenomeno stesso, universalità che ben dimostra come esso sia affatto consentaneo alla ragione in se medesimo, ed imperiosa voce della natura, per chiunque sia normale.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «Brevi risposte a varie difficoltà», G. Monetti, imprimatur 1944. • Dall’inferno non si esce più? — Ci sarà il Giudizio Universale: — tutti gli adulti (tutte le persone vive o morte in età di ragione, ndR) vi prenderanno parte insieme: — tra questi adulti i dannati saranno moltissimi, né potranno andare al Giudizio senza lasciare l’Inferno: — come dunque si può dire che chi cade nell’inferno non ne esce più?
Rispondiamo — Distinguiamo bene tra Inferno e Inferno... — C’è l’Inferno «materiale», cioè la prigione infernale, il luogo di reclusione dei dannati — supponiamo un qualche cosa di simile all’Inferno Dantesco, sebbene immensamente più orribile —; e c’è l’Inferno «personale» immanente al dannato, cioè il suo «stato di pena» integrato dalla pena del danno e dalla pena del senso. In ordine al dogma dell’eternità delle pene (questa e non altro significa la frase obbiettata: «Dall’inferno non si esce più»), quello che più conta è la perpetua eternità dell’Inferno immanente, che il dannato si porta con sé ovunque egli vada; sia che, per ordine di Dio, venga trascinato al Giudizio Universale, come accadrà di tutti i dannati nel giorno della finale risurrezione; sia che, per disposizione o permissione divina appaia ed operi in questo mondo, com’è dei diavoli, dei quali si legge che «ad perditionem animarum pervagantur in mundo», cioè ne va piena la terra a prova della nostra virtù, ad esercizio della nostra pazienza, talora a castigo della nostra temerità.
Quanto al luogo, invece, esso è cosa soltanto secondaria, accidentale; la dannazione non è punto sostanzialmente costituita dal trovarsi o non trovarsi il dannato confinato in quello. — Proprio come accade del Paradiso — anch’esso, come la dannazione, eterno in quanto non avrà più interruzione. — Per i suoi felicissimi possessori, esso consiste sostanzialmente nella vista di Dio immediata, nella partecipazione alla beatitudine stessa di Lui, dunque nel conseguente sconfinato possesso di ogni bene, giusta la personale e soprannaturale capacità del beato. Solo accidentalmente per Paradiso si significa il luogo speciale da Dio singolarmente destinato a manifestarvi la Sua divina magnificenza nella glorificazione degli eletti. — Perciò il Divino Agonizzante Gesù Crocifisso ben poté promettere per quella stessa sera il Paradiso al ladrone convertito, dicendogli esplicitamente: — «Hodie mecum eris m Paradiso!» — sebbene soltanto dopo quarantadue giorni dovesse aver luogo l’Ascensione di Gesù Cristo risorto al Cielo, e quindi l’entrata effettiva di quel predestinato e degli altri Santi dell’Antico Testamento a quel luogo particolare della beatitudine (fino a quel giorno le anime dei giusti abitavano il Seno di Abramo o Limbo dei Padri, ndR).
Del resto ciò derivasi dalla natura stessa delle cose. In che consiste la beatitudine? Nella vista immediata e svelata di Dio, e nel pieno possesso di Lui. Ora Iddio è in ogni luogo, e in ogni luogo può mostrarsi glorioso al beato ed ammetterlo alle gioie tutte proprie delle ineffabili tenerezze dell’amor suo, cioè «imparadisarlo» di Sé. L’ubicazione dell’eletto non c’entra per nulla. — La Beatrice Dantesca, l’Angelo che spalanca all’Alighieri con la sua verghetta le porte di Dite, erano beati, in pieno Paradiso; tal Paradiso, cioè la pienezza della loro rispettiva felicità, e l’uno e l’altra se la portarono sin nell’Inferno, ove accidentalmente discesero in soccorso del Poeta pericolante. Dappertutto l’eletto è insieme col suo Dio; dappertutto Dio e il beato spirito si trovano insieme congiunti intellettualmente, e a vicenda si contemplano, si amano, si possiedono; questa è la beatitudine! Il nostro Alighieri la diceva: «Luce intellettual piena di amore; Amor di vero Ben, pien di letizia; Letizia che trascende ogni dolzore!».
Tutto il resto, di per sé non è propriamente il Paradiso, sebbene possa appartenere esclusivamente al Paradiso. Pensiamo alle bellezze, alle delizie dell’Eden: per quanto fossero grandi, sconfinate, scevre di ogni mala mistura di noie, timori, privazioni, rimorsi, ecc..., non costituivano davvero il Paradiso di Beatitudine, ma soltanto il Paradiso «terrestre»; tanto terrestre che vi poté entrare il diavolo a farvi il suo triste mestiere di ingannare l’uomo, di farlo prevaricare, e così ucciderlo spiritualmente, quanto alla vita soprannaturale della grazia. E i nostri progenitori erano ancora là quando sentirono in sé il pungolo del rimorso implacabile della coscienza, e le ribellioni umilianti del fomite vizioso, e gli arcani timori della Divina Giustizia...
Ma torniamo ai dannati. — In che sta propriamente per essi l’Inferno? Nella privazione della vista di Dio, alla quale sempre spasmodicamente aneleranno, come a proprio ultimo fine, pur sempre da quella inesorabilmente reietti... — E ne consegue l’angoscia immensa dell’anima per tanta jattura, e il cruccio disperato nel capire chiarissimamente, inequivocabilmente, che tanta perdita sarà irrimediabile, assolutamente eterna, e la vergogna di sé e il rimorso del doversi personalmente chiamare in colpa della perdita immane, irreparabile, pienamente volontaria. E tutto questo è privazione personale, e coscienza che non dipende per nulla dal luogo ove il dannato si trovi, ma gli è immanente, ovunque egli vada o rimanga... Ma il fuoco, e gli altri positivi tormenti del senso? Neanche questi sono legati a un’ubicazione determinata, sebbene sia vero che più particolarmente si infliggono ai dannati nel carcere infernale. Iddio non ha bisogno della materiale particolarità di luogo per infliggere tali pene. — La loro fiamma è immanente a quelle faci (ardenti e vive) che sono i dannati, investite dagli ardori delle divine vendette!
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «Brevi risposte a varie difficoltà», G. Monetti, imprimatur 1944.
• — Dolore! Breve parola: ma quanto comprensiva! Essa comprende, nell’ampiezza del suo significato, tutto ciò che può affliggere l’uomo: disagi, malattie, privazioni, disdette, incertezze angosciose, intime pene dell’animo, lugubri separazioni; insomma tutto ciò che, ruvido come la rocca dell’alpe, pungente come la spina della boscaglia, insanguina l’uomo sul sentiero della vita. E il dolore si perpetua con la vita umana; vagisce e lacrima il neonato, come lacrima ed ansima agonizzante il moribondo. Ora, come conciliare tutto questo con l’infinita bontà di Dio, con la sua potenza, sapienza, giustizia e provvidenza? Come conciliarlo anche con la dignità dell’uomo, e con le esigenze della sua propria natura? Che l’uomo colpito dal dolore è come l’albero colpito dal fulmine, o come nave che piega sul fianco trabalzata dalla tempesta!... Eppure l’uomo non è fatto per il dolore, ma per la felicità, che è luce serena, vita radiosa, gioia perfetta. Com’è, dunque, che il dolore regna tra noi?
• Confessiamo subito che il problema del dolore umano è, tra i problemi, quello che forse ha più affaticato a risolverlo gli umani ingegni; e che, fuori del Cristianesimo, non trovò soluzione soddisfacente: soluzione, cioè, che insieme persuadesse e consolasse il cuore e riasciugasse le lacrime. La Chiesa invece ci riuscì: proiettò sulle tristi caligini del dolore i raggi possenti della sua dottrina; e il dolore fu spiegato, consolato, nobilitato, consacrato, diremmo quasi divinizzato. Chi riesca a persuadere chi soffre, che il suo dolore, se si risalga alle ultime cause, non è capriccio crudele di chi si piaccia del penare altrui, come non è neanche un duro colpo menato alla cieca da non so quale arcana potenza irresponsabile, che qua percuote senza ragione, come là senza ragione prospera ed esalta. Chi possa mostrargli, per entro la scorza amara del dolore, il dolce seme e salutifero ch’essa racchiude, colui ha già fatto molto per temperare all’afflitto l’acerbità della pena, quando pur non riesca a racconsolarlo del tutto. Non è vero che la rassegnazione piena al patire è già un gran balsamo al cuore esulcerato? Ebbene la Chiesa spiega il dolore, e lo fa accettare ai suoi fedeli con pace rassegnata. Innanzi tutto essa avverte l’afflitto che non è ragionevole il pretendere da Dio che in suo favore sconvolga o sospenda prodigiosamente il corso spontaneo della natura, secondo il quale il dolore fisico è ordinato ad ammonirci di ciò che ci è necessario (per esempio la fame ci eccita alla ricerca del cibo), e, viceversa, di ciò che non ci conviene (per questo la sua presenza ci dà della pena, eccitandoci ad eliminarlo od allontanarlo da noi).
• Secondo la sua natura, l’uomo ha corpo corruttibile, soggetto ai dolori di una graduale dissoluzione; ha altresì le sue passioni, soggette al libero arbitrio, e versatili tanto al bene quanto al male; libertà e passioni, che, stante l’ingenita corruzione operata in noi dal peccato originale, sono fonte di dolori sopra dolori. Ecco una prima spiegazione del dolore. Di più la Chiesa mostra l’opportunità del dolore. Essa ricorda che ogni colpa esige la sua pena: e l’uomo è colpevole tanto! Ricorda che l’energia delle passioni è energia selvaggia, buona in sé, ma facile al trasmodare; quindi la necessità del freno e della ronca che ne stralci i soverchi germogli; il che non si fa senza dolore o coazione penosa.
• Ricorda ancora che, come nel corpo, così nell’animo, spesso fanno presa i mali germi, e l’infarciano di umore maligno; quindi ad impedire la corruzione ci vuole il taglio doloroso del chirurgo: e il chirurgo dell’anima è, appunto, il dolore. Con ciò essa mostra nel dolore una via sbrigativa per pagare i proprii debiti con Dio, per migliorare se stesso, per guarire delle proprie infermità; e non è questo un confortare efficacemente colui che è in preda dell’amarezza?
• Ma ciò non le basta: la Chiesa nobilita il dolore! Di fatto ci mostra in esso come lo strumento di un’arte tutta sovrumana, e come una scala che si erge sublime alla vera grandezza. Certo tra le grandezze umane non c’è altra che sia superiore a quella della virtù, od anche l’adegui; — tra le virtù poi — a parità di altre condizioni — più giganteggia quella che ha più dell’arduo. L’eroismo è come l’apogeo della vera grandezza; ma non c’è eroismo se non di fronte a straordinaria difficoltà. Laonde dire eroismo è dire sacrificio affrontato per un ideale superiore, e costanza serena di fronte all’impeto del dolore. Perciò la Chiesa ci addita il dolore come strumento di virtù efficacissimo, il quale corregge l’uomo, lo fa rientrare in sé, lo inizia al timore santo di Dio, principio della sapienza. Ed è appunto per mezzo del dolore, che, come per mezzo di una scala gigante, ascesero grado grado i Martiri alla loro altezza sublime; — esso è che educava alla Chiesa quella progenie di più veri eroi che è la moltitudine sterminata dei Santi.
• Travagliati dal dolore come masso marmoreo dallo scalpello, quei servi fedeli di Dio vennero man mano assumendo forme spirituali ogni ora più leggiadre, più rispondenti al divino ideale; ed è così che adeguarono un giorno il disegno di Dio, sorridendoci ora dal Cielo, fulgidi di soprannaturale bellezza e perfezione. Poteva farsi di più per la riabilitazione del dolore, per giustificarne la presenza del mondo? Eppure la Chiesa passò ben oltre! Essa circondò il dolore di un nimbo divino, portandolo all’apoteosi. Basta entrare in qualsiasi tempio cristiano, dalle sontuose cattedrali alla più umile cappelletta delle nostre campagne; basta guardarvi l’altare per vedervi inalberata la Croce; e su quella Croce a- doriamo confitto l’Uomo-Dio, che ci mostra nelle sue piaghe, nelle ferite, nel sangue sparso, tutta una storia di dolore, ch’è in pari tempo divina storia di amore. A tal vista l’uomo, che prima rifuggiva per istinto dalla sofferenza, ora la guarda e vi s’affisa estatico, e vi s’intenerisce sino alle lacrime, e s’accende di brama di emulare nel sacrificio quell’amore che Gesù sospinse sino alla morte. — Ciò spiega come l’umanità, meravigliata, assista tutto giorno all’eroismo spontaneo e sorridente di cento e cento giovani che sacrificano divertimenti, famiglia e patria per darsi alle fatiche dell’apostolato nelle missioni; — di cento e cento fiori che, rinunciando alla loro parte d’aria, di sole, di profumate rugiade, si rinchiudono per sempre negli ospedali, nei ricoveri, nelle scuole del popolo, negli asili infantili! E, poggiando tuttora più in alto, si capisce altresì come certi spiriti più intimamente e più perfettamente cristiani, in contemplare amando, e in amare contemplando Gesù Crocifisso, siano giunti a fare del dolore il loro programma, il loro ideale, il loro sogno, la loro vita, finché dovevano rimanersi quaggiù!
• Parlo di un San Paolo, che misticamente si affermava confitto in Croce col suo Gesù dolorante: di un San Giovanni della Croce che domandava a Gesù, come caro premio del suo amore a lui, alle sue fatiche per lui, nient’altro che «pati et contemni pro Te!»: — di una Santa Teresa di Avila, che al divino suo Sposo Crocifisso domandava di patire per lui o di morire — «aut pati aut mori!» — come se senza dolore per il suo Dio già la vita le trascorresse insipida, insignificante, indegna di viverla: — di una Santa Maria Maddalena dei Pazzi, la quale, più ardita ancora esclamava e pregava: — «Non mori, sed pati!» — Morta non potrei più patire per il mio Signore: che perciò mi si prolunghi la vita, per tener compagnia con le mie sofferenze per lui a Gesù agonizzante! Ecco sino a qual punto di morale grandezza sa elevare il dolore un’anima ben istruita nella fede cristiana, e bene sperimentata nelle vie di Dio: beati noi se, fatta tacere in noi la nostra ipersensibilità, imparassimo sul serio, e mettessimo poi in pratica generosa queste lezioni della scienza dei Santi! Quanto diversa non ci trascorrerebbe la vita!
• Replicano i detrattori: Sì! Ma intanto come riuscire a vincere l’affanno che opprime l’anima, quando si soffrono tante pene? — Si dirà: — «Con la reazione energica, risoluta!». Ma tale reazione violenta non ne susciterà un’altra più violenta ancora, capace di darci maggior pena che mai? Rispondiamo: Parliamo in primo luogo un po’ empiricamente. Sappiamo, per esperienza, che certe cose ci affliggono solo quando vi pensiamo, e in proporzione del pensiero che noi concediamo loro. — Se è così, santificata una volta la nostra pena con una bella e generosa offerta di essa a Dio, per la sua maggior gloria, per la salute dell’anima nostra, per la conversione dei peccatori, per l’espiazione dei nostri peccati, per l’impetrazione efficace di grazie speciali, cerchiamo poi subito di non pensarci più, di distrarcene, dimenticarcene... Per questo procuriamo di occuparci tosto in qualche cosa d’importante, che richieda tutta la nostra attenzione... Ecco un rimedio relativamente efficace, facile, e ragionevole; — se, pensando al nostro male, potessimo rimediarvi senz’altro, allora avrebbe il suo perché il fermarci a cercargli in ciò il conveniente riparo: ma quando proprio non ci si può far niente, né le cose per il nostro immalinconirci non mutano, a che prò stare lì a farcene cattivo sangue? Pensiamo piuttosto che la vita è breve; e che c’è ben meglio da fare che sprecarla in malinconie inutili e in dannose tetraggini sfibranti.
• E persuadiamocene pure, che è vero: gran parte dei nostri mali siamo noi stessi a fabbricarceli scioccamente; e così pure gran parte dell’intensità delle nostre pene è dovuta semplicemente alla nostra insipienza! E quanto di santa avvedutezza non c’è mai in quel tanto noto proverbio: «Fare di necessità virtù»! Ma ora, volendo parlare scientificamente, sempre ispirandoci alla Fede cristiana, domandiamoci: Che cosa ci dice la scienza teologica riguardo al dolore? — Ci dice che esso è permesso e predisposto da Dio per i suoi altissimi fini: stanteché è certo, e razionalmente e cristianamente, che «non muove foglia che Dio non voglia»! — La Fede però aggiunge che gli altissimi fini di Dio riguardo al nostro patire sono anche fini di nostro incalcolabile vantaggio, se noi amiamo il Signore: — «Diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum!» — Facciamo dunque di essere sempre in grazia di Dio, e di prendere sempre dalla mano di lui virtuosamente quel male, qualunque siasi, che noi soffriamo:, — ed ecco che esso subito diverrà un bene per noi: — e che bene!
• Bene di liberazione da durissime espiazioni delle quali siamo in debito alla Divina Giustizia per i nostri peccati; quelle ci saranno da Dio commutate nel presente dolore, relativamente lievissimo... Bene di accrescimento di grazia santificante, ossia di soprannaturale bellezza e forza, che ci renderà sempre meglio ammirabili e simpatici agli occhi dei celesti, e più caro oggetto di loro protezioni e favori. Bene di tesori incomparabili che ne veniamo acquistando quasi senza pur avvedercene: dacché ogni nostro atto virtuoso, se noi siamo in grazia di Dio, ci vale almeno un merito di più, cioè un grado di grazia di più nella vita presente, e nell’altra vita un corrispondente Paradiso di più... che è una eternità di felicità incomparabile, trascendente ogni naturale immaginabile felicità; e ciò per ogni momento di nostra pena, cioè per un’inezia fuggitiva! Vogliamo capirlo anche meglio? Facciamo un po’ un’ipotesi, che ha del bambinesco, ma è pur tanto e tanto suggestiva. — Supponiamo che ci si faccia l’offerta di un’eredità — da percepirsi immediatamente — di parecchi milioni, con palazzi meravigliosi, e ville, e parchi, e castelli, l’uno più bello dell’altro, alla sola condizione di sopportare un solo colpo di frusta, ma di quelli ben secchi, ben dati... — Chi sarebbe tanto stupido da rifiutarsi, per paura del dolore momentaneo della frustata? — Appena soffertolo, non lo si avvertirebbe neanche più, e intanto sarebbero nostri e i castelli, e le ville, e i parchi, e i palazzi, e i milioni...
• Ebbene quell’ipotetica offerta, e in modo immensamente più vantaggioso per noi, ci viene fatta ad ogni momento dalla Divina Bontà, quando ci dà a patire qualche cosa: — e consiste in un nuovo Paradiso di più, eterno, incomparabilmente bello, ricco e felice per ogni attimo di pena!... Ma, se è così, ben vengano a cento, a mille, queste pene! — Tanti Paradisi di più, da godere per sempre nell’altra vita! E perché pensare solo a noi stessi?
• Pensiamo anche un poco a tanti nostri fratelli o peccatori, od infedeli addirittura, che stanno sull’orlo dell’inferno, in pericolo di precipitarvi per sempre, ad ogni istante che passa... Se lo vogliamo possiamo coi nostri patimenti, offerti a Dio per la loro eterna salute, ottenere a loro le grazie di conversione, onde tanto abbisognano! — Perché non farlo? Perché non muoverci, quando ci costa tanto poco, a un salvataggio tanto insigne di anime in procinto di eterna dannazione? — Perché non crearci in Paradiso una magnifica Corte Regale, una famiglia spirituale di noi tenerissima, un vivente trofeo di conquista — gloriosissimo a noi — risultante di tutte queste anime da noi così salvate con l’apostolato del patimento, del sacrificio, della rassegnazione cristiana? Ah! Solo che avessimo un po’ di fede, e un po’ di generoso coraggio, benediremmo il Signore dei nostri dolori, esclamando col Serafico d’Assisi: «Tant’è grande il ben che aspetto — che ogni pena m’è diletto!». — E d’incanto la vita ce ne tornerebbe rasserenata spiritualmente, per quanto materialmente fosca per privazioni, traversie e dolori, ed agitata dalle più violente sfortune!
• Del resto, ci sarebbe poi tanto da meravigliarci che la vita presente sia dura, e tanto tribolata da patimenti d’ogni maniera? — Certo non possiamo aspettarcene altro, dato che essa è veramente per noi un esilio, un luogo di prova, un campo di battaglia, una giornata di faticoso lavoro. Altrove, non qui, dobbiamo ravvisare la patria nostra, dove ci si riserba il premio delle nostre fatiche, la dolcezza del perenne riposo, l’ebbrezza del trionfo definitivo: — qui abbiamo soltanto la grande vigilia, nella quale dobbiamo, — nel fedele servizio di Dio — prepararci noi stessi, travagliando come e quanto vorrà il Signore, la bella festa dell’eternità. Peraltro facciamoci animo: quando quella festa sia venuta, non ci parranno che un’inezia affatto insignificante i travagli, le pene e le fatiche che avremo dovuto durare per assicurarcela! — E ringrazieremo allora il Signore, a mani giunte, di avercela disseminata di ostacoli, non già per il gusto di vederci cadere, ma perché, sormontandoli noi vittoriosamente — con l’aiuto che Egli non ci nega mai — ce ne facessimo come altrettanti gradini per salire più in alto e nella virtù, e nel merito, e conseguentemente nella gloria celeste!
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «Brevi risposte a varie difficoltà», G. Monetti, imprimatur 1944.
Battibecco, in treno, tra un operaio «cosciente» e un Cappellano Militare. Afferma l’operaio: Scusi, Reverendo! È inutile che tocchi questo tasto della Pasqua; per me, Chiesa, fede, religione, non contano nulla! Sono OPPIO DEL POPOLO! Replica il Cappellano: Davvero? Te ne sei proprio convinto tu, o te l’ha inculcata qualcuno questa convinzione? Risponde: Eh non c’è bisogno di questo; mi basta ragionare da me! Replica il Cappellano: Oh guarda! Senza studiare tanto, saresti arrivato a una scoperta che io non ho ancora saputo fare dopo tanti e tanti anni di studio... Che bell’ingegno! Ma, vediamo: sai cos’è l’oppio? Ebbene ti dico io che cos’è l’oppio: è un estratto di papavero che ha la proprietà di efficace stupefacente. — Ma intanto, vedi un po’: tu fai dipendere l’irreligiosità tua, e quindi l’orientamento sostanziale di tutta la tua vita, da una parola, di cui finora ignoravi il significato! — Convieni che, per un operaio cosciente, come sei tu, questo è un po’ poco... Di più mi mostra ad evidenza che quel pensiero che la religione sarebbe l’«oppio del popolo» non è stato pensiero tuo, in principio, ma te l’hanno imprestato altri... Prosegue l’operaio: Che hanno tutte le ragioni di dire così; tanto è il male che la religione fa alla povera gente! Risponde il Cappellano: Povero amico mio! Ti hanno bene sconvolto la testa, va! E si vede una volta di più che non sai neanche tu quello che dici, quando ripeti come un pappagallo quella frase cretina che «la religione è l’oppio del popolo»! E questo anche dopo che ti ho detto che cos’è l’oppio... Sai l’effetto dell’oppio? Quello di addormentare l’individuo, togliendogli la sensazione dei mali presenti. Sicché dire che la religione è l’oppio del popolo, significherebbe in fondo in fondo che la religione addormenta il popolo, sicché non senta più i mali che lo colpiscono. E sarebbe poi questo un gran danno, un torto fatto al lavoratore, al proletario, tanto da mettergli in mala vista la religione? Se dovessi andare all’ospedale — che Dio te ne liberi! — per una lunga e tormentosa operazione chirurgica, rifiuteresti il narcotico che ti addormentasse sicché non sentissi più i tagli?
(Oh no! In questo caso il sonno sarebbe una buona cosa, e buon rimedio il narcotico che lo procurasse) — Ebbene la Religione fa un po’ come il narcotico: ci lenisce i dolori, d’altronde inevitabili, per mezzo della rassegnazione cristiana. Tra le due, non è meglio una vita di tranquilla pazienza rassegnata, che non una vita di rabbia perpetua, quale è la vostra? (Dunque, almeno m questo, è giusto dire che la religione è l’oppio del popolo: vero?) — Non nel senso vostro però, in quanto ne fate un rimprovero alla Religione, mentre dovreste lodarnela! Ma poi ci sono troppi altri spropositi in quella frase da incoscienti! E sono madornali! Vedi, per esempio: — l’oppio agisce soltanto per alcune ore: invece la Religione, se lo vogliamo, influisce perennemente su tutta la vita, disacerbandola, consolandola, normalizzandola! L’oppio addormenta, sì, ma prostra l’organismo: la Religione invece, pur diminuendoci il cruccio delle pene, ci tonifica la vita, dandoci forza di reagire salutarmente contro di esse, e di trarne guadagni! L’uso dell’oppio ubriaca ed abbrutisce, come tutti gli stupefacenti: la Religione, al contrario, nobilita chi sa praticarla e sa viverla! — Se fossi più istruito conosceresti i Santi nella loro grandezza, i grandi Maestri del Cristianesimo nella loro sapienza, i grandi Artisti Cattolici nella loro ispirazione... Tutto frutto della Religione che ne sublimava oltremodo la mente, il cuore, le opere!... E poi che significa quella frase: «La religione è l’oppio del popolo»? Quasi che sia soltanto il popolo, il ceto in cui la religione possa accreditarsi? Tutt’altro! Basta aprire gli occhi per vedere quanta gente rispettabile, e per censo e per cultura e per dignità e per meriti insigni, professi e pratichi la Religione e la insegni agli altri, senza paura alcuna di smentite, di confutazioni, di incorrere la taccia di gente senza cervello. Tutti stupidi quei signori? Tutta gente che ha proprio bisogno di venire da voi per imparare a ragionare, a vedere come stanno le cose, a ben orientarsi nella loro coscienza e nella loro vita? — Un po’ di modestia e di buon senso, mio caro! E questo buon senso e questa modestia vi mostrerebbero, ancora, che la Religione non solo differisce profondamente dall’oppio, anche figuratamente, ma ne è anzi l’opposto; sicché il dirla — nel senso vostro — «oppio del popolo» è la frase più sciocca che si potesse inventare...
(Oh questo poi, forse è esagerato!) — Stammi attento, e ti farò toccare con mano che non esagero. Ti ho detto, dunque, che l’oppio addormenta... Ne segue che, se la Religione fosse veramente l’oppio del Popolo, quanti praticano la Religione ne sarebbero senz’altro addormentati, e profondamente... Ora, chi dorme non piglia pesci! — Viceversa la Religione Cattolica — dato che di quella specialmente si tratta — mostrò e mostra tale meravigliosa attività che è proprio agli antipodi dell’inerzia degli addormentati. Attività conquistatrice nelle Missioni degli Infedeli, attività civilizzatrice tra i Barbari, attività consolatrice e ristoratrice nei più ampi e spaventosi teatri delle miserie umane, attività illuminatrice nei mille e mille Centri di educazione — anche Superiori — onde ha il primato nel mondo; attività vittoriosa contro tutte le violenze, frodi, perfidie, malignità, aberrazioni umane d’ogni genere, accatastatele sulla strada, a modo di barricata ... Chi oserà dire sul serio altrettanti addormentati gli Apostoli, i Martiri, i grandi benefattori del popolo, un San Leone Magno, un San Benedetto, un San Francesco d’Assisi, un Sant’Ignazio di Loyola, un San Vincenzo dei Paoli, un San Giovanni Bosco, un San Francesco Saverio, un San Giuseppe Cottolengo, un San Roberto Bellarmino, un Dante Alighieri, un Michelangelo, un Palestrina, un Raffaello, Papi meravigliosi come Pio IX, Leone XIII, Pio X, Benedetto XV, Pio XI, Pio XII. Se questa è gente che dorme, chi dunque veglia in questo grande dormitorio del mondo? I comunisti forse, che, nel loro nichilismo del vero, del buono, del bello, vorrebbero mutarlo in un cimitero immenso, popolato, non già da semplici addormentati, ma da cadaveri? Inoltre, chi dorme non fa paura! — E invece paura matta fa ai comunisti e a tutta la setta dei cattivi, la Chiesa Cattolica; non per nulla tutte le armi si affilano contro di lei, tutte le macchine contro di lei si rizzano, contro di lei ancora, disperatamente, si rinnovano tutti gli sforzi le tante volte tornati inutili. Lo disse persino il Lenin che, sparito di mezzo tutto il resto, si sarebbero un giorno trovate di fronte, per la lotta suprema, soltanto più Roma e Mosca... E tutte le previsioni, anche semplicemente umane, credilo pure, sono per il trionfo di Roma sopra di Mosca... Roma ha già vinto e stravinto in ben più altre battaglie e ben più ardue!... Tutti addormentati così formidabili prodi? Gli addormentati, sai dove sono? Sai dov’è il vero oppio del popolo? Nei campi di quel vostro materialismo che vi chiude gli occhi, sicché non vediate i veri vostri beni e i veri vostri benefattori, la vera strada della vostra eterna salute e della vera vostra pace anche temporale! Quello sì, ch’è l’oppio fatale che vi snerva, sicché non sappiate fare più nulla di bene, capaci solo a distruggere: — quello è l’oppio che vi ubriaca tanto delle cose materiali e sensibili, sicché non pensiate più ai beni superiori dello spirito: — quello è l’oppio che vi imbestia in modo da darvi l’istinto delle belve feroci, istinto di sangue, di strage, di rabbia, di morte! Quello è l’oppio che vi rovina per il tempo e per l’eternità: — per il tempo in cui vi toglie la pace: l’eternità, che sarà l’eternità disperata dei nemici di Dio, quali voi vi professate... Pensaci, povero amico, finché ne sei in tempo: — non credere all’odio del nichilista: credi all’amore del Ministro di Dio morto in Croce per te, e, per quanto gli si faccia contro, Dominatore del mondo.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «Brevi risposte a varie difficoltà», G. Monetti, imprimatur 1944.
Dicono i detrattori e finti propugnatori della libertà di espressione: «Tutta la Chiesa celebra la festa di Maria Immacolata come una delle principali solennità dell’anno né ho di che contestare. Però non so liberarmi da questo pensiero insinuante che mi tormenta, eccolo. La Madonna è santissima: però, se fu concepita e nacque immacolata, perciò senza fomite di peccato, non fu suo merito se in lei non si riscontrò mai neo di colpa! Perché dunque onorarla tanto per cosa in cui essa non c’entra affatto, né con uno sforzo qualsiasi, né con un atto personale vittorioso, conquistatore?». Rispondiamo: Certo la Madonna non ebbe alcun merito nell’essere stata concepita senza peccato, essendo ciò un puro privilegio della divina grazia; — è certo altresì che la sua Immacolata Concezione le valse l’altro privilegio d’andare immune perfettamente dal fomite della concupiscenza, conseguenza di quello. — Del pari è certo che quel cumulo incalcolabile di grazie, onde fu insignita nel primo suo istante — già superiore a quanto mai ebbero od avranno tutti gli Angeli e Santi insieme — fu anche esso per Lei privilegio, non merito. Ma che perciò? E quindi? — Quando si tratta di persone di grado ed a noi care, noi facciamo festa, e giustamente, non soltanto per quello che è frutto di loro forza e sagacia, onorandone così il merito; ma festeggiamo altresì ogni loro fortuna, quale il riacquisto della sanità, il felice compimento di un loro desiderio, il giorno del oro onomastico, il loro compleanno ... E perché mai, dunque, non festeggiare la bellezza Immacolata di Maria Santissima, alla quale inneggia perennemente tutto il Paradiso? — Siamo i beneficati di Maria SS., siamo suoi figli; perché non godere dei suoi privilegi, far festa nostra ciò che è una festa per Lei? — Il volerle bene non importa forse questo? — E che altro sarebbe la simpatia per Lei? Tuttavia subito dopo quelle prime, del tutto gratuite, effusioni della grazia divina in Lei, cominciarono per Lei meriti incalcolabili, cui ella vanno man mano accumulando, mercé la sua «libera corrispondenza» alla grazia ricevuta. Per tale corrispondenza, essa si confermò sempre meglio sia nell’innocenza sia nella santità, che — in rigore di termini — anch’essa poteva perdere, nonostante fosse immacolata e senza fomite, come di fatto le avevano perdute Adamo ed Eva, innocenti anch’essi e senza concupiscenza. Diremo dunque che Maria Santissima non ebbe il merito d’interne vittorie, perché lotte interne mai non ebbe a sostenere: ebbe, invece, il merito immenso di sempre ulteriore volontaria ascesa nella santità per il continuo suo operare virtuoso. Né è da credere che il mancarle il merito della lotta interna sia un’ombra per lei: tutt’altro. Infatti ciò si riduce al non esservi mai stato in lei alcun disordine, neanche involontario, neanche passeggero; il che è somma lode, non biasimo. — Anche in questo il suo Divin Figliuolo Gesù la volle a sé somigliante! Né il merito si desume propriamente dall’entità di ostacoli superati, ma dall’intensità dell’atto di volontà che li superava; oltreché dallo stato di grazia e dagli aiuti soprannaturali che vivificarono soprannaturalmente tale atto. Orbene l’intensità di quell’atto, — com’è provocata dalla presenza degli ostacoli a modo di reazione contro di essi, — così può aversi, e ben più perfettamente, dall’intensità dell’abito virtuoso onde emana quell’atto, com’anche semplicemente dalla libera volontà, che, cooperando alla grazia, vi pone tutta la sua energia. Dobbiamo anzi notare che, anche dove sussiste la concupiscenza, lo sforzo nel compiere il bene va progressivamente facendosi meno necessario — per essere le contrarie passioni sempre meglio domate, — mentre l’intensità degli atti (e conseguentemente il loro merito) va crescendo in proporzione del progressivo rafforzarsi degli abiti virtuosi, della maggiore perfezione istrinseca agli atti e della maggiore grazia che li impreziosisce al divino cospetto. E così, quant’uno è più santo, tanto meno — normalmente e a parità di altre condizioni — ha da combattere contro se stesso; — viceversa egli merita assai più che non gli imperfetti ancora immortificati. Infatti, parte delle costoro energie virtuose deve ancora consumarsi in affrontare gli ostacoli — le tre fiere dantesche — ond’è loro conteso il bel salire «al dilettoso monte» della santità; il santo invece, già domate le dette fiere, attua tutte le sue energie nell’oggetto dell’atto virtuoso, aderendo pienamente ad esso ...
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «Brevi risposte a varie difficoltà», G. Monetti, imprimatur 1944.
Dicono gli avversarii: Come mai nella Bibbia agli ebrei era imposto, o almeno concesso, di odiare i nemici? Infatti nel Vangelo stesso si legge (Matt. V, 43): «Avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico». Rispondiamo: Osserviamo prima di tutto che il comando «Odia il tuo nemico» non si trova in nessun luogo della Scrittura. Che anzi, non solo nel Nuovo, ma anche nel Vecchio Testamento era già prescritto l’amore dei nemici. Così nel Levitico (XIX, 17) si legge: «Non odierai il tuo fratello nel tuo cuore... Non cercare la vendetta e non conservare memoria dell’ingiuria dei tuoi concittadini». E nel Deuteronomio (X, 19): «Amate Voi altresì i forestieri, perché anche voi foste forestieri nella terra di Egitto». Nel libro dei Proverbi: (XXV, 21-22): «Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete dagli da bere». E nell’Ecclesiastico (XXVIII, 1-2) «Chi fa vendetta, proverà la vendetta di Dio, che terrà minuto conto dei suoi peccati. Perdona l’ingiuria al tuo prossimo, e allora alla tua preghiera i tuoi peccati saranno rimessi». Da questi testi appare che dovevano amarsi anche i nemici, ma i rabbini, forse per il fatto che Dio, per impedire ogni contaminazione idolatrica, aveva voluto che il popolo eletto fosse segregato dagli altri, insegnavano che era lecito e fors’anche doveroso odiare i nemici della patria e della religione. I Farisei,estendendo questi principii, dicevano che doveva essere odiato anche ogni nemico personale. Gesù Cristo invece aggiunge: «Ed io dico a voi: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, affinché siate figli del vostro Padre, chè è nei cieli ». Sublimi consigli di eroismo, che non sono rimasti lettera morta per i discepoli di Gesù Cristo. Santo Stefano, la primizia dei martiri, sotto il turbine di pietre dei suoi lapidatori esclamava: «Signore, non imputare loro questo peccato!».
— Replicano i nemici di Gesù: Presto detto: — «Amate i vostri nemici!» — Finché si dice di perdonare, compatire, chi ci ha fatto molto male, ed anche di pregare per lui, passi; ma dimenticarne i torti ed amarlo... Come può giungervi la nostra natura tanto sensibile? Rispondiamo. Certo, la nostra natura, lasciata a sé stessa, non può giungere facilmente a tanto: ma non si tratta di questo. Si tratta invece di amare i nostri nemici «corrispondendo» alla grazia che ce ne offre il Signore, e che non manca mai a chi la solleciti con la preghiera fatta come si deve. Però notiamo subito che non si tratta di un amore sensibile di spontanea simpatia; realmente un tale amore qui mancherebbe del suo naturale fondamento. Quando una persona ci ha procurato del male, quando un nemico della patria ha seminato attorno a noi delle rovine, non sono tenuto certo ad approvare le sue azioni, che anzi posso (e devo) giustamente riprovare e abominare. E posso anche desiderare la rovina di un nemico, se questa rovina mi libera da una persecuzione ingiusta, o se è causa di salvezza per molti infelici. Così posso desiderare che venga distrutta una squadra d’aeroplani, che vada a seminare la distruzione e la morte in mezzo ad una popolazione inerme. Ma tutto ciò non toglie che si possa amare la persona del nemico, considerando in lui un figlio di Dio come noi, un nostro fratello in Gesù Cristo, un’anima come noi destinata alla salvezza eterna. I nostri buoni e valorosi soldati, che in fondo al cuore portano radicato il sentimento cristiano, anche quando rimane nascosto, più d’una volta hanno provato come si possa combattere strenuamente il nemico, pur amando le persone. Più d’uno ricorderà l’episodio, riportato dai giornali, di quell’aviatore, che dopo aver fatto precipitare in mare un apparecchio nemico, non s’accanì contro l’avversano per finirlo, ma, sceso sull’acqua pur con proprio pericolo, raccolse il nemico portandolo in salvo alla base. E sappiamo di soldati che, in Africa, dopo un combattimento tra le sabbie ardenti, si privavano di un sorso della preziosa acqua, per cederlo a un ferito nemico. E sappiamo di numerosi altri che, dopo l’occupazione della Grecia, dividevano la loro pagnotta con la popolazione affamata...
Ma più aspri e dolorosi sono oggi gli odii tra concittadini, divisi da opinioni e passioni politiche. Qui, più che mai, per osservare il precetto dell’amore, è necessario ricorrere a motivi cristiani, sopratutto all’amore di quel Dio che vuole così, e considera come fatto a sé ciò che facciamo agli altri, e se ne ricorderà un giorno alla resa finale dei conti, ed anche prima: nei momenti del nostro bisogno.
Saremo noi stati larghi e generosi col prossimo? Anche Dio sarà largo con noi e non ci dirà di no alle ragionevoli nostre richieste. — Viceversa ci saremo malignamente impuntati nei nostri pretesi diritti trascurando «I diritti di Dio», che ci comanda l’amore dei nemici? Anche Dio insisterà rigorosamente sui diritti suoi: e, guai a noi, in tal giorno! Pensiamo che, se vorremo avere perfetta pace con Dio, ed entrare alla sua gloria celeste ed ai suoi gaudi, dovremo bene un giorno buttare a mare tutta questa greve zavorra di torve passionalità. Per farlo poi un giorno, con dispendio pari al colpevole ritardo, non è forse ben meglio farlo subito, con merito immenso, stroncando vigorosamente di un tratto la nostra lotta interna, e il tumulto di spinto che ne consegue? Anche a ciò, come in tanti altri casi, non ci vorrà molto, col divino aiuto. — Diciamo il nostro «sì» risoluto a quanto ci domanda il Signore; indi svaghiamoci in altro, per togliere alla passionalità quell’esca che agogna, e conservare tutta la bontà profumata di quel «sì», che sarà spesso eroico.
D’altronde, come insegna il Catechismo, Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e per goderlo poi nell’altra in Paradiso. A uno scriba che gli chiedeva quale fosse il primo comandamento, Gesù rispose che è quello che impone di amare Dio con tutto noi stessi (v. Mc. 12, 28-32). Vi è un solo Dio (Padre, Figliuolo e Spirito Santo) e perciò dobbiamo amare e servire Lui solo e amare le creature in quanto è volontà sua che le amiamo. Dobbiamo amare tutti gli uomini come fratelli, perché siamo tutti creature di Dio e figli degli stessi progenitori. L’essere figli di una sola Chiesa, che è cattolica, ci obbliga ad amare tutti gli uomini con lo stesso amore. Tuttavia ciò non significa approvare il male commesso da terzi o vivere da idioti: questo mai!
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, rispondiamo ad alcune obiezioni utilizzando il volumetto SOS «Brevi risposte a varie difficoltà», G. Monetti, imprimatur 1944.
• Affermano i detrattori: La Confessione? È un’invenzione dei preti! È inutile che s’insista con me perché mi confessi! Nessuno mi caverà di mente che la confessione sia un’invenzione dei preti: invenzione interessata in grado superlativo, per dominare le coscienze, e quindi le attività degli uomini, per volgerle poi — al momento giusto — a proprio vantaggio! Rispondiamo. — Speriamo che la tua avversione alla Confessione non sia la fissazione aprioristica di un ostinato che non vuol udire ragioni: quella, certo, sarebbe inguaribile dalla scienza teologica e storica; entrerebbe nel dominio della... patologia! Non so se mi spiego... — Perciò ragioniamo.
• Ti pare possibile che i preti abbiano mai «pensato» ad inventare la Confessione? Se erano proprio quei furbi matricolati che si vorrebbe far credere, astuti sino al punto di escogitare un’arte sì sopraffina per giungere ai pretesi loro fini di intrigo e di dominio, ci voleva poco per accorgersi che per tal via non avrebbero potuto abbindolare che i semplici; la gente avveduta avrebbe mangiato la foglia, e si sarebbe tenuta al largo... Quanto ai semplici, appunto perché semplici, c’erano altre maniere di arreticarli, senza compromettersi! — Veri furbi non avrebbero mai pensato sul serio ad un’istituzione di questo genere, naturalmente ripugnante a tutti: certo, se la Confessione non fosse un’istituzione divina, immediatamente, appena proposta, avrebbe suscitato nel campo dei credenti quelle proteste e quelle alienazioni d’animo che suscita oggi nel campo degli increduli! E a che bel fiasco sarebbero andati incontro i preti! L’arte dei furbi, invece, è precisamente quella di farsi innanzi pian piano senza urtare nessuna suscettibilità, senza far novità che dèstino sospetti e mettano in guardia: Non è vero?
• Ed anche se, per dannata ipotesi, i preti avessero potuto immaginare da sé d’introdurre la Confessione, l’avrebbero essi «voluto» fare? Si vede proprio che chi lo crede non ha neanche la più lontana idea della noia e della fatica che seco porta naturalmente una lunga seduta di confessionale; se no, un simile sproposito non gli sarebbe mai passato neanche per la mente! — Che gioia ci sarebbe per un prete — caso mai la Confessione non fosse istituzione divina di Gesù Cristo stesso — nello starsene lì, confitto in confessionale, le lunghe ore, a sentire il racconto delle miserie di sconosciuti, spesso ripetute dagli uni dopo gli altri fino alla nausea, spesso anche dovute tirare fuori di bocca quasi con le tenaglie a penitenti rozzi o peritosi, condannando poi se stessi a ripetere le migliaia di volte dal più al meno le stesse raccomandazioni, ed a rimettere perciò ad altro tempo occupazioni ben più geniali, e materialmente più proficue? Quanto semplicismo! E pazienza ancora, se si trattasse soltanto di questo: ma i lunghi studi preparatori? E gli esami da subire in merito?
• E l’obbligo anche per i preti, di confessarsi essi stessi? Persino il Papa ha il suo confessore! E i preti son essi i primi a ritenersi in obbligo di confessarsi! Bell’affare, adunque, avrebbero combinato, assumendosi spontaneamente simili durissime obbligazioni! Del resto, anche i preti, come tutti gli altri, hanno diritto di non venire condannati senz’altro come falsari, bugiardi, mistificatori, senza prove — e ben chiare e convincenti — a loro carico: ora dove sono queste prove? Un’innovazione simile, per tutta la Chiesa, non può immaginarsi spuntata lì, come un fungo boschereccio dopo una nottata piovosa; avrebbe dovuto sancirsi da qualche solenne decreto o conciliare o pontificio, ovvero avrebbero dovuto introdursi a poco a poco insensibilmente, senza contrasto, per consuetudine, sino a che questa, stabilizzatasi universalmente ed ufficialmente, assumesse forza di legge. Ma intendi tu una consuetudine, che per volontà concorde ed efficace di popolo, faccia accettare un peso tanto grave quanto la Confessione, sino a crearne un obbligo imprescindibile? Sappiamo bene quanto gli individui ci tengano all’indipendenza, e le folle ripugnino alle coazioni! Dunque la confessione non fu introdotta per spontanea consuetudine. Ma neanche per decreti o disposizioni positive di Papi o di Concili, se si tratti della Confessione segreta, sacramentale, quale la intendiamo qui.
• Ci sono, sì, decreti di Papi e di Concilii che riguardano la penitenza pubblica, ma quella non è precisamente la Confessione; non è sacramento, fu d’istituzione nettamente ecclesiastica, e col tempo disparve. — Così ci sono pure decreti e conciliari e Pontifici (in particolare il Decreto d’Innocenzo III e del Concilio Lateranense IV), in cui si tratta della Confessione propriamente detta: ma tali decreti non istituiscono davvero la Confessione. Essi non fanno che regolamentare l’uso, vigente già sino dal Cristianesimo primitivo, come attestano ininterrottamente i SS. Padri in ciascun secolo precedente, sino a risalire ai tempi apostolici, e poi a Gesù Cristo stesso, Autore della Chiesa, della Fede, dei Sacramenti, e quindi anche della Confessione. Da ultimo, posta la pregiudiziale dell’inganno da parte dei preti, come si sarebbe potuta mantenere a lungo una mistificazione sì enorme, senza venire o presto o tardi smascherata da malevoli, da eretici, da empi filosofi, da scismatici, da ribelli? E come potrebbe concepirsi oppressione sì ingiusta, proprio da parte dei Personaggi più santi che l’umanità abbia conosciuto, quali i Sacri Pastori della Chiesa, i SS. Padri, i SS. Dottori? — Falsari di tal fatto, obbrobrio del genere umano, non possono certo trovarsi tra il fior fiore della società cristiana!
• Dice il Catechismo (useremo il commento del P. Dragone) che la grazia di Dio perduta per il peccato mortale si riacquista con una buona confessione sacramentale, o col dolore perfetto che libera dai peccati, sebbene resti l’obbligo di confessarli. Il peccato mortale, sebbene sia un male gravissimo e incalcolabile, non è irrimediabile. Se ne può ottenere il perdono con una buona confessione sacramentale. Infatti il sacramento della penitenza fu istituito da Gesù Cristo per la remissione dei peccati attuali di tutti i battezzati che lo ricevono con le dovute disposizioni (v. i nn. 143-144, e specialmente 355, 362-366). Per avere il perdono dei peccati gravi è necessario il sacramento della Confessione, o almeno il proposito di riceverlo quando sarà possibile. I cristiani dei primi secoli erano ben consci della necessità della confessione e vi si accostavano spesso. In seguito, diminuendo il fervore, anche la frequenza alla Penitenza andò scemando. Perciò la Chiesa, nel quarto Concilio del Laterano (1215), dichiarò obbligatorio per tutti i cristiani che hanno raggiunto l’uso di ragione accostarsi al sacramento della Penitenza almeno una volta l’anno. Con questa legge la Chiesa non impose un nuovo obbligo, ma rese più chiaro ed esplicito l’obbligo di confessare i peccati e ricevere la Santissima Eucaristia. Il Concilio non inventò la confessione, come dicono i protestanti, ma determinò quante volte ci sia l’obbligo di confessarsi. Il Concilio di Trento precisò: «Se qualcuno negherà che tutti e ciascuno dei fedeli cristiani siano obbligati a confessarsi (almeno) una volta l’anno, conformemente alla Costituzione del Concilio Lateranense, sia scomunicato» (DB 918). Per evitare il peccato grave e correggere a poco a poco i propri difetti è necessaria la grazia sacramentale della Confessione.
a cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, riprendiamo il tema dell’immigrazione di cui si è iniziato a scrivere nel numero 220 di Sursum Corda. Al medesimo luogo rimandiamo per le premesse, per gli articoli menzionati e per le ragioni dello scritto. È d’uopo solo ricordare la nostra principale fonte: 1993, Editrice Civiltà di Brescia, sotto lo pseudonimo di Giuli Valli, «Il vero volto dell’immigrazione. La grande congiura contro l’Europa».
• Il fenomeno in atto è così grave ed immenso (scriveva l’Autore al principio degli anni novanta), e le sue manifestazioni sono, a volte, così clamorose che non possono mancarne le eco sulla stampa, e a quelle eco abbiamo attinto copiosamente per queste nostre pagine. Tuttavia abbiamo notato, da parte dei mezzi di comunicazione, una sconcertante tendenza a minimizzare e sdrammatizzare, sia gli atti criminali commessi dagli extracomunitari, sia le reazioni degli italiani. Non ci risulta, ad esempio, che sulla stampa nazionale si sia dato congruo risalto ad una manifestazione di protesta che si assicura essere avvenuta a Genova allorché, com’è noto, un nordafricano, gridando parole di odio contro gli italiani, colpì violentemente al capo, con la mannaia di un macellaio, una bimbetta di pochi anni, ferendo poi anche il genitore e altre persone presenti nel negozio. Similmente, solo uno dei giornali di Trento ha dato notizia, e su spazio ristrettissimo, di un episodio davvero eccezionale per tale piccola e tranquilla città: uno scontro a colpi di bastone e di bottiglie spezzate tra un gruppo di prostitute italiane e uno di prostitute di colore, per il dominio di una delle piazze del vizio. (Dallo stesso tenore della notizia di stampa, si ricava che non è stato il primo episodio!). Anche le vicende notturne di Bologna, analoghe a quelle di Trento, ma su molto maggior scala, e la reazione massiccia dei quartieri interessati, con fiaccolata notturna e turni di guardia nella notte, non hanno certo avuto il risalto che un evento simile avrebbe ottenuto se non avesse riguardato il problema dell’immigrazione extracomunitaria! Questa coltre ovattata di complice silenzio, notava l’Autore già nel 1990/91, serve ad evitare il consolidarsi di una presa di coscienza della straordinaria gravità di quanto sta accadendo, da parte di un’opinione pubblica sempre più inerte ed acritica che i grandi centri di potere manipolano e dirigono a loro piacimento.
• A mano a mano che il fenomeno, aumentando di proporzioni, dà luogo a manifestazioni più gravi e inquietanti, assistiamo a quel gioco dello scaricabarile che costituisce uno degli aspetti più caratteristici dell’attuale sistema politico: esso consiste in una serie di pubbliche e reciproche accuse tra persone ed istituzioni, tutte più o meno responsabili e complici di qualche grosso malanno. Nel frastuono assordante delle polemiche, che preferibilmente non debbono toccare il nocciolo della questione, la gente resta frastornata ed incerta domandandosi chi mai avrà ragione, e, magari, prendendo posizione per questo o per quello, e intanto non si accorge che colpevoli sono tutti, proprio come accade in certi processi penali dove i complici di uno stesso delitto tendono a scaricarsi l’uno sull’altro tutte le responsabilità per vedere di farla franca. Nel nostro caso, un esempio eloquente di questo modo di procedere è dato da quanto è accaduto a Roma. Su «Il Tempo» del 15 luglio 1990, sotto il significativo titolo «Immigrati a orologeria», leggiamo che Monsignor Luigi Di Liegro, direttore della “Caritas” di Roma, accusa il Comune della città, e quindi le autorità politiche locali, per non avere provveduto alle esigenze di alloggio e di servizi degli extracomunitari sistemati alla peggio nei locali dell’ex-pastificio Pantanella. Il competente assessore, dal canto suo, si rivolge addirittura alla Protezione Civile, in ciò preceduto, peraltro, dallo stesso Mons. Di Liegro. Intanto, poiché il problema è di difficilissima soluzione anche per il noto fatto che in Italia, grazie sempre alla politica governativa, gli alloggi mancano per gli stessi italiani, e quindi le cose vanno per le lunghe, il prelato fa la voce grossa e ammonisce: «Attenzione, signori, perché abbiamo tra le mani una bomba a orologeria. La guerra tra i poveri è già cominciata, ma se andiamo avanti così rischiamo la guerriglia urbana!». Cosa si ricava da tutto ciò? È chiaro: poiché l’intervento del servizio di Protezione Civile è previsto per calamità e disastri, è evidente che si ritiene che ormai l’invasione islamica abbia raggiunto livelli tali da poter essere qualificata, appunto, un disastro nazionale; anzi, Mons. Di Liegro, la definisce addirittura «una bomba ad orologeria, foriera di guerre». La situazione, dunque, è tragica, e tende ad aggravarsi ulteriormente con l’aumentare del numero degli immigrati.
• Ma di chi è la responsabilità di tutto ciò? La risposta è ovvia: di chi provoca, permette o favorisce l’immigrazione, e quindi, in primissima linea, sia del potere politico che delle strutture ecclesiali (occupate dai modernisti, ndr.), e della Caritas in particolare. E allora sorge spontanea un’ulteriore domanda: è cristiano o non, piuttosto, pazzesco o criminale porre le basi di una guerra civile e quindi di una carneficina? Un altro aspetto sconcertante della vicenda è che la CGIL si sforza di instillare nelle teste degli immigrati uno spirito di rivendicazione, e quindi di protesta, persuadendoli di essere titolari di chissà quali diritti, col prevedibile risultato di fomentare un odio di classe che, date le peculiarità della situazione, non potrà non trasformarsi in odio di religione e di razza. A questo riguardo, non possiamo fare a meno di osservare - anticipando quanto più approfonditamente vedremo nella seconda parte di questo scritto - che il potere occulto, che, come la vicenda della loggia P/2 insegna, si colloca al vertice e al di sopra delle istituzioni e dei partiti, ma non contro di essi, utilizzerà quasi certamente il delitto, con la spregiudicatezza che gli è propria, dapprima per additare alla pubblica esecrazione e intimidire coloro che si oppongono all’immigrazione, colpevolizzandoli con l’addebitare loro ben calcolati misfatti; (è comunque sempre possibile promuovere e foraggiare movimenti neo-nazisti, pescando tra esaltati e squilibrati!). In un secondo momento, si servirà dello stesso strumento per confondere le idee e distogliere l’attenzione del pubblico dalle proprie mene. In questa prospettiva, sono da prevedere attentati sanguinosi e delitti spietati. In tal modo, i burattinai assisteranno alla scena sogghignando in disparte, presentando, magari, se stessi o i loro emissari, come pacieri e intemerati custodi della legalità infranta dai facinorosi. Le tenebrose storie degli attentati sui treni, alle stazioni, nelle banche, ecc., dovrebbero rappresentare e tutti un’eloquente lezione! [Come dar torto all’Autore del volume che, già negli anni 1990 1991, anticipava meticolosamente quanto sarebbe accaduto. D’altronde è noto che dalla sapienza cristiana viene conseguentemente la preveggenza, ndr.].
• Pur riservando alla seconda e terza parte del nostro studio la disamina dei risvolti e retroscena più profondi e sconcertanti dell’avventura immigratoria, ci pare opportuno, a conclusione di queste pagine introduttive, svolgere alcune rapide considerazioni sul contesto politico-sociale e criminologico in cui questo fenomeno si inserisce e sulle sue prospettive a breve termine. Premesso che - come era, più che prevedibile, sicuro, anche per le esperienze dei paesi che ci hanno preceduto su questa via! - la gran maggioranza delle attività criminali degli “extracomunitari” si svolge nel settore del traffico della droga, va detto che una serie di operazioni di polizia e di istruttorie penali, in Italia ed all’estero (basti ricordare, da noi, le indagini dei giudici Carlo Palermo, del Tribunale di Trento; Augusto Lama, del Tribunale di Massa Carrara e Mario Vaudano, del Tribunale di Torino) hanno rivelato lo stretto legame esistente tra tale traffico, mondo islamico, mercato internazionale delle armi da guerra, terrorismo - specialmente musulmano e sudamericano - guerre locali, o guerriglie, (Afghanistan, Libano, Iran-Irak, Nicaragua, ecc.), banche operanti su scala internazionale, e quindi alta finanza, classi politiche e, spesso, governi di paesi di tutto il mondo. Cercando di essere il più possibile sintetici su un argomento che meriterebbe ben più diffusa trattazione, vari cordato, anzitutto, che quello degli stupefacenti è un affare colossale il cui ammontare, nel 1988, è stato valutato in 500 miliardi di dollari. È opportuno rammentare altresì che uno dei principali problemi di questo traffico è il riciclaggio del cosiddetto “denaro sporco”, perché i grandi pacchi di banconote presentati agli sportelli bancari dai grossi trafficanti non possono non destare i sospetti della polizia, con conseguente individuazione e incriminazione dei corrieri e dei mandanti, quindi sequestro dei proventi. Ora, da una serie di indagini, specialmente della polizia statunitense, è emersa un’attiva partecipazione e complicità di numerosi e importantissimi istituti bancari che si prestano sistematicamente a questo riciclaggio e hanno persino istituito, a tal fine, appositi servizi e succursali nei cosiddetti “paradisi fiscali”, piccoli Stati nei quali le operazioni finanziarie si svolgono al di fuori di ogni controllo. Una volta che i grandi trafficanti hanno incassato, attraverso manovre abbastanza complesse in cui intervengono numerose società di comodo, il denaro così apparentemente ripulito, si pone il problema di investirlo. Ora, uno degli investimenti più proficui, e comunque il più seguito, è quello delle armi, di cui c’è grandissima richiesta da parte di organizzazioni terroristiche ed eserciti del Terzo Mondo. In queste operazioni, si distinguono specialmente i paesi musulmani. In particolare, sin dal 1983, l’ayatollah Khomeini ebbe ad emettere una “fatwa” (decreto religioso) in cui invitava a combattere «il grande Satana (gli USA) e i suoi alleati, (quindi tutto il mondo occidentale!) con tutti i mezzi e particolarmente facendo ricorso agli stupefacenti»; dichiarazione da cui risultano evidenti il profondo odio islamico per il mondo occidentale e l’immensa pericolosità di un’immigrazione composta da persone molte della quali, a differenza dei criminali nostrani, delinquono non per cinico amor di danaro che supera ogni remora morale, bensì nella distorta visuale di una religione distorta, al preciso scopo di distruggere noi e la nostra società, e nella convinzione di adempiere, così facendo, un alto dovere morale. Anche la Siria ricorre sistematicamente al traffico degli stupefacenti per finanziare il proprio esercito e il terrorismo arabo. Pure lì, un capo religioso islamico e gran trafficante di droga, ha autorizzato con una “fatwa” la coltivazione del papavero e della canapa indiana, e colui che, dalla Francia, sovrintende al commercio siriano, è addirittura Rifat-el-Assad, il fratello del dittatore di quel paese, Hafiz-el-Assad, il massacratore del Libano cristiano! Similmente, l’Afghanistan finanzia la sua guerra con un ingente traffico di eroina. Quanto all’Egitto, basti dire che il fratello di Sadat aveva anche lui le mani in pasta. È poi noto, dalle cronache, quanti sequestri di imponenti quantitativi di droga siano stati effettuati in Italia su autocarri di provenienza turca. Dal canto suo, Israele, attraverso uomini già appartenuti ai suoi servizi segreti (il Mossad), addestra i killers dei magnati della droga del cosiddetto “cartello di Medellin” e ha curato il traffico di rifornimento di armi ai contras del Nicaragua e all’Iran, sempre finanziato, beninteso, con denaro sporco. Ci troviamo, insomma, di fronte ad un complesso sistema operante su scala intercontinentale. Il mondo comunista vi ha pure la sua non piccola parte che coinvolge i produttori di droga, i circuiti di spaccio all’ingrosso, assicurati da associazioni criminali tipo mafia, (che formano ormai una rete abbracciante tutto il globo!), alta finanza, e governi di paesi produttori di stupefacenti. Ma anche le classi politiche dei paesi occidentali, produttori di armi, vengono coinvolte in questo traffico. Ognuno, infatti, capisce che un flusso massiccio e continuo di cannoni, carri armati, elicotteri, missili, aerei, navi da guerra, munizionamento pesante e leggero per migliaia di tonnellate, sistemi d’arma: quanto occorre, insomma, per sostenere un conflitto, non è cosa che possa passare inosservata; si aggiunga che le fabbriche di armi da guerra, per la loro stessa natura, sono controllate o, comunque, in stretto rapporto con le autorità politiche dei paesi di appartenenza. A questo punto, è evidente che presupposto indispensabile di tutti questi traffici è la compiacente passività, se non addirittura la attiva collaborazione, di una determinante parte delle gerarchie politiche del mondo occidentale. Ne è una manifestazione clamorosa il caso del cosiddetto “Irangate”, che ha coinvolto le autorità USA. Ma anche nel campo del semplice riciclaggio del denaro sporco, il mondo politico è stato colto a tener bordone alle manovre dei banchieri... Naturalmente, questi silenzi, queste compiacenze, queste coperture non sono disinteressati... Il risultato finale di tutto ciò, sconcertante per il semplice cittadino che vive del suo lavoro e magari - beato lui! - crede alle virtuose dichiarazioni dei partiti e alle loro strenue campagne per i poveri e gli “emarginati”, è una solidarietà occulta, ma profonda e tenace, tra produttori di droga, associazioni criminose che ne curano la distribuzione, alta finanza, mondo della politica, sino a una vera e propria compenetrazione, al punto che spesso è difficile dire dove comincia una e dove finisce l’altra categoria. Lentamente, ma sicuramente, sulla scia dei principii dell’immoralismo materialista, laico e machiavellico, sta costituendosi un sistema di dominio mondiale che spezza i confini degli Stati, e ove, all’insegna di Mammona, alta finanza, politica e crimine organizzato, si fondono in un corpo unico. Occorre tener presente, a tal fine, l’unione europea del 1992, quando, cadute le frontiere, sono venuti meno tutti i relativi controlli che costituivano il più robusto argine al dilagare della droga. Riferisce, infatti, il Moncomble che, in Francia, l’80% dei sequestri di sostanze psicotrope avviene appunto ai confini di Stato («Le pouvoir de la Drogue...», pag. 115). Abbattute le dighe, grazie anche alla legge Martelli, l’Europa costituisce, ora, un vasto e indisturbato mercato cui possono confluire, senza troppe difficoltà, trafficanti di ogni paese della terra.
• Scriveva il rabbino Baruch Levi al suo correligionario Karl Marx: «Il popolo israelita, preso collettivamente è esso stesso il proprio Messia. Il suo regno si otterrà con l’unificazione delle razze umane, la soppressione delle frontiere e delle monarchie, che sono la difesa del particolarismo, e con l’istituzione di una Repubblica Universale». Ma c’è davvero una congiura dietro la grande e incontrollata immigrazione? «La Repubblica» del 23 febbraio 1990 (al pari, del resto, di tutti i quotidiani nazionali) riferiva che, la notte precedente, 54 clandestini erano stati sorpresi dalla polizia portuale di Bari mentre cercavano di mettere piede sul lungomare di quella città, dopo essere stati scaricati da una scialuppa, messa a mare da un ignoto mercantile [I primi esperimenti di quella che poi diventerà prassi per milioni di clandestini, ndr.]. Venivano, quei giovani, dalle terre più disparate e remote ed erano stati attirati in Italia da sconosciuti reclutatori con mendaci promesse di stabile e remunerata occupazione. Per il viaggio avevano dovuto pagare 2.000 dollari a testa, un prezzo assai alto per gente povera, onde, una volta giunti in Italia e trovatisi di fronte all’inevitabile disinganno, sarebbe stato assai arduo per loro tornare ai lontani paesi di origine. Ai poliziotti che li interrogavano, costoro riferirono di un misterioso uomo che parlava inglese, «con il volto nascosto da una maschera che lasciava intravvedere solo gli occhi», e che li aveva fatti scendere sulla scialuppa, lasciandoli poi sul molo foraneo del porto pugliese. Quel quotidiano dava notizia, lo stesso giorno, di un flusso di clandestini attraverso il confine del Brennero, e di un secondo attraverso quello jugoslavo. Innumerevoli altri immigrati entrano, poi, per vie legali: ad esempio col traghetto “Abib” che ogni sabato mattina attracca al porto di Genova, o con quello che, pure settimanalmente, approda a Trapani dalla Tunisia. «Ma delusione e angoscia - scrive Guido Nicosia su «Avvenire» del 3 marzo 1990, sotto il titolo «Clandestini ancora a frotte» - non si fanno attendere»: il lavoro promesso, infatti, non c’è, e allora, nella migliore delle ipotesi, bisogna andare in giro a vendere [in nero, ma del nero extracomunitario nessun trombone mediatico si scandalizza, ndr.] penne “Bic” e accendini, occhiali da sole e collanine, non si sa da chi e a quali condizioni forniti». Che si deduce da tutto questo? La risposta è evidente: che una schiera di arruolatori retribuiti percorre le strade del mondo islamico, dall’Africa occidentale al subcontinente indiano, sfacciatamente mentendo e presentando, a gente spostata e ignorante, l’Italia come un Eldorado, una terra di immense risorse e di favolosa ricchezza che offre lavoro e guadagno a folle sterminate. Questo colossale inganno presuppone un ’organizzazione complessa ed articolata, ricca di mezzi, oltre che di uomini; una vera e propria congiura a livello internazionale. Ma, quello che ancora più colpisce, presuppone anche il consenso del mondo politico e del governo italiano. Esso, infatti, di fronte all’assedio tumultuoso, lungi dall’intensificare i controlli, smantella le barriere legali abrogando, come si è visto, gli articoli della legge di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento, sostituendoli con il velo illusorio della legge Martelli. Per giunta, spiega il citato articolo di Guido Nicosia su «Avvenire» del 3 marzo 1990, il nostro governo, almeno fino a quella data, non chiedeva alle persone provenienti dall’area maghrebina e dal Senegal, e cioè dalle terre islamiche che forniscono il maggior flusso di immigrati, neppure il visto di entrata. Onde, per esse, persino l’inconsistente filtro della nuova legge era reso del tutto inoperante. Inoltre, altra realtà di fronte alla cui evidenza è giocoforza arrendersi, la congiura ha a propria disposizione tutti i grandi strumenti di propaganda e se ne avvale per esorcizzare ogni accenno di perplessità e di sconcerto, ricorrendo, per intimidire i potenziali oppositori, al ricatto della magica parola “razzista”, (quasi che il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, rimasto in vigore sino a quest’anno, fosse stato un’espressione di razzismo!), o a quello di un sentimentalismo falso e piagnucoloso, o, addirittura, a roventi accuse di abbietto e anticristiano egoismo. [Per conoscere la vera dottrina cristiana sull’immigrazione rimandiamo alle nostre pubblicazioni: 1° Exsul Familia Nazarethana in italiano. La Magna Charta di Pio XII sull’immigrazione; 2° Esposizione della dottrina cristiana sulle migrazioni; 3° Teologia Politica 107. Breve dissertazione sulla cosiddetta “immigrazione” (parte 1); 4° Teologia Politica 108. Breve dissertazione sulla cosiddetta “immigrazione” (parte 2)., ndr.].
• Ma qual è il movente di questa lapalissiana congiura? Siamo forse di fronte a un’immensa opera filantropica, a una lega occulta di generosi che, commossi dalla povertà di tanta gioventù del mondo islamico, vogliono farla in qualche modo partecipe dei benefici economici della nostra società? Forse, il penoso e sconfortante giudizio che avevamo formulato fino a ieri sulla nostra classe politica, anche per la sua proverbiale voracità, che richiamava alla nostra mente i terribili pesci pirañas dell’Amazzonia, va radicalmente rivisto e dovremo, d’ora in poi, considerarli come una categoria di disinteressati, anche se, per i motivi che abbiamo illustrato nella prima parte di questo scritto, incredibilmente ingenui e maldestri, benefattori del genere umano? In realtà, però, francamente parlando, davvero non riusciamo a vedere - per usare una brutta espressione alla moda - una grande “promozione umana”, in relazione a persone costrette a mendicare per le vie o a lavorare saltuariamente nei lavori più ingrati e a condizioni strozzinesche, ovvero indotte a prostituirsi sui marciapiedi, a spacciare droga, a rubacchiare o a venire irregimentate nelle organizzazioni della malavita del sud e del nord d’Italia. Neppure ci pare che sia il non plus ultra della carità spiantare un uomo dalla sua terra, dalla sua famiglia, dal suo ambiente, per indurlo, con l’inganno, a trasferirsi in un mondo a lui totalmente estraneo. Pur nella sua frenesia immigratoria, persino il mensile «Nigrizia» espressamente riconosce questa evidenza: gli immigrati «sono... le vittime di un profondo senso di isolamento, di emarginazione, di impotenza; tutti sentimenti che spesso possono sfociare in tentativi di suicidio e, qualche volta, portare alla morte», scrive Maria Rita Matti sul numero dell’ottobre 1989 di quella rivista, sotto il titolo «Ero in carcere, sei venuto a trovarmi»! Viene da chiedersi: non era forse mille volte più efficace, fraterno e misericordioso l’aiuto offerto prima del Vaticano II e, in parte, ancora oggi, dai missionari e dalle missionarie, portando a domicilio ospedali e ospizi, lebbrosari e scuole, insegnando tecniche agricole, scavando pozzi, allestendo bacini, e - quel che più importa - diffondendo quel sommo fattore di vera civiltà che è il Vangelo di Cristo? Non si sarebbe potuto sostenere e incoraggiare la loro preziosa azione di vero servizio a Dio e all’uomo? Non è facile sottrarsi alla penosa impressione che l’esodo grandioso cui stiamo assistendo assuma piuttosto l’aspetto - e non parliamo solo delle donne, trascinate a migliaia sulla via della prostituzione! - di una smisurata tratta di schiavi nel quadro di un tenebroso piano di occulti “Signori”.
• Chi ascolta i piagnistei governativi e le grida indignate della stampa di regime contro i cattivacci che si allarmano per l’inattesa invasione, non può non restare sbigottito sol che ripensi alle mille difficoltà che recentissimamente vennero fatte contro alcune centinaia di profughi polacchi, rinchiusi come malfattori in campi di concentramento. Ad essi fu impedito di lavorare e di inserirsi nel contesto sociale italiano, malgrado parecchi di loro avessero qualifiche professionali di tutto rispetto. Eppure, in quella circostanza, nessun organo di stampa volse la sua cetra in pianto; nessun governante sorse gridando alla lesa umanità e si stracciò pubblicamente le vesti; nessun sodalizio umanitario alzò la voce contro l’obbrobrio razzista. Ci si domanda: quelle centinaia di polacchi, forniti di regolari documenti, erano davvero tanto più pericolosi, sospetti e destabilizzanti delle molte centinaia di migliaia di persone che, a non tanti mesi di distanza, corrono le strade e battono i marciapiedi della penisola e dei milioni che premono ai suoi confini? Più ancora sconcerta e insospettisce quello che sta succedendo con i profughi vietnamiti: l’Assemblea Generale di quelle Nazioni Unite che - come vedremo - hanno avuto e hanno una parte così importante nell’incoraggiamento all’immigrazione dei cosiddetti “vu cumprà”, in una conferenza internazionale, tenuta a Ginevra il 13 e 14 giugno 1989, ha deciso di imporre restrizioni nell ’accordare lo status di profugo politico a coloro che sono fuggiti dal territorio del Vietnam, per lo più su fragili imbarcazioni, in quelle terribili e rischiosissime condizioni che tutti sanno, e di rispedire in patria i fuggiaschi “illegali”, così, in pratica, esponendoli al concretissimo pericolo di una condanna a morte in massa o, nella migliore delle ipotesi, a terrificanti rappresaglie, essendo ben nota la spietata crudeltà dei regimi comunisti verso i loro profughi (Vedasi al riguardo «Nuova Solidarietà», numeri del 23 settembre e del 23 dicembre 1989). Eppure, si trattava di circa 100.000 persone in tutto, pochissimi, dunque, rispetto alla massa degli attuali immigrati, e si sarebbe potuto distribuirli in tutti i paesi dell’occidente; eppure - giova aggiungerlo - quegli sventurati, vittime di un regime spietato, sono profughi politici veri, verissimi, e non immaginari e per burla, come quelli che provengono dalla Tunisia e dal Marocco, dal Senegal e dal Ghana, e verso cui l’ONU è così larga di amene patenti di “rifugiato politico”! Vi è per caso capitato sott’occhio l’appello a Wojtyla dei 47.000 rifugiati di Hong Kong? A leggerlo c’è da rabbrividire: dopo avere accennato alla persecuzione e alla spaventosa oppressione del regime comunista, che li ha indotti a tal punto di disperazione da abbandonare la loro amatissima terra e ogni caro ricordo e affidare le loro vite a fragili battelli vaganti senza precisa meta sui flutti minacciosi dell’oceano, essi descrivono la loro attuale prigionia nei campi britannici di Hong Kong: «Siamo stati considerati come immigranti illegali, gettati in campi attorniati da due cinte di filo spinato, come erano in altri tempi i campi nazisti. Manchiamo di tutto, materialmente, moralmente ed affettivamente. Viviamo in una tensione insopportabile, senza sapere che sarà del nostro avvenire». In realtà, se proprio non lo sanno con certezza, lo immaginano: «L’obiettivo principale delle autorità di Hong Kong, nello stabilire questa procedura di selezione (fra quelli che debbono e quelli che non debbono considerarsi rifugiati politici, ndA.) è stato quello di rimandare il maggior numero di rifugiati in Vietnam.». Ed essi, e, al pari di essi, le ultra-umanitarie autorità inglesi e onusiane, sanno benissimo ciò che là li attende: «Ciò che ci aspetta nel nostro paese, noi già lo sappiamo: inchieste, la prigione e l’eliminazione...» E incominciano così i rimpatri forzosi: «Di fronte alla sofferenza dei nostri compatrioti, picchiati, portati via nelle lacrime e tra le urla, ormai senza alcuna speranza non possiamo impedire a noi stessi di essere sconvolti dalla pietà» (dalla rivista missionaria dei gesuiti «Popoli» del 5 maggio 1990). Nobile sentimento la pietà! Peccato, però, che in questo caso non abbia trovato alcuna eco nel cuore degli uomini politici occidentali in genere (oh, la “civilissima” Inghilterra!) e di quelli italiani in particolare, pur così teneri quando si tratta di nordafricani e di senegalesi. Per questi sventurati non abbiamo sentito i ruggiti virtuosi dei socialisti, dei radicali e dei comunisti del nuovo corso occhettiano, né le prediche untuose dei democristiani [che non sono di dottrina cristiana, ndr.]. Nessun Martelli e nessun Andreotti si è fatto avanti a dire che l’Italia, commossa di fronte a tanta sventura, era disposta, sia pure con le dovute cautele, ad ospitare almeno in parte quegli esuli per sottrarli a morte quasi certa. Anzi - udite, udite! - il governo italiano che, nel 1989, si era impegnato (che sforzo!) a riceverne mille, a un anno di distanza -come informa «Famiglia Cristiana» del 20 giugno 1990 a pag. 101 - non ha mantenuto neppure questo meschinissimo impegno e non ne ha ricevuto neppure uno! Anche la pseudo indipendente stampa di regime si è ben guardata dal dar fiato alle sue prezzolatissime trombe: una coltre di complice silenzio copre l’agonia tormentosa di quella gente. Ci si domanda: se non è il colore della pelle, cos’è che rende così diverso, così spregevole un vietnamita rispetto a un maghrebino o a un senegalese? L’unica risposta possibile è: la religione. I vietnamiti sono, in alta percentuale, cattolici, mentre gli attuali immigrati sono, nella loro stragrande maggioranza, musulmani. Quale misterioso disegno si cela dietro a queste preferenze? Un altro episodio, che rende ben poco credibile la pelle di agnello di cui si rivestono i nostri governanti, è quello dell’Etiopia e dell’Eritrea. Come ha denunciato il famoso Piero Gheddo su «Avvenire» del 3 marzo 1990, guerra e fame hanno divorato quei paesi, schiacciati sotto il tallone di ferro del tiranno comunista Menghistu, che «ha distrutto l’economia con le nazionalizzazioni, e la serenità di vita del popolo con un sistema di controlli e repressioni da togliere il fiato», e sorresse il suo traballante potere con coscrizioni militari, fucilazioni di massa e bombardamenti aerei. Nella sola crisi alimentare del 1984-85, si calcola che siano morti circa un milione e mezzo di etiopi, e la situazione posteriore, pure in difetto di dati, fu ancora peggiore! Il popolo eritreo, oggi, tra deportati, profughi e morti, è ridotto a meno della metà e la sua terra a una landa desolata e sabbiosa. Ma chi ha sostenuto finanziariamente il feroce Menghistu da quando gli sono venuti meno gli aiuti sovietici? Lo denuncia il P. Gheddo: il Governo italiano! ... e naturalmente sempre all’insaputa e coi quattrini dello spennatissimo “popolo sovrano”! Nel gennaio 1990, questa compagine di buoni samaritani ha preso contatto col dittatore etiopico per mezzo (guarda chi si vede!) del sottosegretario agli Esteri, senatrice Susanna Agnelli, esponente della principale dinastia dell’ Alta Finanza mondialista in Italia!
• Un primo consistente indizio per sapere dove andassero cercati i meno occulti promotori di questo grandioso fenomeno ci fu offerto da un articolo apparso sul quotidiano «Alto Adige» del 10 agosto 1989, dal titolo: «Ondata di immigrati africani». Vi si riferiva l’intervista col presidente degli ambulanti trentini aderenti alla “Confesercenti”, il quale, tra l’altro, dichiarava: «Si calcola che nei prossimi anni, 30-40 milioni di africani verranno in Europa, e i governi centrali, su direttive dell’ONU (il corsivo è nostro), hanno affidato a Italia, Spagna e Grecia il peso maggiore. Sembra che l’Italia, nella spartizione internazionale, debba farsi carico dell’immigrazione senegalese, e si stima in 5 milioni la dimensione numerica: quasi una persona ogni dieci italiani»! Dunque l’ONU veniva indicata come la centrale da cui è partito l’ordine che è alle origini di questa vicenda e le si attribuiva un preciso programma che non potrà non incidere in maniera sconvolgente sul prossimo avvenire del popolo italiano, i cui destini, al di là dell’amena favoletta della sovranità popolare, evidentemente sono in mano di lontani e sconosciuti padroni. Successive ricerche confermavano che la pista era quella giusta: l’Italia, con la legge 10 aprile 1981 n. 158, ha ratificato la convenzione n. 143 del 1975 della Organizzazione Internazionale del Lavoro (uno degli organi dell’ONU), recante il titolo: «Sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti». Da qui si vede che già, almeno dall’ormai remoto 1975, si venivano addensando sul capo degli ignari italiani fosche nubi foriere di tempesta. In obbedienza a quei patti, il Governo nazionale proponeva e il Parlamento approvava la legge 30.XII.1986 n. 943 che sin da allora garantiva (art. 1 ) «A tutti i lavoratori extracomunitari parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani», nonché il godimento «dei servizi sociali e sanitari» e il diritto «al mantenimento dell’identità culturale, alla scuola e alla disponibilità dell’abitazione». E all’art. 2 prevedeva, proprio come riferito dal citato articolo dell’«Alto Adige», «accordi bilaterali e multilaterali previsti dalla convenzione dell’O.I.L. n. 143 del 24 giugno 1975... per disciplinare i flussi migratori». Si aprivano, insomma, fin da allora - in nome di una convenzione dell’ O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro), e cioè di un istituto specializzato dell’ONU, le porte all’immigrazione, nonostante ancora, malgrado le statistiche del CENSIS, il fenomeno non fosse neppur lontanamente così evidente, come è diventato oggi. E, in realtà, l’Italia non era affatto allora, così come non lo è a tutt’oggi, un paese che possa ragionevolmente attirare un consistente flusso immigratorio: di modesta estensione, montagnosa, povera di materie prime, densamente popolata, con grave penuria di alloggi già per i suoi abitanti, grazie anche a mille pastoie burocratiche che ostacolano le nuove costruzioni e persino il restauro di quelle già esistenti, con ancora molti suoi figli emigrati all’estero e una rilevante disoccupazione e sotto-occupazione interna, con servizi pubblici e sanitari largamente e spesso drammaticamente inefficienti, e insufficienti anche per la sola sua popolazione, davvero non si vede come potrà fronteggiare i mille problemi posti dalla valanga extracomunitaria [Noi, uomini del ventunesimo secolo, siamo oramai ben consapevoli di quanto l’Autore denunciava e presagiva trent’anni fa, ndr.] . Invero, come si è visto e si ribadisce, per uno straniero senza arte né parte, le principali offerte di lavoro provengono dalla malavita organizzata, sempre bisognosa di manovalanza a buon mercato, e dall’ambiente dello sfruttamento della prostituzione, a meno di non volersi accontentare di un lavoro nero senza garanzie, della mendicità o di un misero commercio ambulante, che dalla mendicità vera e propria ben poco si distingue. Ma è facile capire come anche queste vie siano anch’esse facile anticamera al delitto! Cosa, dunque, era necessario fare per mettere in moto verso l’Italia l’immensa ondata di spiantati che la sta sommergendo? Occorreva una duplice disinfestazione: una internazionale, volta ad ingannare gente ignorante o, comunque, non al corrente della nostra realtà sociale, presentando, con capillare propaganda, l’immensa menzogna di un’Italia simile a un nuovo Eldorado, un vero e proprio paese di Bengodi; e una all’interno dell’Italia stessa, tendente a fare apparire come un frutto ineluttabile della storia quello che, invece, è l’effetto di una cinica e meditata orchestrazione. A tal fine, con ammirevole improntitudine, si osa parlare di imprescindibili esigenze di mano d’opera nel nostro mercato e di carenza delle nostre forze lavorative, ma su ciò rimandiamo il lettore a quanto si è già detto [numero 220 di Sursum Corda, ndr.]. È chiaro, in ogni caso, che si specula sul fatto che l’uomo moderno, bombardato com’è da effimere notizie, ha memoria corta e il suo senso critico è intorpidito, altrimenti sarebbe facile notare la spaventosa contraddizione di una classe politica che, dopo aver prospettato col “Club di Roma” minacce di tremende crisi alimentari ed energetiche come effetto della sovrappopolazione, e dopo aver legalizzato l’aborto, esaltandolo come un fondamentale diritto civile, aprendo la via allo sterminio dei nostri figli, spalanca ora la porta all’invasione islamica col pretesto che in Italia non c’è più gioventù sufficiente per il funzionamento della nostra economia! In tutto questo piano, la parte avuta dall’ONU è primaria ed evidente. Infatti, la legge Martelli esordisce (art. 1, comma 1) presentandosi come emanata in attuazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che fu appunto promossa dall’ONU, e prosegue riconoscendo a un ufficio della stessa ONU - l’A.C.N.U.R., Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - importanti poteri di ingerenza sulla immigrazione extraeuropea in Italia. Che poi si tratti di un piano su scala soprannazionale, preciso e programmato, lo si ricava anche dal fatto che da più parti si specificano i numeri e i tempi dell’invasione, così come abbiamo visto fare sulle colonne dell’«Alto Adige» del 10 agosto 1989. Ad esempio anche su un articolo de «Il Giornale» del 9 novembre 1989, intitolato «L’Italia deve affrontare la mina vagante degli immigrati di colore», si legge che, entro 20 anni, gli immigrati dovrebbero essere 5 o 6 milioni. Ci si domanda come sarebbe possibile formulare previsioni del genere se si trattasse di un fenomeno spontaneo, imprevisto e imprevedibile, e non di un piano controllato, studiato a tavolino. Similmente il Cardinal Martini [l’eresiarca ormai deceduto, ndr.], dando prova di sorprendenti carismi profetici, intervenendo nel corso di una mattinata di “studio e riflessione” sul tema: «Per una società dell’accoglienza verso un’Europa multirazziale», tenuta in preparazione della IX giornata della solidarietà, proclamata nella sua diocesi, preconizza, a quanto riferisce Daniela Pozzoli sulle colonne di «Avvenire», che il fenomeno toccherà la sua punta massima nei prossimi vent’anni. [Dobbiamo tristemente rilevare che il fenomeno è andato ben oltre e non cessa di esasperarsi sine die, ndr.].
• Ma chi c’è dietro l’ONU? Individuata con certezza nell’ONU l’organizzazione promotrice di questa grandiosa migrazione di popoli, di nuovo genere e che, per dimensioni, non ha precedenti dal tempo delle invasioni barbariche, si tratta ora di vedere cosa si nasconda dietro quella sigla. La risposta è molto semplice: l’ONU è una creazione della massoneria. Nei giorni 28-30 giugno 1917 - e cioè in sul finire della prima guerra mondiale, voluta, appunto, dalla massoneria per distruggere i due imperi, l’asburgico e lo zarista, che ancora serbavano, seppur sbiadita, un’impronta teocentrica e teocratica, e per gettare le basi del Nuovo Ordine Mondiale, e cioè del governo universale da sempre vagheggiato dalle Logge, già adombrato in quel documento base della massoneria che sono le costituzioni di Anderson del 1723 - le massonerie dei paesi alleati e neutrali si riunirono a Parigi, in via Cadet n. 16, e decretarono di costituire la “Società delle Nazioni” che poi, dopo la 2a guerra mondiale, cambiò il nome in ONU. E l’ONU è l’abbozzo del Governo Mondiale massonico. Che la prima guerra mondiale sia stata voluta dalla massoneria e, prima ancora, da chi sta dietro di essa, è un dato certo e inconfutabile: proprio nel Convegno in cui si decise la creazione della Società delle Nazioni, le massonerie intervenute stabilirono le condizioni e gli obiettivi della pace futura, a dimostrare che, al di là e al di sopra dei governi ufficiali, ben altri, ignoti ai “popoli sovrani”, erano i centri di potere che avevano voluto e gestito quel terribile conflitto. Sempre a quel Convegno, la Società delle Nazioni fu definita: «Lo scopo stesso della guerra» (Gianni Vannoni, «Massoneria, fascismo e Chiesa Cattolica», ed. Laterza, 1979, pag. 5). Ora, ci si domanda: chi poteva assegnare uno scopo alla guerra se non chi l’aveva voluta? Molte altre prove si potrebbero addurre. Basti dire che il famoso Gran Maestro della massoneria italiana, Ernesto Nathan (che, in realtà, era un ebreo inglese), in un’ intervista, citata al Convegno massonico di Torino del 24-25 settembre 1988 dallo storico ufficiale della massoneria, Aldo Mola, ebbe testualmente a dire: «La massoneria volle la guerra e ha dato alla guerra tutta se stessa»! (Vedasi la raccolta degli Atti di quel Convegno, sotto il titolo: «La liberazione d’Italia nell’opera della massoneria», Bastogi editrice, 1990, pag. 264). Sono, questi, fatti notori e incontrovertibili, essendo anche stati pubblicati gli Atti di quel Convegno, tanto che il P. Rosario Esposito, il famoso paolino strenuo sostenitore della massoneria, in un suo libro dal titolo «Le grandi concordanze tra Chiesa e Massoneria» (Nardini ed., 1987) a pag. 185, ascrivendo a merito della “sètta” la creazione di quell’organismo internazionale, così si esprime: «Tutto il mondo seppe in quale ambiente (sottinteso: massonico) e sotto quali segni (del pari massonici) la Società delle Nazioni nasceva». Anche recentemente, l’allora Gran Maestro Achille Corona, parlando al Convegno di Torino del 24-25 settembre 1988, così ebbe a dire: «Tuttavia essa (e cioè la massoneria) si pone oggi in prima fila nel processo di unione europea. Lo fa con la consapevolezza di chi ha posto mano per prima alla liberazione dei popoli, alla redenzione delle minoranze, all’avvento della Società delle Nazioni e dell’ONU, e punta ora all’unione europea» («La liberazione d’Italia nell’opera della massoneria», cit., pag. 311). Che poi la massoneria prenda un interesse non solo indiretto - attraverso quella sua creatura che è l’ONU - ma anche diretto alla questione della immigrazione, è stato ancora dichiarato dal medesimo Gran Maestro Corona nel corso del citato suo intervento al Congresso torinese del settembre del 1988: «La massoneria italiana - egli ha detto - ha tutti i titoli per dire una parola saggia e ispiratrice delle nuove minoranze e soprattutto degli immigrati, e, in specie, di quelli di colore, nei confronti delle quali essa ha sentito e sente un legame di autentica fratellanza» (Idem, pag. 309). Di che fratellanza poi si tratti, lo lasciamo immaginare a chi sa qualcosa dello spirito massonico. Similmente in Francia, il B’nai B’rith, e cioè quella somma branca della massoneria che è riservata solo agli ebrei, pubblicò su «Le Monde» del 26 marzo 1986 un comunicato del seguente tenore: «Le associazioni “B’nai B’rith” lanciano un appello alla vigilanza, richiamano l’attenzione dei Partiti della Nuova Maggioranza contro ogni tentazione di voler riprendere gli slogans estremisti sull’insicurezza e le idee xenofobe nei confronti degli immigrati e ricordano ai rappresentanti di questi Partiti gli impegni da loro presi nei corsi dei “forum ” dei B’nai B’rith, davanti alla comunità, dichiarazioni rese dopo la proclamazione dei risultati del voto, di non allearsi in alcun caso col Fronte Nazionale» (Yann Moncomble, «Les professionels de l’antiracisme», Paris, 1987, pag. 251). Da questo comunicato si ricava l’istruttiva notizia che i Partiti di governo francesi hanno assunto il formale impegno, con la massoneria ebraica, che li richiama severamente e pubblicamente all’ordine, di non porre ostacoli all’immigrazione, e che l’unico Partito che vi si oppone, e cioè il Fronte Nazionale, è messo al bando e deve restare isolato come un lebbroso. Davvero strano questo impegno ebraico per una società in cui i gruppi religiosi ed etnici si mescolano e si confondono, ove si pensi che la famosa Golda Meir, già primo ministro dello Stato di Israele, intervenendo in Inghilterra a un seminario di studio della “Zionist Socialist Youth” (Gioventù Sionista Socialista) ebbe a dire: «La grande tragedia dei giovani ebrei nei paesi prosperi è il fatto che essi, per la maggior parte, non comprendono che il più gran pericolo che minaccia l’esistenza dell’ebraismo non proviene dall’antisemitismo e dalla persecuzione, ma dall’assimilazione e dai matrimoni misti» (Idem, pag. 284); e che anche Nahum Goldman, autorevole membro di quello stesso B’nai B’rith che tanto si batte per l’immigrazione extracomunitaria in Europa, ebbe a deprecare come una terribile iattura la minaccia di estinzione, per assimilazione, cui è esposto il popolo ebraico (Idem, pag. 285).
• Accertare lo scopo che la massoneria si propone con questi spostamenti di popoli, non è certo impresa difficile: lo dichiarano, ad ogni passo, i giornali, alti esponenti dei Partiti politici e altri importanti personaggi: al termine dell’attuale processo, si prevede una società “multi-etnica, multi-razziale e multi-religiosa” in cui convivano, si fondano e si confondano, sincretisticamente tra loro, razze, usi, costumi e religioni. Ciò che sorprende e disorienta chi ancora non si è reso conto della doppiezza e della equivocità dei sistemi politici moderni è che, mentre da un lato si lascia intendere che, “regolarizzati” gli extracomunitari, il fenomeno immigratorio verrà praticamente bloccato, e lo si presenta come un evento imprevisto e incontrollabile che ha preso di contropiede il potere politico, dall’altro non si nasconde affatto che quello della società multi-razziale è uno scopo, un programma avuto di mira dai governanti e che, quindi, l’immigrazione è voluta e incoraggiata. In questo ordine di idee, ad esempio, l’amministrazione provinciale di Treviso - come riferisce «Il Giornale» del 9.11.1989, nel già citato articolo: «L’Italia deve affrontare la “mina vagante” degli immigrati di colore» - ha promosso un convegno internazionale, ai cui lavori era previsto l’intervento dei ministri Martelli e Donat Cattin, del sindaco di Milano, Pillitteri, e di Diego Novello, oltreché di autorevoli personalità d’Europa e di America e della immancabile ONU, il cui titolo - «Il nuovo pluralismo culturale e razziale della società europea» - la dice lunga sulle prospettive del fenomeno in esame, evidentemente già previste a tavolino. Giova infatti sottolineare che, in quel Congresso, non erano previste discussioni sui mezzi per bloccare efficacemente il flusso immigratorio anche con opportuni aiuti tecnici ed economici ai paesi del cosiddetto “Terzo Mondo”, bensì, per usare le parole del professor Pavan dell’Università di Padova, uno tra i promotori dell’ iniziativa, si doveva parlare dei metodi per dirigerlo in vista della trasformazione del mondo in un «villaggio globale», in cui si avrà una «fecondazione artificiale delle varie culture». Una operazione ciclopica, insomma, il cui esito programmato dovrà essere la scomparsa della civiltà italiana e di tutte quelle europee, in una broda grigiastra che non sarà né cristiana né islamica, né europea né moresca. Ecco perché si ritiene urgente, per dirla con le parole del rabbino canadese Abraham Feinberg, che «la legge incoraggi la commistione dei sangui», dato che «il richiamo deliberato ai matrimoni interrazziali è la sola maniera di accelerare il processo per eliminare totalmente i pregiudizi razziali e poi le razze separate». Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, in passato abbiamo dedicato diversi approfondimenti alle questioni delle migrazioni, dell’immigrazione, dei migranti e degl’immigrati. Ci sembra opportuno menzionarne alcuni: 1° Exsul Familia Nazarethana in italiano. La Magna Charta di Pio XII sull’immigrazione; 2° Esposizione della dottrina cristiana sulle migrazioni; 3° Teologia Politica 107. Breve dissertazione sulla cosiddetta “immigrazione” (parte 1); 4° Teologia Politica 108. Breve dissertazione sulla cosiddetta “immigrazione” (parte 2). Anche altro è stato pubblicato sul nostro sito ed è possibile raggiungere i contenuti cercando la parola «immigrazione» nell’apposito modulo di ricerca. È altresì possibile consultare l’indice analitico cliccando qui. È stato scritto non tantissimo sull’argomento, tuttavia riteniamo di aver detto quanto basta per avere una solida e rigorosa formazione a riguardo, per approcciare al problema con equilibrio e, Dio volendolo, con sapienza cristiana. L’attualità della materia, invero, ci induce a proporre un ulteriore approfondimento ai Lettori, atteso che una cattiva gestione del fenomeno, o piuttosto dei moti migratori, ha storicamente e sempre prodotto gravi danni alla fede ed alla salute dei singoli, della collettività e di intere Nazioni.
• Nel 1993 l’Editrice Civiltà di Brescia pubblicava l’interessante volume, sotto lo pseudonimo di Giuli Valli, dal titolo «Il vero volto dell’immigrazione. La grande congiura contro l’Europa». Poste alcune premesse e tralasciata la parte meramente filosofica dello scritto, questa sarà la principale fonte del nostro odierno comunicato. Si tratta di un volume arguto e lungimirante, dove l’attento studio della storia passata, dei fatti più recenti e delle cronache contemporanee (all’anno 1990) inducono l’Autore ad elencare una serie di conseguenze - talvolta certe, talvolta probabili - davvero sorprendenti, a tratti preveggenti. Questo libro, scrive l’Autore, vede la luce due anni dopo la sua ultimazione (anni ’90/91). Pur essendo possibili aggiornamenti ed aggiunte, i termini della questione restano sostanzialmente immutati. Ciò che invece, purtroppo, è mutato, è l’atteggiamento degli italiani di fronte alla immigrazione “extracomunitaria”: dopo un primo periodo di sconcerto e di spavento, essi si sono, almeno in parte, assuefatti - quasi si trattasse di un fenomeno inevitabile! - a questo evento grandioso che frattanto va dilatandosi e radicandosi sempre più. Assuefazione e rassegnazione sono proprio le due carte principali su cui punta chi ha causato e tuttora promuove e dirige un processo graduale e, nei limiti del possibile, silenzioso, ma, proprio per questo, tanto più insidioso che, per le sue dimensioni e finalità, non ha precedenti nella storia. Ecco perché questo grido di allarme, per quanto tardivo, ci pare non solo utile ma doveroso!
• Proemio. In Italia, l’evento più vistoso e grandioso del 1989, fatidico anno del bicentenario della Rivoluzione Francese, è stato senza dubbio l’impressionante aumento dell’afflusso immigratorio, proveniente soprattutto dai paesi di religione islamica. Di fronte a questo fenomeno, così imponente che, nel giro di brevissimo tempo, è giunto a sconvolgere l’aspetto delle nostre più antiche città, i cui centri sembrano a volte trasformarsi in vere e proprie casbah, ci è parso necessario proporre agli italiani, travolti dal mare di una propaganda tanto chiassosa quanto mistificante, un saggio che ne descriva gli effetti e ne indichi gli sviluppi e le cause. A tal fine, abbiamo diviso la nostra trattazione in tre parti: nella prima, esamineremo - al di là della menzogna di Stato! - il vero volto della immigrazione e gli effetti immediati della legge Martelli. Nelle successive due, mostreremo al lettore i retroscena, i piani e gli scopi ultimi che si celano dietro a questo sconcertante movimento di popoli.
• Da sempre, le polizie di tutti i Paesi tengono d’occhio lo straniero che entra nel loro territorio, subordinandone la permanenza a permessi e controlli. Le ragioni sono evidenti: lo straniero è quasi sempre uno sconosciuto alla polizia nazionale; potrebbe benissimo, quindi, essere un malvivente che ha gravi conti in sospeso e fugge la giustizia della sua terra; o essere un emissario della delinquenza organizzata che viene a gettare le basi di illeciti commerci; o a tessere le fila di vaste cooperazioni criminose; o essere la spia di una potenza ostile. Un Paese che sopprimesse questi controlli sarebbe destinato a diventare il porto e il rifugio di tutta la criminalità mondiale e la base di ogni losco traffico. Fino alla legge Martelli - anche se, in linea di fatto, negli ultimi tempi le maglie della vigilanza si erano misteriosamente allentate! - l’Italia non faceva eccezione a questa regola e la sua legislazione prevedeva questi controlli al titolo V del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 142-152) e agli artt. 261-271 del relativo regolamento.
• In questo contesto normativo - i cui precedenti, si ripete, sono ultrasecolari, risalendo a ben prima dell’unità d’Italia - in un momento in cui la criminalità dilaga e si organizza, specialmente in relazione al traffico della droga e delle armi, e le sue fila proliferano mostruosamente e si estendono e si infittiscono avvolgendo tutto il globo in una malefica ragnatela, si è abbattuta, con fulminea rapidità, la legge Martelli. Il contenuto di questa legge è addirittura rivoluzionario. Essa, infatti, al suo articolo 13, demolisce la quasi totalità delle norme del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in materia di controllo sugli stranieri, rende l’espulsione di costoro estremamente difficile e farraginosa, consentendo persino il ricorso - contro i provvedimenti prefettizi in tal senso, e contro il diniego di rinnovo del permesso di permanenza - ai tribunali amministrativi, con l’elevatissimo rischio di paralizzare e di schiacciare quegli organi di giustizia sotto il peso di un contenzioso smisurato, rendendo loro impossibile ogni altra attività a tutela degli interessi dei cittadini. Il sicuro esito di questa opzione legislativa sarà quello di differire, a termini imprevedibili, l’esecuzione dei provvedimenti di espulsione. Occorre poi tener presente che, essendo gli stranieri, il più delle volte, privi di fissa dimora, le sentenza di espulsione sarebbero destinate a restare, nella gran maggioranza se non nella quasi totalità dei casi, inutili, essendosi l’interessato, nel frattempo, trasferito altrove senza lasciare tracce anagrafiche e quindi rendendosi, in tal modo, praticamente irreperibile. È opportuno aggiungere che, mentre in precedenza, per l’espulsione e l’accompagnamento al confine, era sufficiente una condanna penale per qualsiasi reato non meramente contravvenzionale, ora, invece, occorre che si tratti di una di quelle fattispecie criminose di particolare gravità. Lo smisurato allargamento del concetto di “rifugiato politico”, divenuto ormai evanescente e incontrollabile, apre ulteriori, immense falle alle frontiere e nei controlli. In definitiva, si sono abbattuti i precedenti filtri e barriere per sostituirvi una normativa che offre una protezione volutamente illusoria e inconsistente, e ciò proprio nel momento in cui, di fronte a un’immigrazione torrenziale, massimo sarebbe il bisogno di un vaglio rigoroso e di un efficace controllo.
• Quale sarà e, anzi, già in gran parte sia stato il risultato immediato (anno 1990) di questa inaudita apertura delle frontiere, dovrebbe risultare evidente, al di là delle declamazioni retoriche e dei pilotati sentimentalismi, anche ai più sprovveduti. Il primo e più evidente effetto non può essere che la proliferazione della criminalità: questa massa di immigrati, privi di lavoro e sradicati dal loro contesto sociale, trasferita in un paese che non è in grado di offrire una sistemazione a tutti i suoi figli al punto di avere un tasso di disoccupazione superiore al 10%, non può che fornire manovalanza al delitto, e in particolar modo alla droga, alla prostituzione e al relativo sfruttamento. Persino il periodico dei missionari comboniani, «Nigrizia», (che pur si batte con sconcertante accanimento per un’immigrazione illimitata e indiscriminata!) si lascia sfuggire importanti ammissioni in tal senso: sul numero 46 dell’ottobre 1989, in un articolo intitolato: «Ero in carcere e sei venuto a trovarmi», Giuseppe Caramazza, passando in rassegna casi individuali, riconosce che un certo Ahmed, da lui conosciuto in una casa di pena, e che presenta come un caso paradigmatico, «dopo decine di notti trascorse alla stazione centrale o in macchine abbandonate, è inevitabilmente finito nel giro dell’hashish», dove quell’«inevitabilmente» la dice assai lunga... In relazione alla famosa strage di Castelvortuno del 24 aprile 1990 il «Resto del Carlino» scrive: «Certo, ora la faccenda si complica se anche gli sbandati dell’immigrazione vanno a ingrossare gli eserciti della mafia, della ‘ndrangheta e della camorra. Era così difficile prevederlo?». A pag. 3 narra: «L’idea di reclutare anche manovalanza di colore era venuta al ragioniere Pasquale Scotti, il pluriomicida luogotenente di Cutolo». Giorgio Bocca, famoso giornalista di regime, scrivendo sul numero dell’11 marzo 1990 de «L’Espresso», settimanale assai prossimo a quel Partito Socialista che, nello schieramento politico, è l’alfiere più acceso dell’apertura delle frontiere, così scrive a pag. 17: «Dalle notizie sparse nelle cronache italiane veniamo a sapere che il numero degli immigrati che spacciano droga è in continuo aumento e che le loro casbah diventano sempre meno frequentabili. A Torino, i vigili urbani che si avventurano nel quartiere di Marassi, in riva al Po, possono trovarsi circondati da spacciatori armati di spranghe e di bottiglie rotte...», prosegue preconizzando un inevitabile conflitto etnico, e così conclude: «La pervicacia con cui i nostri grandi partiti, i nostri politici, legiferano sempre in astratto, senza mai tener conto di quello che poi immancabilmente avviene nella pratica, diffonde sospetti: ci si chiede: “ma quali interessi ci saranno dietro questa permissività verso gli immigrati? ”». È proprio quello che ci siamo chiesti anche noi; ma, prima di passare a questa indagine, ci preme esaurire, sia pure trattandola per sommi capi, la rassegna degli effetti prossimi e remoti di una vicenda che, giorno per giorno, assume dimensioni vieppiù grandiose e inquietanti.
• L’articolo 9, comma 2 della legge Martelli contiene una disposizione che definire incredibile è dir poco: essa prevede, infatti, che l’“extracomunitario” sprovvisto di documenti possa “regolarizzare” la propria posizione sulla base di un’attestazione della sua identità, resa da due persone incensurate aventi la cittadinanza italiana e, persino, da altri due stranieri soggiornanti in Italia da almeno un anno, appartenenti allo Stato dell’interessato. Non è chi non veda come, in tal modo, il più incallito dei killers professionali o dei trafficanti di droga possa ricrearsi una verginità in Italia, fregiandosi di un nome nuovo e immacolato con la compiacente o addirittura complice, e comunque incontrollabile, dichiarazione di due mentitori, magari prezzolati per l’occasione, o stabilmente al soldo di qualche associazione criminale. L’Italia diventerà, in tal modo - e forse lo sta già diventando! - il rifugio della delinquenza mondiale: affluiranno ad essa malviventi dai paesi d’Europa non appartenenti al Mercato Comune, dalle Americhe, dall’Africa e dall’Asia, promuovendola a centro dei loro loschi traffici ed intrighi, a “City” delle multinazionali del crimine. Ciò consente e consentirà l’ingresso in Italia di interi battaglioni di manovali e di “boss” del delitto; va anche detto che questa disposizione riproduce l’analogo art. 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, che già poneva questo assurdo principio e i cui termini sono stati prorogati ben quattro volte, e precisamente coi decreti legge 27 aprile 1987, n. 154, 27 giugno 1987 n. 242, 28 agosto 1987 n. 353, e con la legge 16 marzo 1988 n. 81.
• È, allora, assai ragionevole ritenere che la prossima, prevedibilissima, “sanatoria” conterrà un’identica statuizione e la malavita, nazionale e mondiale, che ben conosce queste incredibili falle periodicamente offerte da una legislazione suicida, certamente fa conto sulla periodicità di siffatti provvedimenti e predispone, di conseguenza, le proprie mosse e le proprie pedine. Senza contare che, a prescindere dalle regolarizzazioni formali, a un determinato livello di caos, certo già largamente raggiunto, sfuggita la situazione di mano alla polizia, ogni efficace controllo diventa impossibile. È da notare che, proprio perché il fenomeno immigratorio è incontrollato, e, di conseguenza, gli immigrati sono ignoti agli uffici anagrafe italiani, nulla impedirà, a chi sia stato scoperto a commettere delitti anche dopo aver acquistato una nuova identità, di fuggire in un’altra città italiana, dandosi un terzo nome, e così via, ricominciando sempre daccapo. È quanto in concreto sta già accadendo (anno 1990), come narra il pur ultra “progressista” settimanale «L’Europeo» del 17-28 aprile 1990, sotto il titolo: «Qui polizia, siamo circondati» - sottotitolo: «Gli arresti? Impossibile quando una volante è sola contro 60 persone. Le espulsioni? Inutili. I fogli di via? Inefficaci. Le pattuglie raccontano», impressionante documento sullo stato di impotenza cui i nostri governanti hanno ridotto la forza pubblica di fronte al sorgere di uno Stato nello Stato, inaccessibile ai nostri poliziotti e le cui leggi sono quelle commiste dell’Islam e della mafia, del traffico di droga e della prostituzione. In quel servizio, il succo della “sanatoria” Martelli è così riassunto nelle efficaci parole di un agente di P.S. milanese: «Noi importiamo delinquenza di terzo mondo come materia prima, gli diamo una nuova nazionalità, cioè quella italiana, e riesportiamo questa delinquenza in Europa... la malavita italiana sta creando una vera e propria organizzazione per importare gli spacciatori tunisini: gli insegna a riciclare i documenti falsi o a “lavare” i propri, se sono pregiudicati». (Vedere lo stelloncino intitolato «Il gioco delle identità» a pag. 15 della citata rivista). Dove si vede che, grazie al Governo e al Parlamento, sono state create una scuola e un’industria del crimine con molte migliaia di dipendenti e vasti quadri dirigenziali!
• È inevitabile che l’incremento nel commercio della droga comporti anche un incremento del relativo consumo, onde è evidente e sicuro che i nostri figli, già così sviati e pericolanti, saranno ancor più insidiati e travolti dalla malefica seduzione di quel terribile vizio auto-distruttivo che è fonte e occasione di ogni altra forma di criminalità. Poiché, poi, droga e prostituzione vanno a braccetto, è questo il momento per ricordare che le donne di colore immigrate in Italia rivelano una tanto preoccupante quanto diffusa tendenza a darsi alla prostituzione, e ciò non solo come risultato di credenze religiose che, a partire dall’Islam, sono prive di un serio contenuto morale, ma anche perché loschi personaggi, evidentemente inquadrati in associazioni operanti su scala internazionale, adescano nei paesi d’origine ragazze spostate, indirizzandole verso l’Italia con false promesse di lavoro e speculano poi sulla loro disperazione non appena, lontanissime dalla terra natale e senza più mezzi per rientrarvi, si accorgono che quelle promesse erano solo turpi menzogne. Sono, questi, fatti ben noti e sempre più sotto gli occhi di tutti, ma poiché prevediamo inevitabili accuse ed ingiurie da parte dei soliti “mass-media” di regime, ci pare opportuno citare un altro periodico - «Epoca» - che è innegabilmente una delle voci più autorevoli della stampa periodica “laica” e “progressista” del nostro paese. Sul numero del 22.10.1990, quel settimanale dedicava un ampio e documentato servizio a questo argomento, scritto da Maria Giulia Minetti e intitolato: «Io, prostituta nera». Le parole con cui questo articolo si apre, già rendono chiara l’idea dell’importanza e delle proporzioni di questo aspetto dell’immigrazione: «Arrivano a migliaia, deportate (si noti il vocabolo, assai significativo! ndA.) sui marciapiedi di tutta Italia: Torino, Livorno, Firenze, Modena. .. Analfabete o laureate, professioniste o principianti, le nigeriane sono vittime di uno sfruttamento inesorabile e di due complici: mafia del Ghana e razzismo all’italiana». Bisognava pur tirarlo fuori questo benedetto razzismo! Quindi andare con una negra sarebbe razzismo, mentre andare con una caucasica che sarebbe? Anti-razzismo? Più oltre, narrando le vicende, invero paradigmatiche, di una di queste sventurate, l’articolista riferisce che non appena costei giunse in Italia, attirata da ingannevoli miraggi fattile balenare da tenebrosi individui, svanirono di colpo tutte le promesse, e le fu brutalmente detto: «L’unico lavoro è battere»! A questo punto ci si domanda: forse che il Governo queste cose le ignora?
• E come potrebbe ignorarle esso che riceve le notizie provenienti da tutte le questure d’Italia? Al riguardo, ci sembra comunque molto significativo riportare un passo della Circolare del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1985 n. 559/443/ 225388/2/4/6, che affrontava il problema quando era ben lontano dal raggiungere l’attuale gravità: «I falsi turisti, per buona parte provenienti da paesi del Terzo Mondo, in particolare dal Medio Oriente, dall’Africa, dal Sudamerica e da qualche Stato dell’Asia, una volta entrati, rimangono nel territorio della Repubblica quasi sempre omettendo di rendere la dichiarazione di soggiorno e vanno ad ingrossare le file dei lavoratori clandestini - molto spesso manovrati da spregiudicati specialisti del settore del lavoro nero - e vivono nell’illegalità, facile preda di malviventi, dediti a traffici di droga, alla prostituzione e alla criminalità organizzata, comune e politica. Basti porre in evidenza che i detenuti stranieri costituiscono oltre il 10% della popolazione carceraria in Italia (il dato è del 1990, nel 2019 la percentuale sale ben oltre il 30%, ndR.). La situazione sopra esposta si è andata addirittura aggravando da un paio d’anni a questa parte...». Che il Governo sia perfettamente al corrente della situazione risulta chiaro anche dalle autorevolissime dichiarazioni rilasciate dal capo della Polizia di Stato, prefetto Vincenzo Parisi, in un’intervista riportata su «Epoca» del 25 marzo 1990, sotto il titolo: «La polizia vede nero». Nel corso di essa, quell’altissimo funzionario, pur dichiarandosi favorevole alla legge Martelli (e, dato il posto, potrebbe essere altrimenti?), riconosce che, ad esempio, sono da riferire agli “extracomunitari” il 50% degli atti criminali commessi nella città di Firenze. Il che significa che in quella grande città, grazie alla nuova normativa, la delinquenza che, come meglio vedremo in seguito, già aveva raggiunto in tutta Italia livelli inauditi e terrificanti, è aumentata del 100%, dimostrando così l’enorme tasso delinquenziale che si registra tra gli immigrati. C’è da chiedersi che sarà domani, quando il loro numero sarà cresciuto e, col tempo, le radici di questa nuova delinquenza avranno avuto modo di meglio ambientarsi, ramificarsi ed estendersi. (L’Autore ci aveva visto benissimo, basti pensare a cosa sono diventate oggi le nostre città, ndR.).
• Droga e prostituzione, oltre ad essere il terreno ideale su cui attecchiscono tutti i delitti, rappresentano anche, come è a tutti noto, il brodo di coltura in cui proliferano e si propagano le peggiori malattie, e in particolare quel terribile AIDS che costituisce l’incubo dell’umanità alle soglie del 2000. Tanto più che, come è stato sottolineato alla IV Conferenza internazionale sull’AIDS in Africa, tenutasi a Marsiglia tra il 18 e il 20 ottobre 1989, proprio in Africa, da cui proviene la massima parte del flusso immigratorio, quel morbo ha raggiunto punte paurose che pongono inquietanti interrogativi sul futuro dell’umanità in quel continente (Cfr. «Nuova Solidarietà» del 11.11.1989). (A proposito di AIDS: avete notato che da qualche anno, ovvero da quando è stato deciso che ogni freno all’immigrazione incontrollata deve essere annientato, l’AIDS non esiste più? Non se ne parla più: i TG lo hanno dimenticato. Come, sempre gli smemorati della stampa di regime, non hanno mai parlato di COVID 19 e Africa. Lì il Corona Virus è come se non esistesse. Scappano dalla povertà e dalla sporcizia ma non hanno il Covid. Tutto questo è molto strano!, ndR.). Ma se l’AIDS è la più temuta e pericolosa, non è tuttavia l’unica malattia che viene incrementata dall’ondata degli “extracomunitari”. È lo stesso Francesco De Lorenzo, Ministro della Sanità del Governo, che ha voluto la legge Martelli, a riconoscere che, «secondo dati recenti forniti dall’Istituto Superiore di Sanità, si sono registrati aumenti di malattie infettive che sembravano debellate, come la TBC, e di malattie veneree». Secondo il Ministro, gli immigrati possono essere veicolo di diffusione di queste malattie («Famiglia Cristiana» n. 3 del 1990). Naturalmente, quel personaggio ne trae spunto non già per un ritorno alla legislazione precedente, bensì per promuovere l’accesso gratuito degli immigrati ai servizi sanitari, con condizioni addirittura di privilegio rispetto agli italiani. È naturale pensare alle conseguenze che ineluttabilmente scaturiranno da una simile scelta e da questo incremento della più grave morbilità.
• Per quanto riguarda questo altro gravissimo aspetto della questione, ci pare opportuno richiamare l’attenzione del lettore sullo stato di confusione delle idee che regna anche e principalmente nel campo cosiddetto “cattolico”, riportando le parole di un rappresentante della Caritas italiana, Pino Giulia, testualmente riferite nel citato servizio su «Famiglia Cristiana»: «Così come è stata espressa dai ministri, questa norma sembra rivolta soprattutto a tutelare la salute degli italiani dal possibile contagio e non quella degli immigrati. Mi sembra un vecchio pregiudizio...». A parte l’assurdità e la vacuità di questo processo alle intenzioni, non può non sorprendere chi non abbia smarrito tutti i parametri del buon senso e della vera morale questo presentare come se fosse una grave colpa e non, invece, il primo dei doveri del Ministero della Sanità Italiano una presunta (anche se, ahimè, inesistente) tutela della salute degli italiani. Nello stesso distorto ordine di idee, affrontando la questione in termini più generali, sulla rivista dei missionari comboniani «Nigrizia» dell’ottobre 1989, Mario Marazziti scrive: «La cosa peggiore che potrebbe accadere è che il dibattito su cosa fare per tutelare gli stranieri in Italia si trasformasse praticamente in cosa fare per tutelare gli italiani dagli stranieri».
• Quello che più sorprende quando si affronta il problema degli “extracomunitari” è la sconcertante superficialità, per non dire incoscienza, di chi considera con aria spensierata e ottimistica un afflusso immigratorio di milioni di persone; eppure da anni e anni i giornalisti riportano le notizie degli scontri e delle stragi che costellano la convivenza nell’Irlanda del Nord di due gruppi etnici, pur appartenenti alla stessa razza, in un clima, a volte, di vera e propria guerra civile. In tutto l’impero sovietico, non appena è stato allentato il freno della spietata tirannide bolscevica, che occultava ma non sopprimeva i conflitti, sono subito scoppiati ovunque torbidi di origine etnica con massacri e vere e proprie battaglie. Anche in Romania, nella regione della Transilvania, si è registrato un aspro scontro con morti e centinaia di feriti tra rumeni e ungheresi, scontro che era latente ai tempi di Ceaușescu e che questi si proponeva di risolvere con la deportazione in massa dei magiari. Tutto ciò accade nell’ambito di quell’Europa su cui, è ben vero, ha soffiato a lungo la bufera della riforma protestante e, sulla sua scia, quella del liberalismo e dei nazionalismi, ma che pure è stata anche più a lungo unificata dall’idea cristiana e da quella di impero cristiano. Pure in Spagna il movimento indipendentista basco ha creato e crea gravi problemi di convivenza; ed è sulle pagine di tutti i giornali l’orribile macello che si sta consumando, sotto lo sguardo sornione dell’ONU, proprio ai nostri confini, nel territorio della ex Repubblica Jugoslava. Ebbene, pare incredibile che tanti italiani si sentano superiori a questi problemi quando un’esigua minoranza di meno di 300.000 subtirolesi ha creato e crea da decenni al Paese gravi difficoltà interne e internazionali con uno stillicidio di attentati non di rado sanguinosi, mentre in tutto il territorio altoatesino la vita si svolge in un clima di tensione e di reciproche rivendicazioni. Ciò, si badi bene, tra genti della stessa razza, della stessa religione, per di più, avezze a secoli di convivenza, essendo stato il Trentino, per lungo tempo, soggetto all’Impero asburgico, e l’odierna provincia di Bolzano, il principale punto di incontro commerciale, culturale e linguistico tra popolazioni italiane, retiche e germaniche, come antichi e illustri monumenti documentano e attestano.
• È poi noto a qualunque studente di primo liceo - e la Storia è lì ad insegnarcelo! - che anche per il passato genti di religione diversa, e quindi di princìpi e costumi morali e giuridici del pari diversi, non hanno quasi mai convissuto pacificamente: l’aspetto più grave delle invasioni barbariche fu proprio la differenza di religione tra i barbari, idolatri o eretici ariani, e le popolazioni dell’impero, cattoliche. Solo per l’opera assidua dei missionari, promossa soprattutto dal Santo Papa Gregorio Magno - ricordate la famosa conversione della regina Teodolinda, cui seguì quella del marito, Agilulfo, che segnò l’inizio della pacificazione tra romani e longobardi? - si conquistarono i barbari alla luce del cristianesimo e fu possibile rifondare l’unità spirituale dell’Occidente che, uscito dai conflitti intestini, assunse nuovamente la funzione di guida della civiltà. Solo così, infatti, fu resa possibile l’incoronazione di Carlo Magno da parte del Papa Leone III, in quella notte di Natale dell’830, che segnò davvero, nel nome di Gesù, il natale dell’Occidente cristiano. Ma il problema che presenta l’immigrazione è particolarmente grave non solo per le differenze, enormi invero, di razza, di lingua, di costumi e di religione, ma anche per la particolare religione che professa la gran maggioranza di questi immigrati. Si tratta, infatti, in prevalenza, di islamici ed è, o almeno dovrebbe essere, a tutti noto quale sia la selvaggia violenza dell’Islam e il suo odio per il nome cristiano: una serie di torri e di altre fortificazioni, dal nord al sud dell’Italia, ricorda le scorrerie sanguinose dei predoni barbareschi che terrorizzarono per secoli e secoli le popolazioni costiere della nostra penisola, quando il grido “I turchi!”, rimasto ancor oggi proverbiale (chi non conosce l’interiezione romanesca “Mamma, li turchi”?), faceva balzare dal letto col cuore in gola adulti e fanciulli e gli uomini validi che si precipitavano alle armi per respingere l’aggressore e vendere cara la vita evitando a sé, alla moglie e ai figli di venir tratti prigionieri e venduti all’asta sui mercati di schiavi in terra moresca. Non si leggono più sui libri di storia - tanto per citare qualche esempio -il massacro spaventoso dell’intera popolazione di Otranto e le vicende secolari di Venezia, dall’assedio di Negroponte, la cui popolazione fu sterminata e il cui comandante, Paolo Erizzo, fu tagliato in due, alla guerra di Cipro e all’espugnazione di Famagosta, il cui valoroso capitano, Marcantonio Bragadin, dopo due settimane di continue ed orrende sevizie, fu scorticato vivo per non aver voluto abiurare la sua fede in Cristo? Per non parlare della Spagna, dove il conflitto tra cattolici e musulmani si protrasse per circa 8 secoli, fino alla caduta del regno arabo di Granada nel 1492, con strascichi di sanguinosa guerra ancora nel tardo ‘500, sotto il regno di Filippo II.
• Ma, obietterà qualcuno, sono fatti ormai antichi: oggi, l’atteggiamento dell’Islam nei confronti dei cristiani è cambiato in meglio. Nient’affatto! Solo le grandi sconfitte della mezzaluna, dall’assedio di Vienna in poi, hanno costretto quelle genti a desistere dal loro programma di sottomettere l’intera Europa al giogo islamico, ma là dove ne hanno la forza (per esempio in Africa dopo l’estinzione, de facto, del missionariato cattolico, ndR.), la via da percorrere rimane sempre quella: aggressione, strage e asservimento! Forse che nel Libano non ci fu un vero e proprio genocidio nei confronti della popolazione cristiana cattolico-maronita? Nella primavera del 1975, parlando con il primo ministro libanese islamico, Yasser Arafat, che fu poi ricevuto con onore da Wojtyla, ebbe a dire tra l’altro: «Farò di Beirut la Stalingrado numero 2... che il sangue scorra fino alle ginocchia, a Beirut! Che il Libano divenga un fiume di sangue! Io Yasser Arafat, non ci vedo nessun inconveniente»! (Bernardo Cervellara, «Libano la pace futura» - ediz. EMI, Bologna, 1988, pag. 39. Si noti che il libro è opera di un missionario del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere, e reca la prefazione di Giulio Andreotti, l’allora presidente del Consiglio dei Ministri che ha voluto le legge Martelli!). E non solo a Beirut: a Damour, città cristiana, oltre 3.000 cristiani vennero trucidati, dopo tre giorni di assedio, nel gennaio 1976, tra il complice silenzio di tutta la stampa occidentale (id., pag. 41); a Baalbek, un tempo interamente cristiana, vi sono ora solo 300 fedeli; quella città è diventata la centrale degli hezbollah, i fanatici sciiti dello ayatollah Khomeini (id., pagg. 54-55). Nel villaggio di Haush Barada, i cristiani sono stati tutti massacrati (id., pag. 57): «Uomini e donne sgozzati come agnelli, interi gruppi fucilati, giovani scomparsi» (id., pag. 67). Questa è la storia della presenza e dell’azione islamica nel Libano, nella (perfida) era di Assisi e dell’ecumenismo! Dietro a tutto questo, è ben vero, c’è la spregiudicatezza sanguinaria di Israele e dell’ebraismo internazionale - tra i principali esponenti figura il ministro USA Henry Kissinger! - che soffiano sul fuoco per neutralizzare i possibili avversari, estinguere gli odiati cristiani ed estendere il territorio israeliano fino alle ambite acque del fiume Litani, attualmente sotto sovranità libanese (id. pag. 76, 78-81, 85), ma ciò non toglie che la religione islamica si presti straordinariamente a queste perfide manovre. (A proposito dell’ebraismo internazionale facciamo menzione ad alcuni approfondimenti già pubblicati su Sursum Corda: 1° Teologia Politica 132. Il «Movimento Sionista» parte prima; 2° Teologia Politica 133. Il «Movimento Sionista» parte seconda; 3° Papa San Pio X e la Chiesa contro il Sionismo. Così concludevo il sofferto studio: «Anno 2018: da oramai settant’anni la Palestina non conosce tregua e la pacifica comunità cristiana, un tempo dinamica e numerosa, è ridotta a poco più dell’1%. Prima del 1946 era circa il 10%», ndR.). Sono ancora negli occhi e nelle orecchie di molti le stragi di armeni cristiani in Azerbaigian e, sebbene non se ne parli quasi, anche in Sudan è in corso da ben 33 anni una guerra sanguinosa che contrappone gli islamici arabi del nord alla popolazione nera, cristiana e animista, del sud del paese; (se ne veda una breve ma eloquente sintesi su «Avvenire» del 27-2-1990). Etc, etc etc ...
• Anche il pericolo rappresentato dal credo religioso, che legherà fatalmente gli “extracomunitari” islamici, e cioè la maggioranza assoluta degli immigrati, in una coalizione ostile agli italiani, non è affatto ignoto ai più accesi fautori della politica delle porte aperte. Sul numero 3 di «Famiglia Cristiana» del 1990 leggiamo infatti: «Questo maggior attaccamento (dei maomettani alla loro religione) diventa talvolta aggressività e tendenza all’ egemonia... lo si vede anche quando i musulmani diventano la maggioranza all’interno di una comunità di accoglienza: per gli altri ospiti non ci sono più spazi. È il virus del fondamentalismo che contagia fasce sempre più consistenti del mondo islamico e sbarca con gli immigrati anche in Italia». E invero, nell’affrontare il problema dell’immigrazione ci si domanda come sia possibile non tener presente la potenzialità dirompente dell’Islam che, nella nostra epoca, ha abbracciato il tipo di guerra che meglio si confà ai suoi uomini, poco idonei ai conflitti in campo aperto tra eserciti organizzati: il terrorismo, le cui più potenti organizzazioni portano il suo sigillo. In queste condizioni, spalancare le porte all’invasione islamica equivale a dar via libera a prevedibili stragi. (Ricordiamo che l’Autore scrive nel 1990 ed ipotizza molto bene quello che sarebbe accaduto ndR.). Il nostro Governo, coi suoi servizi di informazione, può ignorare ciò che nelle sue linee generali è evidente a chiunque abbia seguito le vicende del terrorismo in questi anni? Ma se queste cose sono note ed evidenti, si domanderà sconcertato il lettore, perché la classe politica non alza solide barriere normative e poliziesche? Ha forse ragione Giorgio Bocca quando si chiede quali tenebrosi interessi ci siano dietro a questa permissività verso gli immigrati? È quanto tenteremo di svelare più avanti in questo nostro lavoro. Infine, poi, tratteremo l’aspetto più inquietante della questione: quello dell’atteggiamento della pretesa Gerarchia ecclesiastica di fronte al fenomeno. Ma proseguiamo con ordine.
• Dopo aver aperto, con la legge n. 39 del 1990, le cateratte dell’immigrazione incontrollata, lo stesso Martelli, che di quella legge è stato il padre ufficiale, con quell’assoluto disprezzo per la perspicacia degli italiani, che costituisce una delle caratteristiche salienti della nostra classe politica, ha lanciato la grande campagna propagandistica della mobilitazione dell’esercito e della marina, quasi che fosse agevole pattugliare, per giunta con una marina come la nostra ridotta ai minimi termini, le migliaia di chilometri delle nostre coste. In realtà, è evidente che la vigilanza va bensì esercitata, peraltro senza mobilitazione alcuna, ai valichi e ai porti, ma, e specialmente in una situazione come l’attuale, anche e soprattutto all’interno, controllando chiunque si abbia motivo di ritenere che possa trovarsi in posizione irregolare, colpendo con sanzioni penali e rispedendo i clandestini ai paesi d’origine su navi a ciò destinate, dopo averli isolati e custoditi in appositi campi, così come si è sempre fatto con i profughi provenienti dai paesi dell’Est Europa. E a che serve, poi, se non a gettar fumo negli occhi, rinforzare i posti di frontiera e i pattugliamenti delle motovedette, quando, per effetto della nuova legislazione, si può legalmente entrare in Italia con qualsiasi pretesto e l’estromissione degli intrusi che vi si trattengono oltre i limiti del permesso di soggiorno è diventata un’impresa sovrumana?
• Chi sottolinea l’eccezionale gravità del problema dell’immigrazione si sente assai spesso rispondere che si tratta di una necessità imprescindibile per la nostra economia, perché ci sono molti lavori tra i più umili, che gli italiani non vogliono più svolgere e per cui è indispensabile l’apporto di mano d’opera straniera. Che in qualche caso ciò sia esatto, non lo si nega, ma si tratta di situazioni marginali se è vero, come è vero, che le statistiche denunciano che il tasso di disoccupazione in Italia è il più alto fra i paesi industrializzati (cfr. «Avvenire», 8-5-1990 sotto il titolo «E l’Italia conquista il primato della miseria») e che la stampa ci informa che sarebbe ripresa l’emigrazione dal nostro Meridione (cfr. «Avvenire» del 6-5-1990 sotto il titolo «Sud senza lavoro, riprende l’emigrazione»). D ’altro canto se, invece di bere a garganella le panzane della propaganda di regime, ci si limitasse a credere ai propri occhi, ci si accorgerebbe che torme innumerevoli di africani (i cosiddetti “Vu’ cumprà”) passano il loro tempo stendendo tappeti e vendendo accendini, musicassette (contraffatte), borsette di cattiva qualità e paccottiglia varia. Ci si domanda: davvero l’Italia aveva un così urgente bisogno di gente dedita a questo genere di lavoro? Davvero senza questi venditori di cianfrusaglie la nostra economia andrebbe in rovina? Ben sapendo che questa è l’attività lavorativa più diffusa tra gli “extracomunitari”, (non parliamo qui di quelle turpi o illecite: dalla prostituzione alla droga!), il Governo, all’art. 10 della legge Martelli, ha previsto la concessione di licenze di commercio agli immigrati, a condizioni agevolate rispetto a quelle richieste per gli italiani, che si vedono così passare avanti i nuovi arrivati. Chi conosce e ama il nostro dissanguato e derelitto Meridione - alla mercé della malavita organizzata e con servizi pubblici da “terzo mondo”, abbandonato da uno Stato presente e attivo solo quando si tratta di estorcere imposte e tangenti e di mendicare voti! - e ha davanti agli occhi le miserie di Napoli, dove c’è ancora chi campa stentatamente la vita facendo il lustrascarpe, o vendendo qualche pacchetto di sigarette di contrabbando, e dove, comunque, il piccolo commercio ambulante costituisce una risorsa di vita di primaria importanza, mentre intere famiglie si stipano in “bassi”, bui e malsani, non può non provare un senso di ribellione di fronte a questi discorsi di necessità di mano d’opera straniera. Ciò che soprattutto indigna sono le massicce e ingiustificate agevolazioni per l’ammissione degli immigrati all’ambulantato (quanti extracomunitari contendono, per le vie di Napoli, l’esiguo pane ai locali!), e gli incredibili progetti di affidare a costoro addirittura migliaia di posti pubblici. Basti pensare al clamoroso programma governativo di assumere oltre 30.000 extracomunitari come personale infermieristico. Tale programma è rientrato, in seguito alle reazioni, ma, come tutti sanno, col nostro regime non si può mai stare sicuri! Comunque, il tentativo è segno inequivocabile di una precisa volontà politica, diretta ad agevolare in ogni modo una stabile e cospicua immissione di “extracomunitari”, persino nel delicato settore pubblico, a prescindere dalle evidenti difficoltà linguistiche.
• Aggiunge l’Autore nella nota 1 a pag. 33: Da quando scrivevamo queste parole, fatti nuovi sono intervenuti: il timore che esprimevamo due anni fa, dicendo che col nostro regime non si può stare mai sicuri, ha trovato puntuale conferma. Il Ministro De Lorenzo ha dato il via all’assunzione di migliaia di “infermieri” extracomunitari, lanciando verso gli oppositori l’invettiva di prammatica, al coperto della quale le più assurde iniziative diventano lecite e persino nobili: «E se a qualcuno non va bene, è un razzista!» (cfr. «Corriere della sera» del 15-5-1991). Altamente infischiandocene di questi trucchi e anatemi di regime, dove lo slogan e la parola esorcizzatrice tengono il posto della ragione, osserviamo, senza mezzi termini, che l’ospedale è un’istituzione peculiare dei popoli cristiani, presso cui è cominciata a sorgere subito dopo l’editto di Costantino e che l’hanno esportata in tutto il mondo. Ci sia consentito dire che non siamo affatto tranquilli nell’affidare le vite nostre e dei nostri cari in mano a stranieri provenienti da terre ove la vita non è stimata, ove spesso la stregoneria tiene il posto della medicina e, comunque, ove il nome cristiano è odiato e la pratica della carità sconosciuta. Senza contare che dubitiamo fortemente del valore dei diplomi del Burundi o del Botswana e anche di quelli dell’Algeria o del Marocco. Ci domandiamo, in ogni caso, come sia possibile verificare la genuinità di quei diplomi, scritti per giunta in lingue straniere ignote a tutti i nostri funzionari, una volta che - come si è visto - la legge Martelli rende impossibile l’accertamento delle identità degli immigrati. Aggiungiamo che, come molti, forse, ricorderanno, le assunzioni di infermieri presso gli ospedali italiani furono bloccate per anni. È forse temerario avanzare il sospetto che con quel blocco e col cattivo trattamento economico riservato al personale ospedaliero si stesse preparando, alla lontana, l’attuale manovra? (correva l’anno 1991, ndR.). Va in ogni caso rilevato che la motivazione addotta per giustificare quelle assunzioni in massa, e cioè l’affermazione che in Italia non sarebbe reperibile sufficiente personale sanitario altamente specializzato, onde occorre cercarlo nel campo dell’immigrazione extracomunitaria, appare talmente amena che il fatto che si sia trovato il coraggio di proporla appare sbalorditivo!
• Del resto, chi non capisce che il lavoro “nero ”, sottopagato e irregolare, prestato da taluni immigrati, se, da un lato, fa di costoro degli sfruttati, dall’altro sottrae il posto alle giovani leve italiane, afflitte dallo spettro della disoccupazione? Si registrano, poi, massicci interventi assistenziali, anche a prezzo delle Regioni, con somministrazione di sussidi per il raggiungimento del cosiddetto “minimo vitale”, con interventi nel campo dell’edilizia abitativa ecc. Ci si domanda soltanto se ciò sia giusto in un paese in cui i giovani non possono sposarsi perché non trovano casa e in cui, secondo i dati ISTAT (v. «Famiglia Cristiana» n. 3 del 1990), ben oltre sei milioni di persone percepiscono la pensione minima o sociale, e il 70% di costoro dichiara di non avere altri mezzi di sostentamento, mentre anche le pensioni artigianali, agricole e commerciali sono a livelli di fame! Non deve forse un padre provvedere prima di tutto ai propri figli? È lecita una beneficenza, fatta a “terzi”, quando i propri familiari versano in condizioni di grave o addirittura gravissimo bisogno? O non è forse sottrarre a questi ultimi quanto loro (ordinariamente) spetta di diritto? E poi, quel denaro che elargiscono con tanta munificenza, i nostri signori uomini politici da chi mai lo hanno spremuto e lo spremono, giorno per giorno, con mille esosi ed odiosi balzelli? Non forse da quegli stessi artigiani, contadini, impiegati e casalinghe cui negano una pensione appena decorosa ma cui, a parte l’onere gravosissimo delle imposte dirette, hanno tassato, e giorno per giorno ferocemente tassano la benzina, il caffè, i fiammiferi, il riscaldamento, ogni boccone di cibo, fin l’acqua che bevono dal rubinetto e gli stessi risparmi accantonati per la vecchiaia? Forse non sarebbe male se i signori politici, che si esentano dalle imposte sul reddito, considerassero che la vera beneficenza è quella che si fa col denaro proprio e non con quello degli altri!
• È, infine, il caso di osservare che l’assistenzialismo nei confronti degli immigrati non sembra affatto una scelta indovinata. Se, infatti, è vero che esso evita a coloro che ne beneficiano la necessità di procurarsi di che vivere col delitto, è del pari vero che l’ozio è il padre di tutti i vizi. Chi non vede, quotidianamente, ciondolare nella propria città schiere di giovani nordafricani? Ozio e vagabondaggio non hanno mai favorito l’onestà ed i buoni costumi, specie tra i giovani e i giovanissimi, pieni di vita e ardenti di fantasie, di desideri e di impulsi. Come potranno questi giovani, sbalestrati lontano dalle loro famiglie, resistere alle innumerevoli lusinghe che li assediano da ogni parte, in una società smaccatamente edonistica? “Droghini”, prostitute e “magnaccia”, mendicanti, perdigiorno senza arte né parte, nella migliore delle ipotesi “Vu’ cumprà”, ecco qual è, in realtà il prevalente panorama di quei “lavori umili” che, nella turpe menzogna di Stato, gli italiani non se la sentirebbero più di svolgere e per cui si sono aperte le cateratte dell’invasione extracomunitaria.
• (Cosa pensa e cosa direbbe l’Autore di questo volume oggi, nel 2021, a fronte di quelle pericolose intoccabili ONG (non tutte, per grazia di Dio), dei porti aperti, dei processi alle intenzioni, della censura di Stato, dei ricatti della finanza più spietata che si cela dietro lo pseudonimo di “Europa”, dei centri di millantata accoglienza, dei milioni di extracomunitari che spadroneggiano finanche nei paesini di provincia, dei miliardi di euro estorti dalle nostre tasche ed usati per mantenere falsi imprenditori dell’accoglienza, strutture alberghiere fallite per palese incapacità, avventurieri e spacciatori, meretrici e violenti ubriaconi, veri e propri nuclei di malavita organizzata. Tutto questo a detrimento di chi? Degli indigeni e degli stessi negri onesti. L’Autore farebbe bene ad esclamare: Io vi avevo avvisato trent’anni fa!, ndr.). Prosegue ...
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, tra i tanti mali da cui è tormentata l’età nostra, una cosa c’è, che ci fa bene sperare: è il risveglio d’amore e studi mariani. E tra i vari studi mariani, quello che oggidì più interessa gli studiosi è la Mediazione di Maria. Così scrive il P. Angelo Taverna nel suo opuscolo apologetico «Maria Mediatrice», collana S.O.S., Serie V, n° 97, nella prima metà del ventesimo secolo. Non sarà quindi inopportuno che la nostra collezione se ne interessi, tanto più che con ciò si risponde ai protestanti: i quali aborriscono dall’attribuire in qualsiasi modo a Maria il titolo di mediatrice.
• Mediazione. Una parola sui termini e un’altra sulla questione che qui vogliamo trattare. Mediatore è, secondo la dottrina dell’Angelico, colui che si trova in mezzo a due estremi e li congiunge (Cf. Summ. Theol. III, q. 26, a. 2). Cristo è perfetto Mediatore tra Dio e gli uomini, perché, collocato tra questi due estremi, li congiunse con la sua redenzione: «Mediator Dei et hominum homo Christus Jesus: Qui dedit semetipsum redemptionem pro omnibus» (I Tim. 2-5, 6) e continua a congiungerli, presentando continuamente al Padre per gli uomini il prezzo della redenzione compiuta. Da tutti si deve ammettere che unico Mediatore perfetto tra Dio e gli uomini è Cristo Gesù. «Niente però vieta, dice San Tommaso, che anche gli altri siano in qualche modo mediatori tra Dio e gli uomini: in quanto cioè cooperano con Dio a modo di disposizione o di ministero» (Summ. Theol. III, q. 26, a. 1). In tale mediazione occupa certamente il primo posto la SS. Vergine: a Lei conviene per eccellenza il titolo di Mediatrice, sempre, ben inteso, per mediazione partecipata. Analogamente quindi alla mediazione principale di Cristo si potrà parlare di mediazione secondaria di Maria nella Redenzione (che alcuni Teologi chiamano «oggettiva») e nella distribuzione delle grazie (che alcuni Teologi chiamano «Redenzione soggettiva»). Nel primo caso Mediatrice diventa sinonimo di Corredentrice; nel secondo diventa sinonimo di Distributrice delle grazie. Che Maria sia Corredentrice del genere umano nel senso che è Madre del Redentore, ossia ch’Essa sia Corredentrice remota, è da tutti ammesso. Ma che Essa sia Corredentrice prossima, ossia abbia avuto parte diretta nell’opera redentrice del genere umano, nell acquisto del capitale di grazia, è oggetto di viva discussione presso i Teologi moderni. Lasciando da parte tale questione ed attendendo su ciò maggiore luce, ci piace fermarci sull’altro aspetto della Mediazione Mariana, ossia sulla Madonna Distributrice di tutte le grazie, sul che, almeno quanto alla sostanza, vige il consenso pieno e perfetto di tutti i Teologi cattolici. [L’Autore scrive prima della «Ad caeli Reginam» di Papa Pio XII: Maria la Corredentrice. Dunque luce è stata fatta e ne abbiamo già parlato sul nostro Sursum Corda].
• L’intercessione di Maria. Non v’è dubbio che Maria presenti incessantemente al trono della divina misericordia i suoi meriti e le sue preghiere per la salvezza degli uomini. Diciamo non solamente le sue preghiere, ma i suoi meriti ancora. Giacché, come insegna San Tommaso, «in due modi i Santi pregano per noi. In primo luogo con una preghiera espressa, quand’essi esprimono i loro desideri per noi alla divina clemenza; in secondo luogo con una preghiera interpretativa, fondata sui loro meriti che, sempre presenti al cospetto di Dio, non sono solamente per essi un titolo di gloria, ma sono ancora per noi come tanti suffragi e preghiere tacite, in quella guisa che il sangue di Gesù Cristo sparso per noi, domanda grazia in favore nostro» (S. Thom., In Sentent., IV D. 45, q. 3, a. 3. Così, per esempio, prega la Chiesa nella Messa di San Gioacchino. Post comm.: «Noi vi domandiamo, o Dio onnipotente, che, per i sacramenti che ora abbiamo presi, col soccorso dei meriti e delle preghiere del beato Gioacchino, partecipiamo nel tempo alla vostra grazia ed alla vostra gloria nell’eternità ». E così pure nel piccolo ufficio della Santa Vergine, nel Capitolo: «Per le preghiere ed i meriti della beata Maria sempre Vergine e di tutti i Santi, il Signore ci conduca al regno dei cieli». Ma, come bene osserva il P. Terrien, «se noi distinguiamo questi due modi di preghiere, dobbiamo guardarci dal separarli; giacché, in fondo, anziché due preghiere, abbiamo due elementi costitutivi della stessa preghiera, vale a dire ciò che presenta la domanda e ciò che la rende potente presso Dio. Quindi è che la Chiesa ha cura di riunire queste due cose, quando ella si appoggia sopra il suffragio dei Santi» («La mère des hommes», L. 5, c. 4). Per meglio intendere questo, gioverà ricordare la dottrina comune dei Teologi, i quali insegnano che in ogni opera buona fatta in stato di grazia si contiene un triplice valore, meritorio de condigno, meritorio de congruo e soddisfattorio. Il merito de condigno, che ha per oggetto l’aumento della grazia santificante in questa vita e di gloria essenziale nell’altra e, probabilmente, anche la prima gloria essenziale, non è cedibile ad altri; esso è esclusivamente proprio di chi l’acquista, parlando di pure creature. Solo i meriti condegni di Gesù Cristo sono ad altri cedibili. Non così il merito de congruo, come pure il valore soddisfattorio. L’uno e l’altro si possono cedere ad altri da colui che l’acquista. Lasciando stare il valore soddisfattorio — che non fa a nostro proposito — il merito de congruo non è altro che il valore impetratorio delle buone opere, valore cioè a cui corrispondono grazie attuali, sebbene queste grazie non si debbano alle buone opere di stretta giustizia, né Dio si sia obbligato di concederle alla preghiera impropriamente detta. Ma c’è una grande congruità e convenienza nelle opere buone fatte dal giusto, ch’esse siano retribuite con grazie attuali, e Dio per lo più, conformandosi a questa convenienza, suole di fatto premiare le opere buone, di cui tanto si compiace, con grazie attuali di ogni genere. Ora se si considera, come egregiamente scrive il Toleto (In Lucam, c. 1, annotatio 67), che nella lunga vita di Maria non vi fu nessun atto, nessuna operazione che non fosse santa, giusta e a Dio accetta — poiché se così non fosse, ella non sarebbe stata esente da peccato, laddove è certissimo che non commise mai nessuna anche minima colpa; — di più, se si considera che nella beatissima Vergine non ci fu mai nessuna omissione degna della minima riprensione; che inoltre la Vergine ebbe una grazia abbondantissima per cui era disposta ad esercitare qualsiasi atto di virtù anche eminente ed arduo; se, diciamo, tutto questo si considera, quale concetto potrà farsi dell’immenso cumulo di meriti, tanto condegni quanto congrui, ch’ella adunò nel lungo corso della sua vita terrena? Ebbene, sono appunto questi immensi meriti congrui che danno valore sommo alle preghiere di Maria.
• Potenza della intercessione di Maria. Del resto, nota ottimamente il citato P. Terrien, quando parliamo dei meriti che rendono così potente la preghiera di Maria, noi dobbiamo «intendere non solamente i meriti propriamente detti, ma ancora tutto ciò che può rendere l’orante degno di essere esaudito. Perciò la maternità divina con tutti i privilegi di grazia e di gloria di cui Maria è centro e sorgente, entra da se stessa nell’ordine del merito. Non è giusto, infatti, che la Madre di Dio sia esaudita dal suo Figlio; la Figlia di Dio, dal suo Padre; la Sposa di Dio, dallo Spirito Santo, suo sposo regale?». E così pure anche i meriti de condigno, appunto perché aumentano la grazia santificante, cioè rendono più amica e più grata a Dio la persona che merita, concorrono a rendere più efficace presso Dio la sua preghiera. Giacché è legge dell’amicizia che l’amico faccia la volontà dell’amico. Ora la Vergine con i suoi meriti accumulò tanta grazia santificante che, aggiunta alla grazia che Dio liberalmente a Lei concesse nella sua Concezione Immacolata ed in altri tempi della sua vita come nell’Incarna- zione del Verbo Divino, ed alla grazia che ex opere operato ella attinse dai sacramenti che ricevette, specialmente dalla Divina Eucaristia, forma una grazia quasi immensa, di gran lunga superiore alla grazia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi insieme. Quindi sosteniamo che la preghiera di Maria è più potente presso Dio che quella di tutti gli Angeli e Santi insieme compresi, tanto che l’esimio Dott. Suarez («De mysteriis vitae Christi», D. 23, s. 2, n. 5) non dubita di scrivere che «se noi c’immaginiamo che la beata Vergine domandi una grazia e tutta la corte celeste a lei resista (siccome leggiamo in Daniele che un angelo resisteva ad un altro) sarebbe più possente e di maggiore efficacia al cospetto di Dio la preghiera della Vergine che la preghiera di tutti gli altri insieme. E così pensano i santi Padri, ed è convenientissimo alla dignità di madre ed in certo modo dovuto alla perfettissima grazia e carità della Vergine». E come è certo che Maria ha una potenza così grande per impetrare agli uomini con la sua preghiera le grazie salutari, così è pur certo il buon volere che ha la Vergine di usare di questo suo immenso potere, atteso l’amore ardentissimo da cui è infiammato il suo cuore verso tutti gli uomini. Non c’è dunque dubbio che innumerevoli sono le grazie che Maria con la sua intercessione fa discendere sulla terra dal trono della divina misericordia.
• Mediazione universale. Ma quando si dice Maria Mediatrice di tutte le grazie si vuol dire qualche cosa di più ancora : cioè che nessuna grazia discende dal Cielo sulla terra, che non sia dovuta all’intercessione di Maria; il che è quanto i fedeli sogliono esprimere con bella ed efficace locuzione metaforica, che tutte le grazie vengono da Dio per le mani di Maria. Ed appunto in questo senso, molti, come dicevamo, desiderano la definizione dogmatica dell’universale mediazione di Maria. Ora sarà bene determinare anche meglio il significato di questa asserzione.
• Quanto alle persone. Quando diciamo che tutte le grazie, senza eccezione, discendono per le mani di Maria, è chiaro che non vogliamo comprendere tutte le grazie altresì che Maria stessa ottenne da Dio. Poiché sebbene anche per la Vergine Santissima la preghiera fosse il gran mezzo per ottenere da Dio grazie eziandio per se stessa, pure non c’è dubbio che Dio fece a Lei delle grazie senza l’intervento della sua preghiera. E così, a cagione d’esempio, la grazia ch’ebbe Maria per formare la sua prima preghiera — giacché anche a Maria per pregare era necessaria la grazia — non potè averla mediante la sua preghiera. Altrimenti, si dovrebbe ammettere il processo all’infinito, come parlano i filosofi. L’universalità, dunque, dell’intercessione di Maria riguarda gli altri uomini, rispetto ai quali, quando asseriamo ch’essi non possono avere nessuna grazia senza l’intercessione della Vergine, non vogliamo con ciò dire che nessuno ottiene grazia qualsiasi se a lei non rivolge la sua preghiera. No, perché molte grazie le ottiene Maria anche a chi non l’invoca. Che però disse benissimo il divino poeta, nel suo inno sublime a Maria: «La tua liberalità non pur soccorre A chi domanda, ma molte fiate Liberalmente al domandar precorre» (DANTE - Paradiso XXXIII, 16-19. Affermiamo soltanto che per ogni grazia che dal Cielo discenda, Dio ha voluto che Maria interponga la sua intercessione, anche quando chi riceve la grazia non pensi a richiedere la Vergine della sua intercessione. Così pure può rivolgere direttamente la sua preghiera al Divin Padre od a Gesù Cristo. Ma anche allora la grazia non discenderà dal trono della misericordia di Dio se non passando per le mani di Maria. E similmente può uno pregare un Santo od un Angelo. Ma la preghiera fatta al Santo od all’Angelo salirà al trono della divina misericordia presentata dalla preghiera di Maria.
• Quanto al tempo. Quando asseriamo che Maria è universale mediatrice di grazie si può domandare, s’ella sia tale rispetto agli uomini di tutti i tempi, cioè non solo rispetto agli uomini che vissero dopo il suo ingresso nel regno della gloria, ma ancora per quelli che con Lei vissero quand’ella pellegrinava in terra, anzi ancora per quelli che a Lei preesistettero. A dire il vero, a noi piace la sentenza di coloro i quali, col P. Vermeersch («Maria Vergine Madre di Dio», 47.o sabbato, II) ammettono che l’intercessione di Maria influiva anche sugli uomini che precedettero la sua esistenza. Siccome è certissimo che nessuna grazia si diede agli uomini vissuti prima della venuta di Gesù Cristo nel mondo, se non per i menti di questo Divin Salvatore, così non è inverosimile che Dio non volesse concedere nessuna grazia anche prima dell’esistenza di Maria, se non in riguardo alle future preghiere di questa Vergine benedetta. Del resto, vi sono gravissimi Teologi antichi e recenti, come il Suarez (De paenit., d. 48, s. 5, n. 12) ed il Pesch (Praelect dogm., to. IX, n. 617), i quali attribuiscono un potere retroattivo alla preghiera anche degli altri uomini. Che se così è, con maggior ragione possiamo affermare che l’intercessione della Vergine esercitasse la sua efficacia in coloro che vivevano con Lei sulla terra. Rispetto a questi l’intercessione di Maria era reale ed attuale. È certissimo che Maria pregava intensamente ed assiduamente per la salvezza degli uomini nella sua vita mortale. È vero che, non godendo ancora della beatifica visione, non abbiamo sufficiente fondamento per asserire che, almeno abitualmente, per lume profetico ella conoscesse in particolare le necessità dei singoli uomini. Ma quale difficoltà c’ è nell’ammettere che il Signore non concedesse grazia alcuna ai singoli uomini, se non per riguardo delle preghiere che Maria porgeva a Dio per gli uomini in generale ? Ad ogni modo, poiché gravi Teologi, come il Van Noort, attribuiscono alla Vergine l’ufficio di universale Mediatrice solo dal momento in cui ella, ammessa alla visione intuitiva di Dio, potè al lume beatifico conoscere distintamente le necessità dei singoli uomini, così a noi pure basterà difendere questo glorioso ufficio della Vergine dentro questi limiti, quanto al tempo in cui cominciò ad esercitarlo.
• Quanto alle grazie. Ma se possiamo ammettere una restrizione quanto al tempo, non la possiamo concedere quanto alle stesse grazie. Chiamando Maria mediatrice di tutte le grazie senza eccezione alcuna, intendiamo dire che all’intercessione di Lei siamo debitori non solo delle grazie attuali — per cui non è difficoltà speciale — ma ancora delle abituali, tanto extrasacramentali quanto sacramentali. È vero che le fonti immediate della grazia abituale — così chiamiamo la grazia santificante con le virtù tanto teologiche quanto morali che l’accompagnano —non sono che due: cioè le buone opere meritorie de condigno ed i sacramenti. Supposta l’esistenza dell’opera meritoria, necessariamente nel presente ordine di Provvidenza si ha l’aumento di grazia ed a suo tempo, per chi muore in grazia, l’aumento di gloria. Così pure, posto il Sacramento ricevuto con le debite disposizioni, si ha immediatamente la prima grazia o l’aumento di grazia proporzionato alla disposizione con cui si è ricevuto il Sacramento. Or bene per fare le opere buone e meritorie di vita eterna è necessaria la grazia attuale: la sufficiente per poterle fare, l’efficace per farle di fatto. La Vergine ci otterrebbe le une e le altre grazie, le sufficienti e le efficaci, per fare le opere meritorie. Similmente è grazia attuale il fatto che uno riceva il Sacramento: che un bambino, per esempio, sia battezzato, che un adulto peccatore, moribondo, riceva il sacramento della confessione. Inoltre, l’apportare nell’uso dei Sacramenti tanto le necessarie quanto le migliori disposizioni, è opera insieme e del libero arbitrio e della grazia attuale. Questa grazia attuale si deve anche all’intercessione di Maria. Per conseguenza all’intercessione di Maria è dovuta pure in qualche modo la grazia santificante tanto extrasacramentale, quanto la sacramentale.
• Le prove. Ci siamo fin qui studiati di spiegare e di determinare con precisione il senso in cui si deve intendere la Mediazione universale di Maria nella distribuzione di tutte le grazie. E ci siamo distesi alquanto in questa spiegazione, perché così rimangono sciolte, si può dire, quasi tutte le difficoltà che si possono opporre ad una dottrina così bella e consolante. Dottrina bella e consolante senza dubbio. Ma ciò non basta perch’ella sia conforme a verità. Qui si tratta di cosa soprannaturale, dipendente dalla sola e liberissima volontà divina. E ciò diciamo, anche posto che Dio volesse, come volle di fatto, salvare l’umano genere col mistero dell’Incarnazione: non essendo assolutamente necessario l’intervento dell’intercessione di Maria nella distribuzione delle grazie, non possiamo sapere nulla sopra ciò, se Dio non ci ha rivelata la sua volontà. Ora ce l’ha Dio rivelata questa sua volontà di assumere Maria a cooperatrice universale nella distribuzione delle grazie? Noi non esitiamo a rispondere, che Dio ci ha manifestato questa sua volontà nella Sacra Scrittura e nella Tradizione, dichiarataci dai Padri, dai Teologi, dalla Liturgia e finalmente dai Sommi Pontefici.
• La Testimonianza della tradizione. A dimostrare la volontà divina circa l’universale mediazione di grazia, da essa conferita a Maria, incominciamo dalle testimonianze della Tradizione, perché essa, come avviene in parecchie verità rivelate, è su questo punto più esplicita e più chiara. Non possiamo qui addurre le numerose e splendide testimonianze dei Padri e dei Teologi; chè non basterebbe a questo fine un grosso volume. E del resto, se non tutte, queste testimonianze si trovano già raccolte a gran numero in molti libri, specialmente nelle opere già da noi sopra citate, come quelle di Sant’Alfonso, del P. Godst, del P. Terrien, e del P. Villada. Il P. Terrien, prima di passare alle citazioni particolari, nota quattro classi generali di attestazioni dottrinali, in cui egli vede questa sentenza implicitamente affermata, non solamente da tale o tal altro dottore particolare, ma, si può dire, dal consenso universale dei maestri e dei fedeli. Lasciando le testimonianze della seconda classe, che ci paiono meno efficaci, ci piace di riferire quelle delle altre tre classi secondoché le espone egregiamente l’autore («La Mère des hommes», 1. 7, c, 4).
• I titoli dati alla Vergine. Se v’è cosa manifesta, ella è questa che la Chiesa tutta intera, sotto tutte le latitudini e fin dai tempi più remoti, nei canti liturgici, nelle omelie, nei panegirici, in una parola: in tutti i generi di monumenti, in tutte le opere composte a onore della Vergine, tutta la Chiesa, diciamo, senza eccettuare le parti già unite alla Sede Romana ed ora da lungo tempo separate, ha costantemente salutato Maria con una grande varietà di titoli (presi) dalla Sacra Scrittura e dall’insegnamento cattolico attribuiti a Gesù Cristo, nostro Mediatore e Salvatore. La Chiesa infatti nella Salve Regina chiama Maria nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. Leggasi, ad esempio, la grand’opera del Passglia. («De immaculato Deiparae semper Virginis conceptu commentarius», Napoli 1855). Quivi Maria ci si presenta come luce che rischiara il mondo intero; come la sorgente vivente e perpetua dell’immortalità, di tutta la grazia e di tutta la santità; come la vera vigna, la vigna feconda, sempre fiorita e sempre carica di uva che dà la gioia divina. Ella è la respirazione dei cristiani, la radice della libertà restituita al genere umano. Meglio ancora, ella è la causa della salute, la madre della salute universale, la salute del mondo, la salute di tutti gli uomini fino agli ultimi confini della terra. Ella è il principio comune della nostra felicita, del nostro rinnovamento, in una parola, di tutti i beni; la riparatrice e la ristoratrice dell’umana famiglia, la redenzione dei mortali; colei per mezzo della quale noi passammo dalla morte alla vita, dalle tenebre all’ammirabile lume. Ella è celebrata come il vero propiziatorio del mondo, la causa universale della deificazione, il ponte reale per cui la terra si congiunge al cielo, la speranza dei cristiani e la loro speranza unica, il nostro rifugio e la nostra forza. Ecco ciò che si legge in tutte le forme ed in tutte le lingue, non una, ma cento e cento volte. Si sa bene che quest’espressioni, quando affermano ciò che, in rigore di termini, è essenzialmente proprio di Cristo, si devono intendere della Madre di Cristo solo secondariamente e dipendentemente dal suo Figlio, come del resto, risulta dal contesto e da altre circostanze.
• Maria nel Corpo Mistico. Passando ora ad un’altra classe di testimonianze, la Chiesa tutta intera è un corpo di cui Gesù Cristo è il capo e noi siamo le membra. È legge che ogni influenza vitale e, per conseguente, ogni dono di grazia, discenda dal capo alle membra, da Gesù Cristo agli uomini. Ora qual è, secondo molti Padri e Teologi, la posizione di Maria nel corpo di Cristo? È quella significata da essi, con semplice ma espressiva metafora, del «collo». E ciò nuovamente ci conduce alla conclusione già dedotta. Infatti, nel corpo umano solo per mezzo del collo il capo comunica alle altre parti del nostro organismo il movimento e la sensibilità di cui esso è il centro principale. Dunque la metafora corrisponde mirabilmente al privilegio di Maria. Tra gli altri ci sarà caro di udire svolgere questa metafora il grande Bellarmino: «Cristo, egli dice, è il capo della Chiesa e Maria ne è il collo. Tutti i doni, tutte le grazie, tutte le influenze celesti discendono da Cristo, come dal capo, per mezzo di Maria, quasi per il collo, nel corpo della Chiesa. Nel corpo umano v’è più di una mano, più d’un braccio, più d’una spalla, più d’un piede. Così nella Chiesa vi sono più Apostoli, più Martiri, più Confessori, più Vergini, più Vedove; ma non v’ha che un Figlio di Dio ed una sola è la Madre di Dio... O infelici coloro che non riconoscono, non venerano tal collo. Giacché siccome un membro se volesse ricevere le influenze dal capo e disdegnasse di riceverle per mezzo del collo, si seccherebbe e morrebbe, così quelli che desiderano di avere da Cristo la vita e la grazia e non vogliono averla per mezzo di Maria, rimangono e rimarranno in eterno aridi e digiuni» («Conciones, habitae Lovanii», Concio 42.
• Nulla senza Maria. V’è una terza classe di testimonianze che contengono formole simili a queste: Nessuna salvezza senza la protezione di Maria. Implorare i favori divini indipendentemente da Maria è un voler volare senz’ali. «Qui petit sine ipsa duce, sine alis tentai volare», come si esprime Sant’Antonino di Firenze (Summ. Theol., p. IV, tit. 15, c. 22, § 9). E forse il santo arcivescovo prese questo pensiero dall’Alighieri, il quale nel suo immortale poema fa così parlare San Bernardo alla Vergine: «Donna, se’ tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disïanza vuol volar sanz’ali» (Paradiso, canto XXXIII, 13-16). Bisogna bene che Maria sia per noi la dispensiera di tutte le grazie, se non si può sperare salvezza, né trovare il Salvatore e la grazia senza di Lei. Poiché, se ci fosse per noi un altro canale delle grazie, se il cuore di Dio versasse le grazie per altre mani che per quelle di Maria, più non esisterebbe l’impossibilità significata da queste testimonianze. Non si potrebbe più dire con San Germano di Costantinopoli: «Nessuno è salvo se non per mezzo di voi, o Vergine madre; nessuno riceverebbe alcun dono da Dio se non per mezzo di voi, o piena di grazia» (Serm. in Dormit. B. M. V. 2. Migne, P. G. 98, 349). Tengono un simile linguaggio San Lorenzo Giustiniani (De laud. B. M., L. XII, c. II, n. 12) e Sant’Anselmo (Orat., 52, Migne, P. L., 158, 956). Il P. Terrien passa quindi a esporre le testimonianze speciali, dopo avere meritamente osservato che gli scrittori cattolici non cominciarono a trattare ex professo nelle loro opere la nostra questione se non dopo il secolo decimoquinto. Anzi bisogna discendere più giù, per trovarla espressa in tesi nei trattati speciali. Ciò però non vuol dire che non ci fossero precedentemente delle testimonianze esplicite. Al contrario, le testimonianze abbondano anche nei secoli precedenti. E lo stesso dotto autore ne arreca molte, dividendole in due serie: testimonianze appartenenti ai secoli in cui la questione non era ancora espressamente sollevata né discussa; e testimonianze degli scrittori ecclesiastici degli ultimi tempi, dal secolo decimosettimo fino ai nostri giorni. Similmente procedono il Godst e il Villada, accumulando di secolo in secolo un gran numero di altre autorità antiche e recenti. Eppure noi crediamo che ai nomi già raccolti se ne possano aggiungere altri non meno illustri, per esempio il Pinamonti (Esercizi spirituali, Esame per il nono giorno, n. V). il Cardinale Pallavicino (Arte della perfez. crist., 1. 3. c. 7), e molto più, tra i più recenti, come il Bucceroni (La B. Vergine Maria, 15, 2) ed il Monsabré (Esposizione del dogma cattol. Confer. 50), i quali apertamente professano la medesima sentenza. Dopo aver lette queste testimonianze, concluderemo col P. Terrien: non ci sembra forse di udire mille e mille voci che dall’Oriente e dall’Occidente proclamano con San Bernardo il grande e solenne principio: «Questa è la volontà di Dio che ogni bene ci venga dal Cielo per mezzo di Maria»?
• La Liturgia. Né da esse discordano le voci delle sacre Liturgie occidentali ed orientali. «L’una e l’altra Chiesa, la latina e la greca [beneinteso: non si vuol fare una apologia della greca eretica e scismatica, ndr.], argomenta il P. Piazza, nel sacrosanto Sacrificio della Messa invoca la Beatissima Madre di Dio quotidianamente e frequentemente. La Chiesa greca in tutti i sacri inni, di qualunque argomento essi siano, suole aggiungere le lodi della Divina Madre. La Chiesa latina premette a ciascuna ora canonica insieme con l’orazione domenicale la salutazione angelica e conclude il divino ufficio con una solenne preghiera alla Vergine. È inoltre costume dei fedeli l’unire la salutazione angelica all’orazione domenicale. Or bene, questa frequente e quotidiana invocazione della Madre divina nelle pubbliche preghiere che la Chiesa porge a Dio ed a Cristo prova a sufficienza essere la Chiesa ed i fedeli persuasi che Maria è come il rivolo celeste per cui ai miseri mortali derivano i fiumi di tutte le grazie e di tutti i doni, come si espresse Benedetto XIV nella Bolla spesso citata» (Christianorum omnium in Sanctos Sanctorumque reginam... propensa devotio a praepostera scriptoris reformatione potissimum antiquitatis monumentis... vindicata simul et illustrata). Quest’argomento era già stato addotto dal Suarez; (De mysteriis Christi, d. 23, s. 3, n. 5); e fu poi ripreso ed esposto in tutta la sua forza dal P. La Broise. L’argomento della Liturgia ha avuto recentemente una mirabile conferma dall’istituzione della festa di Maria Mediatrice di tutte le grazie. Si noti che il titolo di questa Messa col proprio ufficio, è «Mediatrice di tutte le grazie». Dunque tutte le grazie si devono all’intercessione di Maria.
• Testimonianze della Scrittura. Ma non solo la Tradizione, anche la Scrittura ci parla del medesimo privilegio di Maria. Fino dalle prime pagine, infatti, dei libri ispirati noi c’incontriamo in quello che meritamente si chiama protovangelo: «Io getterò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua schiatta e la schiatta di lei: essa ti schiaccerà il capo mentre tu ti avventi al suo calcagno» (Gen. 3, 15,- cf. La Sacra Bibblia tradotta dai testi originali con note a cura del P. Istituto Biblico di Roma, I. Firenze, Salani, p. 70). In quest’oracolo la Vergine si trova unita con strettissimo ed indissolubile vincolo a Gesù Cristo Mediatore di Dio e degli uomini nell’opera dell’umana salvezza. Ora questo vincolo non sarebbe indissolubile se noi separassimo anche solo per un istante in questa grand’opera la Vergine dal suo Divino Figliuolo. D’altra parte sappiamo che Gesù Cristo è l’autore principale dell’umana salute non solo perché ha coi suoi meriti accumulato i tesori infiniti di grazie, ma ancora perché attualmente distribuisce ai singoli fedeli questi tesori, Egli che è l’avvocato nostro presso il Padre (1 Io., 2, 1), semper vivens ad interpellandum pro nobis (Hebr., 7, 25). Dobbiamo adunque dire che anche la Vergine concorre con Gesù nella distribuzione di queste grazie salutari. E crediamo che appunto per insinuare questa consolante verità del concorso di Maria con Gesù nella distribuzione delle grazie, lo Spirito Santo abbia ispirato a San Luca di scrivere nel suo Vangelo (Luc., 1, 41-44) come la prima santificazione che il Salvatore operasse nella persona di San Giovanni Battista, da lui si operasse mediante le parole di Maria, che furono parole in certa guisa sacramentali, come s’esprime il P. Nepveu (Pensées. Juillet, 2 jour). Per la stessa ragione San Giovanni fu ispirato a registrare nel suo Vangelo (Io., 2) come quando Gesù fece il primo miracolo per provare la divinità della sua missione, non volle farlo se non per intercessione di Maria.
• L’autorità dei Pontefici. Ciò però che dà maggior valore ancora agli argomenti è l’autorità dei Romani Pontefici. Pio IX, nell’Enciclica Ubi primum diretta a tutti i vescovi dell’orbe cattolico, in cui li esorta a pregare insieme coi fedeli affinché il Signore lo illumini intorno alla convenienza della definizione dell’immacolata Concezione, tra le altre lodi che dà a Maria, ne proclama la mediazione universale, con queste parole: «Voi sapete benissimo, Venerabile Fratello, che tutta la ragione della nostra fiducia è riposta nella SS. Vergine, poiché Dio pose in Maria la pienezza di ogni bene, per modo che se in noi v’ha qualche speranza, qualche grazia, qualche salvezza, conosciamo che tutto deriva da Maria... Tale è la volontà di colui il quale volle che tutto noi abbiamo per mezzo di Maria». Così Leone XIII nella Enciclica Iucunda Semper Expectatione (1894) approva la sentenza di San Bernardino da Siena che cioè ogni grazia si dispensa da Dio per mezzo di Maria. Similmente Pio X nella sua Enciclica Ad diem illum del 2 febbraio 1904 chiama Maria «la dispensatrice di tutti i doni, che Gesù ci procacciò con la morte e col suo sangue». Benedetto XV, poi in una lettera al direttore del Rosario perpetuo in Italia, raccomandando, come Leone XIII, la preghiera del Rosario, dice che «si dirige a colei per cui mezzo piacque a Dio che ci giungano tutte le grazie». Ma non poteva lo stesso Sommo Pontefice Benedetto XV approvare più apertamente la nostra sentenza di quello che ha fatto concedendo la Messa e l’ufficio di «Maria Mediatrice di tutte le grazie».
• L’argomento teologico. Né manca in favore del privilegio di Maria, di cui trattiamo, l’argomento teologico, il quale consiste nel dedurre una verità da un’altra che ci consta dalla rivelazione. Infatti, noi possiamo inferire legittimamente l’universale mediazione di Maria dalla sua maternità spirituale rispetto agli uomini, la quale a sua volta è una conseguenza della sua maternità fisica rispetto a Gesù Cristo. La maternità spirituale di Maria è teologicamente certissima; anzi fu detta recentemente dal dotto Cardinal Lèpicier: «veritas catholica, ad fidem proxime pertinens»; sicché il negarla, secondo lui, sarebbe non solo temerario ma saprebbe di eresia; perché questa verità, quantunque non mai espressamente definita, resta sempre universalmente fissa nel cuore e sulle labbra del popolo cristiano (Tractatus de Beatissima Virgine Maria, p. 3, c. 1, a. 1, n. 17). La certezza della maternità spirituale di Maria non dipende dalla questione se questa maternità fu conferita a Maria sul Calvario con quelle parole che il suo Divin Figliuolo rivolse a Lei dalla croce: «Ecco il tuo figliuolo» additandole San Giovanni che stava a fianco di Maria e con quelle altre rivolte a San Giovanni: «Figlio, ecco la tua madre» (Io., 19, 26-27). A dir il vero, con molti autori e, quel che è più, coi Sommi Pontefici Benedetto XIV (Bull. Gloriosae Dominae), Pio VIII (Bull. Praesentissimum), Leone XIII (Saepe, praésertim in Encyclica Adiutricem), noi crediamo che in queste parole sia designata la maternità spirituale di Maria, in senso non già semplicemente accomodato bensì vero e reale, o letterale od almeno tipico. Ma crediamo pure, come già sopra dicemmo, che quest’altissima dignità fu conferita a Maria nell’Incarnazione del suo Figliuolo, quand’ella divenne sua Madre, e che da Gesù sulla croce fu soltanto promulgata in maniera solenne.
• Dottrina di Pio X. Ecco come autorevolmente svolge quest argomento Pio X nell’Enciclica citata: «E non è forse Maria la Madre di Cristo? Adunque Ella è altresì Madre nostra. — Imperocché deve ognuno ritenere che Gesù, il Verbo fatto carne, è eziandio il Salvatore dell’uman genere. Ora in quanto Uomo-Dio, Egli ebbe un corpo fisico al pari di ogni altro uomo: in quanto poi Salvatore dell’umana famiglia, ebbe un corpo spirituale e mistico, la società cioè di coloro i quali credono in Cristo. Siamo molti un solo corpo in Cristo. Orbene la Vergine non concepì solamente l’Eterno Figlio di Dio perché si facesse uomo, pigliando da Lei l’umana natura; ma eziandio affinché, per mezzo della natura da Lei assunta, fosse il Liberatore degli uomini. Per la qual cosa l’Angelo disse ai pastori: È nato a voi oggi un Salvatore, che è il Cristo Signore. Pertanto nello stesso unico seno della castissima Madre, Cristo prese per sé ed unì a sé il corpo spirituale, formato da coloro, i quali erano per credere in Lui. Talché Maria, portando nel seno il Salvatore, può dirsi che portasse eziandio coloro tutti, la vita dei quali era contenuta nella vita del Salvatore. Per la qual cosa quanti siamo uniti con Cristo e, come dice l’Apostolo, siamo membra del corpo di Lui e delle ossa di Lui, siamo usciti dal seno di Maria, a guisa di corpo unito col capo. Donde è che, in modo bensì spirituale e mistico, siamo noi chiamati figliuoli di Maria, ed Essa è madre a noi tutti. Madre, sì spiritualmente, ma veramente Madre delle membra di Cristo che siamo noi. Se adunque la Vergine beatissima è Madre di Dio e degli uomini, chi dubiterà che Ella non si adoperi con ogni studio perché Cristo, capo del corpo della Chiesa, trasfonda in noi sue membra i doni suoi e quelli innanzi tutto di conoscere Lui e di vivere per Lui? Oltre a ciò alla Madre santissima non toccò solo il vanto di aver somministrato la materia della sua carne all’Unigenito di Dio che doveva nascere con umane membra, della qual materia si preparasse la vittima per la salute degli uomini; ma toccò insieme l’ufficio di custodire e nutrire la stessa vittima e, al tempo designato, presentarla per il sacrificio. Quando poi giunse l’ora suprema del Figlio, stava presso la croce di Gesù la Madre di Lui, non occupata semplicemente nel contemplare il crudele spettacolo, ma rallegrandosi che l’Unigenito suo fosse offerto per la salute dell’uman genere e tanto eziandio partecipando alla sua passione, che, se fosse stato possibile, avrebbe essa molto più volentieri sostenuto i tormenti tutti che sostenne il Figlio. — Or da questa comunione di dolori e di volontà tra Cristo e Maria, meritò Essa di divenire degnissimamente la Riparatrice del mondo perduto, e quindi la Dispensatrice di tutti i doni che Gesù ci procacciò con la morte e col sangue. Non neghiamo già che la distribuzione di siffatti doni, di proprio e privato diritto, appartenga a Cristo; pur nondimeno, per la partecipazione di dolori e di affanni della Madre con il Figlio, fu concesso alla Vergine augusta di essere presso l’Unigenito suo Figliuolo la Mediatrice e Conciliatrice potentissima di tutta la terra. È dunque Cristo il fonte, e della pienezza di Lui noi tutti abbiamo ricevuto; da cui tutto il corpo compaginato e commesso, per via di tutte le congiunture di comunicazione, l’aumento prende proprio del corpo per sua perfezione mediante la carità; Maria a sua volta, come nota acconciamente San Bernardo, è l’acquedotto; o, se vuoisi, è il collo, per cui il corpo aderisce al capo ed il capo trasmette nel corpo la forza e la virtù. Imperocché Essa è il collo del nostro Capo, per via del quale ogni dono spirituale si comunica al Corpo mistico di Lui. Dal che si fa manifesto che noi siamo ben lungi dall’attribuire alla Vergine la virtù di produrre la grazia soprannaturale, ciò che appartiene a Dio solo. Ma superando Essa ogni creatura nella santità e nell’unione con Cristo, ed essendo stata da Cristo presa a compagna nell’opera dell’umana salute, ci merita, come dicono, de congruo, ciò, che Cristo ci meritò de condigno, ed è la prima Ministra nella distribuzione delle grazie».
• Riassumendo possiamo ridurre il ragionamento del Santo Pontefice in questa breve forma. Maria è madre spirituale degli uomini. La sua maternità spirituale consiste nel cooperare ch’Ella fa alla formazione del corpo mistico di Cristo che non è altro che l’estensione ed il compimento di Gesù alla cui formazione Ella cooperò fisicamente in modo da divenirne verissima Madre. La formazione del corpo mistico di Cristo consiste nell’incorporazione degli uomini allo stesso Cristo in modo che così ne risulti un sol corpo di cui Gesù sia il capo e gli altri uomini le membra. Ora questa incorporazione si fa per mezzo delle grazie, cioè immediatamente per mezzo della grazia santificante e mediatamente per mezzo delle grazie attuali che non sono date da Dio se non in ordine all’acquisto, alla conservazione ed all’aumento della grazia santificante, la quale quanto si aumenta nell’anima che ne è adorna, tanto più si perfeziona l’incorporazione con Cristo. Dunque Maria deve aver parte nel comunicare queste grazie. Ciò non può essere in una maniera fisica, perché solo Dio è causa fisica della grazia. Dunque Maria deve cooperare solo moralmente. Non può dirsi che Maria abbia cooperato meritando de condigno queste grazie: Gesù solo le ha meritate de condigno. Resta dunque che ella abbia cooperato coi suoi meriti de congruo e con la sua intercessione. In questo modo risplende mirabilmente l’unità del disegno divino nella grand’opera della Redenzione, come osservava già stupendamente il Bossuet. «Dio avendo voluto, così egli si esprime, una volta darci Gesù Cristo per mezzo di Maria, quest’ordine più non si muta e i doni di Dio non si revocano. Egli è e sarà sempre vero che, avendo noi da Lei ricevuto una volta il principio universale della grazia ne riceviamo ancora per sua interposizione le varie applicazioni della grazia in tutti i differenti stati che costituiscono la vita cristiana» (Sermón sur l’Immaculée Conception).
• Conclusione. Per tutto quello che noi abbiamo detto e più ancora potremmo dire, non dubitiamo punto della verità di una sentenza tanto gloriosa per Maria e tanto consolante per gli uomini, come non ne dubitano, guidate dal sensus Christi, nella vivace semplicità della loro fede, le moltitudini dei fedeli. Le opposizioni si dileguano con nulla più che determinare esattamente lo stato della questione, come ci siamo studiati di fare nella prima parte di quest’opuscolo. Ai giorni nostri [l’Autore scrive, è bene ricordarlo, prima dell’eruzione modernista, ndr.] poi non sappiamo che ci sia pure un autore cattolico che contraddica alla nostra sentenza. È anzi consolante il vedere sempre più crescere il numero di quelli che apertamente la difendono. Oramai anche i teologi nei loro trattati de Verbo Incarnato, tra le tesi in cui dimostrano le prerogative di Maria SS. si fanno premura di non omettere quella che ne difende l’universale mediazione di grazia. Possa questa bella verità, bene conosciuta, fortemente amata, sentitamente vissuta rendere l’età nostra veramente Mariana, affinché così diventi intensamente Cristiana, come già ha previsto il V. P. Chaminade e la Madonna di Fatima sta attuando.
Per il P. Angelo Taverna SJ e per gli onesti autori menzionati: + Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Amen. +
A cura di CdP
- Dettagli
- Categoria: Comunicati e Note
Stimati Associati e gentili Sostenitori, leggiamo cosa scrive l’opuscolo protestante «Il perché» alle pagine 35 e 36: «Per ottenere la salvezza e la salute NON sono necessarie le opere nostre, bastano i meriti e l’opera di Gesù. Mentre Gesù spirava in nome mio in Croce, Egli esclamò: “Tutto è compiuto”, ossia la espiazione è compiuta; la ricevuta è firmata col sangue di Cristo, e Dio essendo soddisfatto pienamente con la morte vicaria di Cristo, lo fece risorgere dalla morte il terzo giorno. La cosa non mi è del tutto chiara, — diceva un ebanista ad un amico che cercava di spiegargli questa ragione. — Costui alzò una pialla che stava a portata di mano e con essa fece mostra di piallare un bellissimo tavolino, ormai finito e tutto lucido che gli era vicino. — Ferma, ferma! — gridò l’ebanista — non vedete che il tavolino è finito? Me lo rovinerete, se gli poggiate sopra la pialla! — Come? — replicò l’amico — ciò è appunto quello che io ho tentato di mostrarvi, rispetto all’opera redentrice di Cristo. Essa fu finita quando Egli diede la sua vita per voi e se voi procurate di aggiungere qualche cosa a quell’opera la guastate, non la perfezionate. Accettatela così come essa, è, la sua vita per la vostra, e voi siete libero dalla morte eterna! — Per quell’ebanista ciò fu un raggio di sole. Egli vide allora la via della fede. Accettò Gesù come suo Salvatore».
• Commenteremo la lunga citazione con l’aiuto del P. Carlo Bozzola S.J. (Opuscolo S.O.S., «Fede, opere, giustificazione», Serie I, n° 16, imprimatur 1944). Per ottenere la salvezza basta accettare l’opera di Gesù senza aggiunte, correzioni, mutamenti. Qui però sta la questione: in che consiste l’opera di Gesù? È quella concepita dai Protestanti (e dai modernisti che, a partire dal Vaticano II, occupano la Chiesa dall’interno, ndr.) o quella intesa dai Cattolici? L’opera di Gesù è riprodotta più fedelmente e maggiormente esaltata dai Cattolici, o dai Protestanti (e dai modernisti, ndr.)? Studieremo la questione nel presente opuscolo. Esaminata la dottrina dei Protestanti (e dei modernisti, ndr.) esporremo quella Cattolica. Dal confronto balzerà la verità.
• L’opera di salvezza di Gesù e i Protestanti. «Per noi — dicono gli oppositori — la salvezza dell’uomo è tutta opera di Dio per i meriti di Gesù Cristo. L’opera redentrice del Salvatore è veramente e pienamente sufficiente, l’uomo non vi aggiunge nulla, nulla vi apporta quasi a completarla: non gli rimane che accettarla così come è». Ma è proprio vero ? Questa affermazione suppone malintesi e contraddizioni. Incertezze e contraddizioni. Non ci pare esatto affermare che nella dottrina dei Protestanti nulla è dovuto all’uomo, ma tutto a Cristo. Devono pure ammettere che l’uomo non può godere della salvezza apportata dal Redentore, senza la fede. È necessario che l’uomo creda all’opera salvatrice di Gesù, che la accolga, che si abbandoni al suo Signore. Di più i Protestanti odierni non dubitano di avvertirci che per ottenere la giustificazione è necessario il pentimento delle colpe passate: «Vero è che il pentimento deve precedere il perdono dei peccati, poiché solo un cuore retto e contrito sente il bisogno di un Salvatore» («Guida a Gesù», opuscolo protestante, pag. 29). Non solo: ma col pentimento ci vuole un sincero proponimento di non peccare mai più. «Non è sincero il pentimento che non reca un cambiamento e una riforma nella vita e nei costumi» (ivi, pag. 66). Ci parrebbe quasi quasi di ascoltare il Concilio di Trento (sic!) quando insegna quali sono gli atti coi quali il peccatore si prepara alla giustificazione! Ivi leggiamo infatti: «Si dispongono alla stessa giustizia quando eccitati e aiutati dalla divina grazia, col concepire la fede per mezzo dell’udito, si muovono liberamente incontro a Dio, credendo esser vere quelle cose che furono da Dio rivelate e promesse, e specialmente che l’empio viene da Dio giustificato per mezzo della grazia e della redenzione in Cristo Gesù; e quando riconoscendosi peccatori si sollevano dal timore della giustizia divina... alla speranza confidandosi che Dio per i meriti di Cristo sarà loro propizio e cominciano ad amar Lui quale fonte di giustizia, e conseguentemente si muovono ad odiare e detestare i peccati e infine propongono di ricevere il battesimo, di incominciare una nuova vita e di osservare i comandamenti di Dio» (Concilio di Trento, sessione VI, capitolo 6). La rassomiglianza è più apparente che reale: lo sappiamo; ma è precisamente nell’assegnare la differenza che ci sembrano apparire più chiaramente il malinteso, l’incertezza, la contraddizione della dottrina non cattolica. «Per noi — ci dicono gli oppositori — gli atti umani che precedono la giustificazione non hanno alcuna vera esigenza: la giustificazione non viene causata da loro, ma da Dio unicamente per i meriti di Gesù». Ecco il malinteso! I Cattolici non insegnano molto diversamente. Anche per loro gli atti che precedono la giustificazione si richiedono non come causa propriamente detta, ma come condizione; non hanno vera esigenza della salute, non contengono valore strettamente meritorio: sono una semplice preparazione, una rimozione di quanto impedisce l’opera misericordiosa di Dio. La grazia, la giustificazione vien da Dio concessa al peccatore, infallibilmente, è vero, qualora vi siano le dovute disposizioni da parte dell’uomo, ma ciò non per dignità ed esigenza dei suoi atti precedenti, ma unicamente per la promessa misericordiosa di Dio stesso in vista dei meriti di Gesù. «Ma veramente — ci soggiungono — nel nostro concetto, in questi atti antecedenti non vi è da riconoscere un vero contributo umano neppure preparatorio all’opera di giustificazione. Questi atti sono frutto della grazia di N. Signore; si producono nell’uomo, ma dimanano dall’influsso divino». Rispondiamo: come dimanano dalla grazia? La volontà è libera ed attiva oppure, come insegna Calvino, è trascinata a viva forza dalla grazia? In tal caso addio libertà umana! L’uomo diventa un automa irresponsabile. Perché allora punirlo se non arriva alla fede, se non si converte, se non vive una vita santa? La colpabilità si riversa tutta su Dio che non gli ha elargito i suoi doni e perciò il Dio dei Cristiani non sarebbe più il Dio della bontà, della misericordia, della giustizia e della santità, appunto perché la volontà di Dio sarebbe causa unica della dannazione dell’uomo. No, ci risponderanno gli oppositori, giustamente inorriditi da queste estreme e spaventose conseguenze, «no, la grazia di Dio non distrugge la nostra libertà. Gli atti che precedono la giustificazione sono frutti della grazia, ma essa li produce senza distruggere la nostra libertà. Essa ci attrae, ci piega, ci induce a questi atti, ci aiuta a compierli, ma non ci sforza. Cristo è pronto a liberarci dal peccato, ma non viola la nostra volontà; e se per effetto di una persistente trasgressione, la volontà stessa è interamente piegata al male, tanto che non consideriamo di esser liberati dallo stesso: né vogliamo accettare la grazia di Cristo, che cosa potrà egli fare per noi? Noi soli siamo la causa della nostra rovina col respingere risolutamente il suo amore» («Guida a Gesù», pagina 37). Ma se è così, perché allora ostinarsi a respingere la dottrina cattolica? Abbiano dunque la franchezza di ammettere che alla giustificazione è necessaria una cosciente e libera cooperazione umana.
• Esaminiamo ora qual è la giustificazione ammessa dai Protestanti (e, più o meno, dai modernisti, ndr.). Simulacro di giustificazione. Essa si riduce a nulla perché gli strumenti di santificazione da Gesù stesso istituiti, i Sacramenti, sono mezzi vuoti e vani. (Notiamo tra parentesi che i Protestanti non ne ammettono ordinaria- mente che due, il Battesimo e quello che loro chiamano la Cena). Difatti non sarebbero essi che segni dell’opera redentrice di Gesù e della sua intenzione purificatrice, un’oggettiva e visibile predicazione della misericordiosa volontà di Dio: loro effetto null’altro sarebbe che una soggettiva eccitazione di fede in Cristo. In tal caso i Sacramenti della Nuova Legge non differirebbero per nulla dai riti sacri dell’Antico Patto. Anch’essi significavano e preannunciavano la futura opera di Cristo, anch’essi servivano ad eccitare la fede e la fiducia nel Salvatore. San Paolo però non è dello stesso avviso. Ai Galati che impressionati dalla pompa delle antiche cerimonie, a cui non vedevano contrapporsi che i semplici e apparentemente meschini riti della Legge Nuova, egli vivamente fa osservare che non si lascino indurre in errore dall’apparenza esterna, ma vogliono colla fede intravedere, oltre il segno esterno e visibile del rito, la realtà meravigliosa che vi si nasconde. Le cerimonie dell’Antica Alleanza erano vuote e impotenti non già perché non potessero eccitare la fede e la fiducia, come è ovvio, ma perché non avevano il potere di trasformare l’uomo internamente, di santificarlo realmente. «Perché dunque — ammonisce l’Apostolo — vi rivolgete di nuovo ad elementi impotenti e vuoti?» (Lett. ai Galati, IV, 9). Se nella dottrina dei Protestanti i mezzi di santificazione sono tali quali sopra abbiamo esposto, ne viene di conseguenza che secondo la stessa dottrina: la stessa giustificazione non sia altro che una finzione, (se si vuole giuridica), ma non una realtà. Per essa l’uomo non viene intimamente trasformato; i suoi peccati non sono distrutti ed annientati: le sue piaghe e ferite non si rimarginano, né si chiudono; egli rimane nel suo interno quale era prima, un ammasso di peccati, di putredine e di fango, essenzialmente guasto e corrotto a causa del peccato di origine e dei suoi propri peccati personali. Però le sue iniquità non vengono più da Dio considerate, non gli vengono più da Dio imputate. Oh! e perché? Perché egli con la fede nella redenzione del suo Signore, si è con Lui unito, ha fatto suoi i meriti di Lui, se li è appropriati, e per conseguenza i meriti infiniti di Gesù si stendono sopra di lui e si frappongono tra lui e la giustizia divina. Che dire di questa dottrina? A noi viene spontaneo alla mente il «sepolcro imbiancato» del Vangelo: come i farisei, così pure i giusti all’esterno apparirebbero purificati e santificati, internamente invece sarebbero pieni «omni impudicitia» (Matt., XIII, 27-28). Oh, davvero che in tal caso l’opera di Gesù sarebbe ben poca cosa! Essa non varrebbe a santificare veramente l’uomo, a riparare veramente la grande perdita, il grande guasto prodotto da Adamo. Se così vana e inefficace è nella sua essenza la giustificazione quale la concepiscono i Protestanti, non migliori saranno le opere.
• Misere e sterili sono le opere dei giusti secondo la dottrina dei riformati. Se il nostro interno non viene realmente trasformato, né i nostri peccati distrutti, né la nostra natura migliorata, ma soltanto è il velo dei meriti di Cristo che sulla nostra miseria si stende a tutto coprire e nascondere, e se ad ottenere quell’effetto null’altro si richiede che la fede in Cristo, parrebbe logico concludere che dunque è inutile sforzarsi di evitare il peccato, e di compiere il bene. E difatti da questa conclusione pare non rifuggissero i primi corifei del protestantesimo, nelle loro violente polemiche contro i Cattolici, conforme al famoso detto, attribuito a Lutero: «Pecca fortiter et crede firmiter». Del resto qualche frase che raccogliamo dalla penna di moderni protestanti parrebbe riallacciarsi a tale conclusione. «Colui che si affatica e pensa di santificarsi con le proprie opere si accinge ad una impresa impossibile» («Guida a Gesù», pagina 67). «Molti pensano di avere una parte in quest’opera di miglioramento. Si sono confidati in Cristo per il perdono dei loro peccati: ora si studiano di vivere giustamente mercé le loro proprie forze. Simili sforzi sono vani!» (ivi, pagina 78). «Vi son di quelli che professano di servire a Dio, affidandosi alle proprie virtù personali per osservare i suoi statuti, migliorare il proprio carattere e assicurarsi la salvezza. I cuori loro non sono mossi da un sentimento profondo dell’amor di Cristo: cercano soltanto di praticare tutti i doveri della vita cristiana, credendo che Dio lo esiga, e guadagnarsi il Paradiso. Simile religione non vale nulla» (ivi, pagina 50). Dunque dobbiamo affidarci al tanto comodo assioma: «Pecca fortiter et crede firmiter»? No: la conclusione che arrideva agli antichi Protestanti, spaventa, e giustamente, i loro tardi nepoti; è troppo pericolosa! Con un’incongruenza logica, famigliare alle eresie, con qualche sapiente(!) aggiustamento, con un’oculata accortezza nell’evitare espressioni troppo spinte e troppo crude, essi metteranno tutto a posto! « L’errore opposto — ci si avverte — e non meno pericoloso, consiste nel credere che la fede in Cristo sciolga l’uomo dall’obbligo di osservare la legge di Dio: poiché per la sola fede siamo fatti partecipi della grazia di Cristo, le opere nostre non hanno più niente che vedere con la nostra redenzione» (ivi, pagina 67). Dunque le opere ci vogliono? «Sì — rispondono — ma tali opere nostre non producono in noi maggiore santificazione: è vano attendersi da loro una forza santificatrice. Le opere buone non si richiedono per santificarci maggiormente e per salvarci: ma naturalmente derivano dalla nostra santificazione. Se siamo uniti con Cristo e coi suoi meriti, da questa unione fluirà spontaneamente l’osservanza dei precetti e le buone opere per effetto della grazia di Cristo che opera in noi. Le opere non sono causa di santificazione, ma soltanto effetto. Se i nostri cuori sono rinnovati all’immagine di Dio, se l’amore divino regna nelle anime nostre, non dovrà la legge di Dio manifestarsi nella nostra vita? Quando il principio d’amore è saldo nel cuore, quando l’uomo è rinnovato all’immagine di Colui che lo ha creato, la promessa del nuovo patto è adempiuta. Io metterò le mie leggi nei loro cuori, e le scriverò nelle loro menti (Ebr., X, 16). E se la legge è scritta nel cuore, come potrebbe non modellare tutta la vita?» («Guida a Gesù», pagina 67). Va bene! Ma se è così, la grazia di Cristo non renderebbe le azioni dei giusti intrinsecamente degne della vita eterna: esse sarebbero accette a Dio solo per un rispetto esterno, per un riflesso dei meriti di Gesù. Ognuno vede come rimarrebbe limitata l’efficacia della redenzione e della grazia di Cristo!
• Un’altra osservazione. Si dice che nell’uomo giustificato per mezzo della fede, la grazia di Dio non può non produrre spontaneamente opere di bene. Come? chiediamo noi. La grazia di Cristo talmente opera nella volontà umana che necessariamente la trascina al bene? No: già sopra ci fu assicurato che «la grazia non impedisce la libertà, non sforza». Dunque se la volontà potrebbe resistere alla grazia e non fare il bene, a cui la grazia porta, bisogna pur dire che l’osservanza della legge richiede la cooperazione umana, lo sforzo nostro. E se l’osservanza della legge è necessaria alla nostra redenzione, poiché «È errore... non meno pericoloso credere che la fede in Cristo sciolga dall’obbligo l’uomo, di osservare la legge di Dio» (ivi., pagina 67), bisogna dunque concludere che alla nostra redenzione è necessario anche il nostro sforzo, sono necessarie le nostre opere. Del resto perché essi stessi i Protestanti nei loro opuscoli, come in quello finora citato, tanto raccomandano l’ubbidienza a Dio, l’osservanza della sua legge, le opere di bene, se tutto ciò non fosse necessario alla salute o non dipendesse oltre che dalla grazia di Dio, anche da noi e dal nostro libero sforzo? Dunque NON sbagliano certo «i molti (che) pensano di aver una parte in quest’opera di miglioramento» («Guida a Gesù», pagina 78) «credendo che Dio lo esiga» (ivi, pagina 50). Dunque è falso che «simile religione non vale a nulla» (ivi).
• Dottrina cattolica sulla giustificazione. Alla dottrina protestante crediamo utile contrapporre quella cattolica. L’eccellenza e l’efficacia dell’opera santificatrice di Cristo splenderà in tutta la sua grandezza e bellezza. Volontà libera dell’uomo e grazia di Dio. La grazia di Dio non è l’unico principio determinante, altrimenti sarebbe finita per la libertà dell’uomo, e insieme cadrebbe il misericordioso disegno di Dio di voler agire nell’uomo secondo la natura libera di lui, e di volerlo nobilitare col farlo concorrere liberamente alla sua salvezza. .Ma neppure la forza umana è sufficiente alla grande impresa. L’impulso violento della concupiscenza, alleata all’ignoranza della mente e alla debolezza della volontà, travolgerebbero l’uomo nel male se la provvida mano di Dio non si tendesse opportuna nel momento critico per preservarlo dalla rovina. Di più, come potrebbe l’uomo con le sole sue forze, che neppure bastano a preservarlo dal peccato, ordinare sé, la sua vita, le sue opere al fine soprannaturale a cui Dio lo destina? Ecco allora intervenire la grazia divina assolutamente necessaria e insieme completamente indebita. L’uomo non ne ha per sé alcun diritto, non può pretenderla. Essa è un dono non solo superiore alle esigenze della natura, ma verso il quale l’uomo ha una positiva indegnità, per causa del peccato originale. Ma allora perché Dio ne è così prodigo; a tutti promette la sua grazia; a tutti è pronto a somministrarla in tanta copia? Unicamente perché i meriti infiniti di Gesù hanno riparato alla nostra indegnità, e ce l’hanno ottenuta. Dunque se l’uomo può tendere alla vita eterna, e indirizzare ad essa la sua vita e le sue opere, lo deve alla grazia di Dio per i meriti infiniti di Gesù N. Signore.
• La grazia eleva le opere naturali. La grazia è un influsso di Dio superiore alle esigenze della natura: quindi essa investendo le azioni umane le dignifica, le eleva, le soprannatura- lizza, fa si che esse siano intrinsecamente ordinate e proporzionate alla vita eterna. Non sono più opere di un semplice uomo, ma il fortunato risultato delle forze umane, e delle forze divine.
• Doni della giustificazione. La grazia non si limita a concorrere alle opere che preparano la giustificazione, e a quelle ancor più eccellenti che la seguono. Essa non è solo un influsso momentaneo diretto a spingere l’uomo ad operare, o ad aiutarlo a ciò; non è solo un concorso attuale (che i teologi chiamano grazia attuale); grazia è pure un altro dono ancor più meraviglioso e misterioso che Dio infonde nella giustificazione e che nell’anima giusta rimane permanentemente, finché non venga ad opporvisi un nuovo peccato mortale. Per tale dono l’anima stessa nella sua essenza viene elevata sopra la sua naturale condizione, soprannaturalizzata (sit venia verbo) acquistando una proporzionata esigenza alla vita eterna, un’esigenza — remota ancora è vero finché dura la vita terrena — a partecipare alla vita intima di Dio, a conoscerlo cioè a faccia a faccia, intuitivamente, come Egli è in sé, e ad amarlo in modo analogo nell’altra vita, in Paradiso. Anche le facoltà spirituali dell’anima vengono elevate e nobilitate da doni infusi, specialmente dalle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, che le rendono capaci di elevarsi verso Dio in modo consono e proporzionato, e di prepararsi così all’unione perfetta con Dio nell’eternità. Per questo si suole dire che è proprio di tale grazia abituale renderci partecipi della natura divina, in quanto cioè ci fornisce un partecipato principio di vita divina; per conseguenza, che ci fa figli di Dio, non per natura, evidentemente, ma per comunicazione ed estensione; che ci fa eredi della vita eterna, in quanto ci dà la capacità intima a godere della stessa felicità di Dio. Anche questo dono ammirabile ci vien da Dio infuso non per i nostri meriti, ma per i meriti di Cristo, nell’atto in cui rimossi con l’aiuto della grazia attuale gli impedimenti del peccato, e predisposta l’anima, Dio gratuitamente ci giustifica. Così brevemente esprime la cosa Sant’Agostino: «È manifesto che chiamò gli uomini Dei, perché deificati dalla sua grazia, non perché nati dalla sua sostanza. Difatti ci giustifica Colui che è Dio per se stesso, non per partecipazione di un altro. Colui poi che ci giustifica, ci deifica pure, perché giustificandoci ci fa figli di Dio... Che se siamo diventati figli di Dio, siamo dunque dei: ma ciò si deve alla grazia di chi ci adotta, non alla sua natura generante» (Sul Salmo 49, 2 — M. 36, 565). Ammirato San Leone Magno ci ammonisce: «Riconosci, o cristiano la tua dignità, e giacche sei diventato partecipe della natura divina, non voler con una condotta indegna ritornare alla bassezza di prima» (Serm. 21 c. 3 — M. 54, 192).
• Effetti della giustificazione. Questi doni meravigliosi non sono sterile abbellimento e decoro. Essi, importano nuove capacità, nuove inclinazioni, nuove e meravigliose attitudini. Per essi l’anima del giusto vien spinta ed aiutata all’osservanza della legge divina, al compimento del bene, all’esercizio di tutte le virtù. Ed ecco sbocciare, come una fioritura smagliante e profumata, gli atti più belli e graditi al Cielo! Ma notiamolo subito, questi atti benché esternamente possano apparire simili, identici anzi a quelli compiuti da un uomo lontano dall’influsso della grazia, in verità ne differiscono immensamente: non solo perché accetti a Dio, ma perché la loro perfezione intrinseca, la loro intima entità è completamente diversa, incomparabilmente superiore. Quelle sono azioni di un semplice uomo, di un principio meramente naturale: queste invece promanano da una causa soprannaturalizzata; provengono da una natura che in virtù della grazia santificante, dice esigenza della gloria celeste: anch’esse quindi portano questa impronta divina, dicono: esigenza alla vita eterna, sono ad essa proporzionate, ne sono degne. E poiché un grado più alto di gloria esige maggior capacità di visione da parte dell’anima, e questa capacità si radica e si fonda nella grazia santificante, ne consegue che un aumento di opere buone nel giusto gli portano maggiore grazia, aumento di santità. Con questa dottrina non si reca detrimento ai meriti di Gesù, come se essi non fossero sufficienti a ottenerci la gloria del Paradiso e avessero bisogno di un nostro contributo. Lo notiamo ancora una volta quanto di bene soprannaturale vi è in noi lo si deve a Cristo; poiché le nostre azioni non sono meritorie se non per la grazia sua che le dignifica. Quindi invece di sminuire l’opera di Gesù, esse maggiormente la esaltano. È tanta la dignità e la santità di Gesù, che unendoci a sé rende anche noi veramente degni e santi, e le nostre opere, pervase dalla sua dignità e santità, degne della vita eterna. Questa breve e semplice esposizione basterebbe, crediamo, per i lettori di buona volontà, a mostrare quanto meglio valga la dottrina cattolica a tutelare l’assoluta necessità della redenzione di Cristo, e la sua mirabile efficacia rinnovatrice. Ma non rispecchierebbe forse essa, anziché la realtà, un sogno, una pia invenzione della Chiesa Cattolica? No: si tratta di una felice ed indiscutibile verità, assicurata in modo inequivocabile dalla parola stessa di Dio, registrata nella Sacra Scrittura. Lo proveremo brevemente.
• Sacra Scrittura e tesi cattoliche. Preparazione e cooperazione dell’uomo. Per arrivare alla giustificazione l’uomo deve prepararsi e cooperare: lo attesta la Sacra Scrittura, presentando Dio che invita alla salvezza ed attende la decisione umana. Un esempio fra mille. « Chiamo in testimonio il cielo e la terra, che vi ho proposto la vita e la morte, la benedizione e la mal edizione. Eleggi dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza» (Deut., XXX, 19). Ciò del resto facilmente ce lo concedono i Protestanti moderni, come abbiamo visto più sopra. Egualmente ci concedono che si richieda la fede, perciò anche su questo punto non ci dilunghiamo. Ma essa non basta, affermiamo noi, altre opere devono influire veramente, altrimenti la fede è inerte e inefficace. San Giacomo ci avverte in generale: «Vedete voi come per le opere è giustificato l’uomo e non per la fede solamente» (Giac., II, 24). In particolare si richiede la penitenza come condizione assoluta per la giustificazione: «Se non farete penitenza, esclama Gesù, perirete tutti allo stesso modo» (Lc., XIII, 3); e San Pietro a coloro che gli chiedono che cosa debbano fare per ottenere misericordia e salvezza risponde categoricamente: «Fate penitenza» (Atti, II, 37-38. Cfr anche Matt., IV, 17 — Mc., I, 15 — Atti, III, 19 etc.). Anche nell’Antico Testamento, infinite volte Dio invitò l’uomo alla penitenza, promettendogli per essa il perdono più completo dei peccati: per esempio Ez., XVIII, 1 ss; Zacc., I, 3. Si richiede di più, e l’accesso ai Sacramenti, prima di tutto al battesimo, e conseguentemente il sigillo della carità infusa da Dio, talmente che se anche vi sia la fede, ma manchi questo, è impossibile essere giusti. San Pietro nel luogo sopra citato parlava ad ascoltatori che, mossi dalla sua predicazione, già avevano concepito in cuore una fede viva e sincera, eppure di questo non si accontenta; per avere salute devono fare penitenza e lasciarsi battezzare: «Fate penitenza e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri peccati» (Atti, II, 38). In questo San Pietro si uniformava all’esplicito insegnamento del suo divino Maestro: «Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo» (Marc., XVI, 15 — «Chi non rinascerà per mezzo dell’acqua e dello Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio» (Giov., III, 5). San Paolo poi dice di se stesso: «Se avessi tanta fede, sì da trasportare i monti, ma non avessi la carità, non sono niente» (I Cor., XIII, 2) cioè non varrei nulla per la vita eterna. Dunque la sola fede non basta a costituire l’uomo giusto.
• San Paolo Insegna che basta la fede? Ci si obbietta: «Nella dottrina del Nuovo Testamento, specialmente in San Paolo, la giustificazione è attribuita alla fede». Rispondiamo: Viene attribuita alla fede perché essa è necessaria ed è il primo movimento dell’uomo verso la salute, sicché si può dire che la sua salvezza prenda le mosse dalla fede, viene dalla fede. Ma ciò non vale in senso esclusivo, come se bastasse la sola fede, per la semplice ragione che negli stessi scritti ispirati la salvezza viene attribuita anche ad altri atti, perché anch’essi richiesti; l’abbiam visto poco fa. Per questo mai la Sacra Scrittura, in nessun luogo afferma bastare la sola fede. Del resto la fede, suppone e inferisce tutto quanto si richiede da parte dell’uomo. Chi ha una fede vera e sincera non può non riconoscere e ammettere, almeno implicitamente, tutte le condizioni fissate da Dio per l’acquisto della salute. San Paolo ce lo dichiara apertamente: «In Cristo Gesù nulla importa né la circoncisione né il prepuzio: ma la fede — quale? — quella che opera per la carità» (ai Gal., V, 6). I nemici obiettano: «Ma pure San Paolo è troppo esplicito nel richiedere la sola fede e nell’escludere ogni altra opera. Eccone le prove: “Sapendo come non è giustificato l’uomo per le opere della legge, ma per la fede di Gesù Cristo, crediamo anche noi in Gesù Cristo, per esser giustificato, per la fede di Cristo, e non per le opere della legge: dappoiché nessun uomo sarà giustificato per le opere della legge” (ai Gal., II, 16). “Imperocché per grazia siete stati salvati mediante la fede, e questo non da voi; imperocché è dono di Dio: non in virtù delle opere, affinché nessuno si glorii” (agli Efes., II, 8-9). “Non per le opere di giustizia fatte da noi, ma per sua misericordia ci fece salvi” (a Tit., III, 5)». Al primo testo addotto rispondiamo, che esso non si riferisce alla nostra questione. In tutta la Lettera ai Galati San Paolo vuol provare che i riti dell’Antica Legge non valevano da sé a giustificare, ma solo un virtù della fede in Cristo venturo: di queste «opere della legge» parla l’Apostolo, e non degli atti che precedono la giustificazione e che la preparano. Negli altri due testi non si tratta propriamente del modo con cui si arriva alla giustificazione, ma della perfetta gratuità della grazia. Già lo notammo, gli atti che precedono, preparano, dispongono la giustificazione, non la meritano in senso proprio, nessun di tali atti è un vero merito, poiché il merito suppone già la grazia santificante e in essa si fonda. Gli stessi atti preparatori, come proveremo tra poco con la Sacra Scrittura, esigono l’aiuto della grazia attuale, che è dovuta non ai nostri meriti, ma unicamente alla bontà divina. Quindi San Paolo può affermare che non siamo salvati per le opere nostre, cioè per le opere compiute con le nostre forze naturali, ma per la grazia di Cristo.
• Influsso soprannaturale nelle opere preparatorie. Che la grazia sia assolutamente necessaria, non v’è dubbio. Mai Gesù fu così chiaro ed esplicito come in affermare questo. «Senza di me non potete far nulla». S’intende, non possiamo da noi far nulla che serva a condurci alla salvezza e al cielo: infatti Gesù nel luogo citato parla dei frutti di vita eterna: si comprendono quindi in ciò non solo gli atti che seguono alla giustificazione, ma anche quelli che la precedono e la preparano: fede, pentimento ecc.; anch’essi sono frutti di vita, perché ordinati anch’essi alla salute e alla vita. Come un tralcio non può produrre assolutamente alcun frutto se non riceve dal tronco della vite la linfa vitale, così anche noi senza l’influsso di Gesù, un influsso che ci giunge immediatamente da Gesù e ci pervade intimamente, appunto come l’influsso della vite nel tralcio è qualche cosa di intimo, di immediato: «Io sono la vite, voi i tralci... senza di me non potete far nulla». Di quale natura sarà quest’influsso divino? Non si tratterà certo dell’influsso ordinario di Dio come causa prima, necessario, secondo che insegna la retta filosofia, ad ogni causa creata per produrre qualunque operazione consona alla sua essenza. Questo concorso divino viene fornito alle creature per le esigenze di natura, e non per riguardo alle redenzione di Cristo, e per mezzo di Lui. Dunque per compiere azioni ordinate alla salute è necessario un concorso speciale di Dio, concesso per i meriti di Gesù, oltre le esigenze della semplice natura; è necessario un influsso soprannaturale. L’operazione che ne seguirà non potrà dunque essere un’entità meramente naturale, sia perché ogni effetto deve proporzionarsi alla causa, sia perché per avere un’entità meramente naturale non si richiede certo un influsso, una forza speciale, indebita alla natura, e quindi soprannaturale. Tutto ciò dobbiamo concludere se non vogliamo svuotare le parole sacrosante del Salvatore, e renderle espressioni senza senso determinato. Alle stesse affermazioni si arriva attraverso un passo ben famoso dell’Apostolo Paolo: «Io piantai. Apollo innaffiò: ma Dio diede il crescere, di modo che non è nulla, né colui che pianta, né colui che innaffia, ma Dio, che dà il crescere». Per arrivare alla fede, alla salute, per crescere nella santità acquistata, ci vuole sì la predicazione, e la cura esterna dell’apostolato — colui che pianta e colui che innaffia — ma ciò non basta e nulla dà, se manca l’influsso superiore di Dio. In questo senso sono da spiegarsi pure le parole di Nostro Signore: «Nessuno può venire a me — (per mezzo della fede, della conversione, della carità) — se non lo trae il Padre che mi ha mandato» (Giov., VI, 44) e quelle di San Paolo: «Imperocché Dio è che opera in voi e il volere e il fare, secondo la buona volontà» (ai Filip., II 13); «Non perché noi siamo idonei a pensare alcuna cosa da noi come da noi: ma la nostra idoneità è da Dio» (II ai Cor., III, 5).
• Natura della giustificazione. La giustificazione si compie per mezzo di una rinnovazione vera dell’anima. È una nuova nascita, una rigenerazione. «In verità in verità ti dico: chiunque non rinascerà da capo, non può vedere il regno di Dio... In verità in verità ti dico: chi non rinascerà per mezzo dell’acqua e dello Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio». Una nuova rigenerazione suppone qualche cosa di intimo mutata, un nuovo principio di vita e di operazione diverso dal precedente.
• Trasformazione completa. Perciò l’Apostolo afferma che nella giustificazione si ha una nuova operazione creativa da parte di Dio, il cui risultato è dare una nuova creatura, che cioè abbia qualche elemento fondamentale diverso da quelli che prima si avevano. «Imperocché in Cristo Gesù nulla vale l’essere circonciso, o incirconciso, ma la nuova creazione» (ai Gal., VI, 15). «Se alcuno pertanto è in Cristo, egli è una nuova creatura; le vecchie cose sono passate; ecco che tutte le cose sono rinnovellate» (II ai Cor., V, 17). E in questo sta la grande diversità tra i riti del Vecchio Testamento e quelli del Nuovo; tra il battesimo di Giovanni e quello di Gesù. Quelli soltanto provocavano alla fede e alla penitenza, ma da sé nulla di nuovo concedevano, perché vuoti; questi invece contengono il dono di Dio, la grazia, e la danno, (vedere la Lettera ai Galati già citata più sopra; e San Matteo III, 11). Nessuna meraviglia quindi che la Sacra Scrittura dica che i peccati non solo non sono più imputati, ma vengono cancellati veramente, distrutti. L’anima è rinnovellata! «Anche se i vostri peccati fossero (rossi) come la porpora, diverranno bianchi come la neve» (Is., I, 18). «E tali (cioè adulteri — ladri ecc.) foste alcuni di voi, ma siete stati mondati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio» (I ai Cor., VI, 11). Quindi «niente di condannevole si trova più in coloro che (per mezzo della giustificazione) sono in Cristo Gesù» (ai Rom., VIII, 1).
• Figli di Dio. Ma il nuovo dono, il nuovo elemento infuso, non solo ha un’efficacia distruttiva, trasforma anche e innalza l’anima sopra la sua condizione naturale, facendola partecipe in qualche modo dei principi divini e delle attitudini divine, in altre parole dandole una partecipazione della natura divina: «Per mezzo del quale (di Gesù Dio) fece a noi dono di grandissime e preziose promesse: affinché per queste diventaste partecipi della divina natura» (II di Pietro, I, 4). Per questo San Paolo proclama: «Che quelli che sono mossi dallo Spirito di Dio, sono figli di Dio» (ai Rom.. VIII, 15): e, come nota giustamente San Giovanni, non figli di Dio per una semplice adozione legale, ma lo sono realmente, benché non per natura, ma per partecipazione. Ora è ovvio che uno non può essere veramente figlio, se non partecipa veramente della natura del padre. «Osservate quale carità ha dato il Padre a noi che siamo chiamati figli di Dio e lo siamo» (I di Giov., III, 1). L’ufficio di questo dono partecipato è appunto quello di comunicarci la capacità di ciò che Dio ha per natura, cioè delle sue intime operazioni, della visione intuitiva dell’essenza divina e dell’amore proporzionato. «Carissimi, già fin d’adesso siamo figli di Dio; ma non ancora si è manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quand’Egli apparirà, saremo simili a Lui; perché lo vedremo qual Egli è» (I di S. Giov., III, 2). È vero che, come nota San Giovanni, ora non godiamo ancora di questa visione, ma il principio, il germe è in noi già deposto: già ne abbiamo la capacità e l’esigenza nel dono della grazia di Dio, in questa misteriosa partecipazione della divinità; già abbiamo le mirabili inclinazioni operative che a quella visione e quell’amore ci preparano. «La carità di Dio è stata diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, il quale è stato a noi dato» (ai Rom., V, 5). E «con la carità sono intimamente congiunte la fede, la speranza, la carità, queste tre cose» (I ai Cor., XIII, 13). «Imperocché non ha dato a noi Iddio uno spirito di timidità, ma di fortezza, e di dilezione e di saggezza» (II a Tim., I, 7). Si ha come un mirabile e nuovo organismo (ci si passi la metafora) soprannaturale che Dio produce in noi: una elevazione dell’essenza, una elevazione delle facoltà spirituali per la nuova vita divina a cui siamo destinati. Data questa affinità, questa assimilazione misteriosa dell’anima giusta con Dio, è cosa naturale che tra essa e il suo Signore nasca e intercorra uno scambio di affettuoso amore, di mutua compiacenza e di mutua dedizione, una vera e propria amicizia. È appunto noto l’antico effato (enunciato), che l’amicizia o presuppone eguaglianza tra coloro che si amano, o tenta, per quanto è possibile, di stabilirla. Dio nella sua benigna bontà si degna sollevare l’uomo a sé, quanto è possibile a una pura creatura, per poterlo amare come un tenero amico. «Chi ama me sarà amato dal Padre mio; e io lo amerò e gli manifesterò me medesimo... Chiunque mi amerà, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e verremo da lui e faremo dimora presso di lui» (S. Giov., XIV 21-23- «Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama, etc...»). «Voi siete miei amici se farete quello che vi comando. Non vi chiamerò già più servi, perché il servo non sa quel che faccia il suo padrone. Ma vi ho chiamati amici, perché tutto quello che intesi dal Padre mio, l’ho fatto sapere a voi» (S. Giov., XV, 14 ss).
• Valore delle opere del giusto. In virtù della grazia santificante l’anima giusta e tutta la sua vita e la sua attività vengono proporzionate alla gloria eterna, e le sue opere acquistano un’esigenza a tale gloria, cioè diventano meritorie di gloria e quindi anche di maggior grazia e santità. Così ci attesta la Sacra Scrittura. In innumerevoli luoghi il Paradiso, la gloria eterna è promessa a chi compie opere buone, è concessa per esse: sono esse la ragione della salvezza. Già nel discorso della montagna Gesù ce lo insegna più volte. «Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli... Beati coloro che hanno il cuore puro, perché essi vedranno Dio... Beati quei che soffrono persecuzione per amore della giustizia, perché di questi è il regno dei cieli» (Matt., V, 3 ss.). E nell’estremo giudizio rivolgendosi ai giusti Gesù esclamerà: «Venite, benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato a voi sin dalla fondazione del mondo». Ora qual è la ragione di quest’invito al regno, di questa eterna predestinazione? «Imperocché ebbi fame e mi deste da mangiare; ebbi sete e mi deste da bere; fui pellegrino e mi ricettaste; ignudo e mi vestiste; carcerato e veniste da me... In verità vi dico: ogni volta che avete fatto qualche cosa per uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l’avete fatto a me». Ora il bene che si concede per ragione di una prestazione, per un lavoro, per una fatica deliberatamente assunta si chiama premio, e il premio ha come correlativo, nell’estimazione umana, il merito; quella prestazione, quel lavoro, quella fatica, ragione del premio, si dicono e sono meritorie. Del resto esplicitamente il regno celeste nella Sacra Scrittura è chiamato mercede, retribuzione, corona : ora è evidente che così si può chiamare soltanto ciò che si è meritato, strettamente meritato, altrimenti non sarebbe una vera mercede, ma un semplice dono grazioso. «Rallegratevi ed esultate —dice Gesù a quelli che sono perseguitati per causa sua — perché grande è la vostra mercede nei cieli». (Matt., V, 12). E queste sono pure le espressioni con cui ordinariamente San Paolo esprime il concetto del cielo e con cui anima i fedeli e se stesso alla generosità nel servizio di Dio. «Ognuno riceverà la propria mercede» (I ai Cor., III, 8). «Sapendo che dal Signore avrete la mercede della eredità, servite a Cristo Signore» (ai Coloss., III, 24). «Mi avanzo verso il segno, verso il premio della superna vocazione, in Cristo Gesù». «Ho combattuto nel buon arringo, ho terminata la corsa, ho conservata la fede. Del resto è serbata a me la corona della giustizia, la quale a me renderà il Signore giusto in quella giornata; né solo a me, ma anche a coloro che desiderano la sua venuta» (II a Tim., IV, 7-8). Si noti bene: si tratta di un premio strettamente dovuto, di giustizia; perché Dio non può negarsi di dare ciò che ha promesso a chi lavora per Lui, Dio non può non coronare col premio un’esigenza da Lui, per mezzo della grazia, impressa nelle opere del giusto. Accenniamo ad altri testi analoghi: ai Rom., II, 7 ss.; I ai Cor., III, 8; II ai Cor., V, 10; IX 6. Anche nell’Apocalisse il Signore ammonisce: «Sii fedele fino alla morte, e ti darò la corona della vita» (Apoc., II, 10).
• Conclusione. Questa dottrina cattolica tanto ben fondata nella Sacra Scrittura, esalta la piena sufficienza dell’opera e dei meriti di Gesù, e insieme eccita e muove i cuori umani alla più alta perfezione, all’imitazione più fedele delle divine virtù del Redentore, mentre provoca in essi la più sincera gratitudine verso la misericordia divina, accende più vivo e più ardente l’incendio della celeste carità. Una dottrina così ben sicura nel dogma, e così efficace nella pratica, non può non esser vera, non può non dimanare da Dio fonte di ogni verità e di ogni bontà.
Per il P. Carlo Bozzola SJ e per gli onesti autori menzionati: + Réquiem aetérnam dona eis, Dómine, et lux perpétua lúceat eis. Requiéscant in pace. Amen. +
A cura di CdP
- Comunicato numero 217. Cosa deve la donna alla Chiesa (Seconda parte)
- Comunicato numero 216. Cosa deve la donna alla Chiesa (Prima parte)
- Comunicato numero 215. Ascetismo cristiano e vita moderna
- Comunicato numero 214. I miracoli di Gesù e la critica razionalista
- Comunicato numero 213. La verità su celibato e continenza
- Comunicato numero 212. Perché dobbiamo soffrire? Perché il dolore?
- Comunicato numero 211. Che cos’è la predestinazione delle anime?
- Comunicato numero 210. La verità sui fondatori del Protestantesimo
- Comunicato numero 209. La Chiesa e lo Spiritismo
- Comunicato numero 208. Che cos’è la Bibbia?










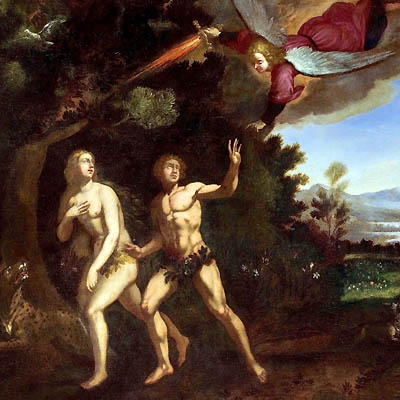




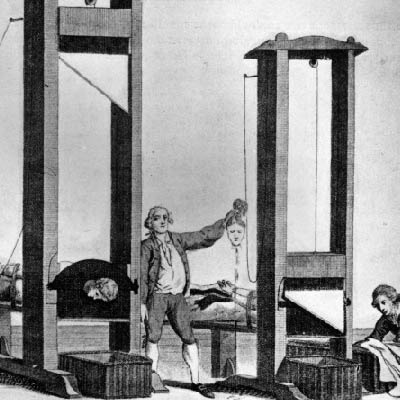
.jpg)








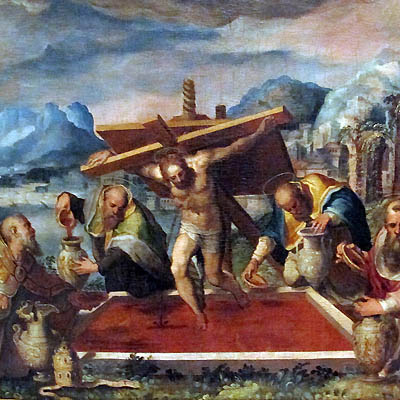







































![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)