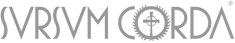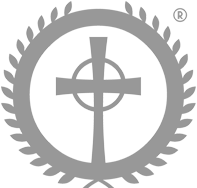Stimati Associati e gentili Sostenitori, oggi, per grazia di Dio, studieremo «Il Vangelo secondo San Marco». Abate Giuseppe Ricciotti («Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, 7a Edizione, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941),
• § 127. Il secondo Vangelo è attribuito a Marco. Gli Atti parlano più volte di un Giovanni chiamato Marco (12, 12.25; 15, 37), la cui madre si chiamava Maria ed aveva una casa a Gerusalemme, come altrove si parla di un Giovanni (Atti, 13, 5.13), e di un Marco (ivi, 15, 39; Coloss., 4, 10; Filem., 24; I Pietro, 5, 13): in tutti e tre i casi deve ben trattarsi della stessa persona, essendo usanza comunissima presso i Giudei di quel tempo di assumere un nome greco-romano oltre a quello giudaico. È certo, poi, che a questo Giovanni Marco fu attribuito nell’antichità il secondo Vangelo. La casa della madre di Marco, a Gerusalemme, era luogo d’adunanza per i cristiani della città; ivi anche si rifugiò Simone Pietro quando fu liberato miracolosamente dal carcere nell’anno 44. Marco era cugino dell’insigne Barnaba, e da esso e da Paolo insieme fu condotto ad Antiochia. Ma dai due si staccò Marco durante il primo viaggio missionario di Paolo, a Perge di Pamfilia, tornandosene a Gerusalemme. Il distacco dispiacque a Paolo, che nel suo secondo viaggio si rifiutò di condurre seco Marco, mentre il cugino Barnaba desiderava condurlo: perciò Barnaba a sua volta si staccò da Paolo, recandosi con Marco nell’isola di Cipro sua patria. La fermezza di Paolo non gli alienò però l’animo di Marco; una decina d’anni più tardi, verso il 61-62, Marco era di nuovo presso Paolo a Roma, e gli fu d’aiuto e di conforto mentre l’apostolo aspettava d’esser giudicato da Nerone (Coloss. 4, 10-11; Filem., 24). Fra gli anni 63 e 64 Marco era a Roma a fianco a Pietro, che trasmetteva da Babilonia (Roma) i saluti del suo figlio Marco (I Pietro, 5, 13). Nell’anno 66 Marco era in Asia Minore, perché Paolo scrivendo da Roma a Timoteo in Efeso gli raccomandava: Prendi Marco e conducilo teco; mi è infatti utile per il ministero (II Timoteo, 4, 11). In questi dati, offerti dal Nuovo Testamento, le relazioni di Marco con Paolo sono più numerose ed importanti delle sue relazioni con Pietro: tuttavia la concorde tradizione successiva mette in rilievo assai maggiore le relazioni di Marco con Pietro, mostrando con ciò che le proprie informazioni non dipendono dalle notizie occasionali del Nuovo Testamento. Se Pietro, in realtà, chiama Marco suo figlio è probabile che lo avesse battezzato: è anche molto verosimile che, per la famiglia di Marco, Pietro avesse una particolare affezione, giacché diretta-mente in casa di lui si rifugiò ancora sbalordito per la propria miracolosa liberazione dal carcere. Tuttavia queste notizie non alludono ad una qualsiasi collaborazione di Marco al ministero apostolico di Pietro; la quale, invece, è attestata fermamente dalla tradizione successiva, soprattutto riguardo alla composizione di uno scritto evangelico.
• § 128. Anche qui, come per il Vangelo di Matteo, la testimonianza più antica e autorevole è offerta da Papia (§ 114), il quale scrive: Anche questo diceva il Presbitero: Marco, divenuto interprete di Pietro, scrisse esattamente, ma non già con ordinamento, quanto si ricordò delle cose o pronunziate o operate dal Signore. -Egli, infatti, né udì il Signore né fu al seguito di lui, bensì più tardi, come ho detto, di Pietro. Costui secondo le necessità faceva le istruzioni, ma non quasi mirando a fare una coordinazione dei detti del Signore; cosicché Marco non è incorso in alcun difetto, scrivendo talune cose così come si ricordò. Ad un solo punto egli fece attenzione, a non tralasciare nulla di quelle cose che udì e a non mentire in nulla in esse (in Eusebio, Hist. eccl., II, 39, 15). Questa testimonianza è più antica di Papia stesso, perché egli nel primo periodo - cioè fino a pronunziate o operate dal Signore - riporta l’affermazione del Presbitero Giovanni. Se questo Giovanni sia l’Apostolo ed evangelista, ovvero sia una persona differente da lui, è questione qui secondaria (§ 158), giacché nel caso presente basta assicurarsi che la relativa affermazione risale al secolo I. È anche superfluo ricordare che le osservazioni già fatte (§ 114 segg.) a proposito di Matteo, circa il valore delle parole «ordinamento», «coordinare» e «detti» presso Papia, conservano anche qui il loro pieno valore. In quale senso Marco divenne «interprete» di Pietro? La voce in sé può significare sia l’interprete delle parole, cioè il traduttore, sia più genericamente l’interprete del pensiero, cioè quasi un amanuense o un segretario. Ambedue queste interpretazioni sono sostenibili, e di fatto sono state sostenute: del resto, ambedue possono corrispondere ad una realtà successiva, in quanto che Pietro - il quale nei primi anni del suo apostolato fuor dalla Palestina doveva essere tuttora poco esperto nella lingua greca e ancor meno nella latina - potè servirsi di Marco dapprima come vero traduttore estemporaneo, e più tardi come amanuense e segretario. Lo scritto di Marco, secondo le affermazioni del Presbitero e di Papia, è dunque un’«esatta» copia della catechesi orale di Pietro: perciò anche è privo di «ordinamento», perché Pietro parlava occasionalmente «secondo le necessità» degli ascoltatori, ma senza voler «fare una coordinazione», né metodica né compiuta, delle cose «o pronunziate o operate» da Gesù.
• § 129. Questi dati si ritrovano tutti nel nostro Vangelo di Marco. Esso si restringe entro i limiti che già riscontrammo esser abituali alla catechesi di Pietro (§ 113), perché comincia col battesimo di Gesù da parte di Giovanni il Battista e termina con le apparizioni di Gesù dopo la resurrezione (cfr. Atti, 10, 37-41). Inoltre, è uno scritto che non ha «ordinamento», secondo il rilievo fatto dal Presbitero e poi confermato da Papia. Se il Presbitero è Giovanni l’evangelista, si può pensare che l’«ordinamento» mancante sia quello cronologico, giacché il Vangelo di Giovanni è il più accurato dei quattro nel fissare la cronologia dei fatti di Gesù (§ 163), mentre in Marco la consecuzione cronologica è in realtà talvolta generica e talvolta mancante. Ma, qualunque sia il giudizio del Presbitero, Papia non può aver pensato che all’«ordinamento» logico, perché egli confrontando Marco con Matteo preferisce quest’ultimo, come già rilevammo, sebbene l’«ordinamento» di Matteo sia meno cronologico anche di quello di Marco. La spiegazione di questa mancanza d’«ordinamento» è fornita dallo stesso Papia. Marco nel suo scritto ha seguito la predicazione di Pietro; il quale, parlando occasionalmente, sceglieva alcuni temi isolati della sua abituale catechesi, e indirizzandosi a pagani preferiva ai discorsi di Gesù i fatti biografici di lui come più adatti a quegli uditori. E infatti Marco ha per buona parte l’aspetto di una raccolta di aneddoti biografici, che corrispondono alle «talune cose» di cui, secondo Papia, l’autore si ricordava: mentre poi è privo degli ampi discorsi di Matteo, pur essendo designato come una raccolta «non coordinata».
• § 130. Le attestazioni successive confermano e precisano quella del Presbitero e di Papia. A mezzo il secolo II Giustino martire, citando una notizia ch’è particolare a questo Vangelo (Marco, 3, 17), la dice contenuta nelle «Memorie» dello stesso Pietro (Dial. cum Tryph., 106); la quale designazione non deve far pensare che Giustino si riferisca a qualche scritto apocrifo, del resto totalmente ignoto, bensì dimostra che egli ritiene lo scritto dell’«interprete» di Pietro come una fedele eco della catechesi di costui. Verso il 180 Ireneo, nel passo che già vedemmo (§ 123), attesta che Marco fu interprete di Pietro e scrisse secondo la predicazione di lui. Verso il 200 Clemente Alessandrino aggiunge importanti particolarità riguardo alle circostanze ed al luogo in cui fu scritto questo Vangelo. Parlando dell’apostolato di Pietro a Roma, Eusebio dice: Le menti degli ascoltatori di Pietro furono illuminate da un raggio di pietà sì grande, che non giudicarono sufficiente contentarsi di una sola ascoltazione né di una istruzione non scritta circa l’annunzio divino; bensì con esortazioni d’ogni genere insistettero presso Marco, di cui va in giro il Vangelo e che era seguace di Pietro, affinché lasciasse anche per iscritto una memoria dell’istruzione trasmessa loro a voce, e non cessarono fino a che quello ebbe compiuto: e così furono essi la cagione per cui fu scritto il Vangelo chiamato secondo Marco. Avendo poi risaputo l’accaduto l’apostolo (Pietro) - a quanto si dice - per una rivelazione fattagli dallo Spirito, si compiacque dello zelo di quei tali, e concesse lo scritto per la lettura nelle adunanze. Clemente riferisce questo fatto nel sesto delle Ipotiposi, e una testimonianza conforme alla sua fa il vescovo di Jerapoli chiamato Papia (Hist. eccl. II, 15, 1-2). Lo stesso fatto è ripetuto dal medesimo Clemente in un altro frammento (Hypotyp. ad I Petri, 5, 14), ove si aggiunge solo il particolare che coloro che a Roma indussero Marco a scrivere erano «cavalieri di Cesare». Un terzo riassunto, sempre dalle Ipotiposi, fa Eusebio: Inoltre in questi stessi libri Clemente espone, circa la serie dei Vangeli, la tradizione degli antichi presbiteri, che è questa. Egli dice che sono stati scritti dapprima i Vangeli che contengono le genealogie (Cioè Matteo e Luca; ma la priorità di Luca su Marco è insostenibile), e che quello secondo Marco ha avuto la seguente origine. Avendo Pietro predicato pubblicamente a Roma la parola (di Dio) ed esposto il Vangelo in virtù dello Spinto, i molti ch’erano stati presenti esortarono Marco, come colui che lo aveva seguito da gran tempo e si ricordava delle cose dette, di mettere in iscritto le cose pronunziate. Avendo fatto (ciò, Marco), consegnò il Vangelo a quelli che l’avevano pregato. Pietro, risaputo ciò non volle esplicitamente né impedire né incitare (Hist. eccl., VI, 14, 5-7). Come si vede, le tre attestazioni clementine concordano sul punto essenziale, che è di far comporre il Vangelo di Marco a Roma come prodotto diretto della catechesi di Pietro. Molte altre sono le attestazioni successive che confermano questo punto essenziale, ma possono considerarsi superflue (Tertulliano, Adv. Marcion., IV, 5; Origene, in Eusebio, Hist. eccl., VI, 25 ; ecc.). È invece di speciale importanza la notizia, del tutto inaspettata, secondo cui Marco sarebbe stato «dalle dita monche»; questo termine gli è applicato in greco da Ippolito (Refut., VII, 30, 1) e altrettanto fa in latino l’antico Prologo latino premesso al suo Vangelo, aggiungendovi una spiegazione (ideo quod ad ceteram corporis proceritatem digitos minores habuisset) nonché la solita conferma che Marco fu interprete di Pietro e che scrisse il suo Vangelo in Italia. Questa notizia delle dita monche è dimostrata autorevole dalla stessa sua stranezza: non c’era, infatti, alcun motivo per inventare arbitrariamente una particolarità fisica di questo genere, che nel campo morale non ha alcun valore; la notizia invece, del tutto corrispondente alla realtà, deve provenire dai ceti del cristianesimo di Roma, a cui apparteneva anche Ippolito. Tale corrispondenza geografica, sebbene a proposito di una minuzia, è eloquente.
• § 131. Quanto al tempo in cui Marco scrisse il suo Vangelo abbiamo come argomento certo la quasi costante attestazione dell’antichità, secondo cui egli è cronologicamente il secondo evangelista, e quindi anteriore a Luca: e ciò è confermato dalla critica odierna, che ammette concordemente che Marco sia stato conosciuto ed impiegato da Luca. Perciò il secondo Vangelo dovette essere scritto dopo l’anno 55, che già assegnammo come estremo limite inferiore di Matteo (§ 123), ma prima del 62, che è la data approssimativa di Luca (§ 139): nel periodo, dunque, fra gli anni 55 e 62 Marco dovette trovarsi a Roma insieme con Pietro. Ora, questa presenza di Marco a Roma è confermata, almeno nei suoi ultimi anni, dai passi già visti delle Lettere di Paolo ai Colossesi e a Filemone, se tali lettere furono scritte - com’è sommamente probabile - appunto verso gli anni 61-63 e precisamente da Roma. Che il Vangelo di Marco possa assegnarsi a tale periodo, sembra impedirlo il già citato passo di Ireneo (§ 123), in cui si dice che dopo la dipartita di costoro (cioè di Pietro e Paolo), Marco, il discepolo e l’interprete di Pietro, ci trasmise anch’egli per iscritto le cose predicate da Pietro. In questo passo il senso di dipartita (§ 403) è certamente quello di morte, e non di assenza per viaggio come taluni moderni hanno supposto: quindi bisognerebbe scendere a dopo l’anno 67 (o 64). Sarebbe anche artificioso e non persuasivo interpretare l’espressione ci trasmise nel senso che, solo dopo la morte di Pietro e Paolo, Marco «pubblicò» e «divulgò» il suo scritto composto già prima: al contrario le varie attestazioni antiche, e specialmente quelle di Clemente Alessandrino, s’interpretano in maniera spontanea solo ritenendo che lo scritto di Marco circolasse subito appena finito. Se pertanto non si vuol supporre che Ireneo parli in maniera solo approssimativa senza insistere sulla concomitanza cronologica, come osservammo anche a proposito di Matteo, bisognerà respingere la sua affermazione (seppure è trasmessa bene dai manoscritti) essendo in manifesto contrasto con testimonianze storiche antiche e con osservazioni critiche moderne.
• 132. L’esame interno dello scritto di Marco svela notevoli tracce della sua particolare origine. Brevissimo fra tutti i Vangeli, esso ha appena una decima parte del suo contenuto che gli è propria, mentre i restanti nove decimi si ritrovano tutti negli altri due Sinottici. Il contenuto poi, così breve, è impiegato a narrare molti miracoli di Gesù, poche parabole, pochissimi discorsi. I miracoli narrati negli altri due Sinottici si ritrovano tutti, salvo quattro, in Marco, ma esso per conto suo ne aggiunge pure degli altri; per contrapposto non vi si ritrovano discorsi d’importanza fondamentale, quale il Discorso della montagna, come pure manca la cura, vivissima in Matteo, di far notare che in Gesù si sono adempiute le antiche profezie messianiche. La descrizione poi dei fatti è vivida, immediata, e scende a minuzie inaspettate che spesso mancano negli altri due Sinottici; ma anche qui, per contrapposto, la lingua greca è povera e grezza, il periodare disadorno e anche duro, i procedimenti stilistici elementari e uniformi. Sembra leggere la lettera di un intelligente campagnolo ove questi descriva avvenimenti meravigliosi di cui sia stato testimone oculare: la descrizione di siffatto narratore risulta tanto più vivida ed immediata, quanto più profonda è l’impressione ricevuta dagli avvenimenti e quanto più sono semplici e limitati gli argomenti letterari di cui il narratore dispone.
• § 133. Ebbene, questi rilievi quadrano perfettamente nella cornice offertaci dalla tradizione. Se Pietro aveva bisogno di Marco come di «interprete», costui a sua volta non doveva essere niente più che un empirico nel campo d’idiomi stranieri, non già un fine letterato da tavolino, e neppure uno scrittore fornito dell’esperienza di un Luca o di un Paolo o dello stilizzatore della Lettera agli Ebrei. Pietro dunque, nelle sue catechesi orali, aveva narrato con la semplice ma potente efficacia del testimone oculare: il suo interprete fissò in iscritto, con l’arte ingenua di cui disponeva, le narrazioni di lui. Pietro, inoltre, parlava in Roma, a uditori provenienti in maggioranza dal paganesimo, inesperti di dottrine e tradizioni ebraiche; e appunto per questo troviamo che in Marco Gesù è presentato, non tanto come il Messia atteso dagli Ebrei, quanto come il Figlio di Dio, signore taumaturgo della natura, dominatore delle potenze demoniache: mentre, al contrario, sono tralasciate questioni dottrinali che avrebbero interessato particolarmente uditori giudei, quali quelle sulle osservanze legali, sullo spirito dei Farisei, e simili. Vi si riportano, quasi per particolare riverenza, precise parole aramaiche pronunziate da Gesù, come (...) in Marco, 3, 17; 5, 41; 7, 34; ecc., ma subito appresso sono tradotte in greco, com’era necessario per ascoltatori o lettori di Roma; per la stessa ragione sono spiegate particolari usanze giudaiche, come quella della lavanda delle mani prima dei pasti (7, 3-4). Fiutando poi sagacemente, si percepisce nello scritto uno spiccato sentore di romanità: più frequenti che presso gli altri due Sinottici vi sono impiegati in greco vocaboli latini, come centurio (15, 39.44), spiculator (6, 27), sextarius (... 7, 4) e altri; affiorano anche espressioni che sono più latine che greche, tanto da sembrare italianismi, come quella che letteralmente dice lo presero a vergate [Cfr. la frase di Cicerone accipere aliquem verberibus (ad necem)] (in 14, 65; mentre in Matteo, 26, 67, lo vergarono) e qualche altra. Né si giustificherebbero, se non perché indirizzate a lettori latini, precisazioni come queste: due minuzzoli, che è (un) quadrante, in cui si nomina la moneta romana equivalente alle due greche (12, 42); oppure dentro l’aula, che è (il) pretorio, in cui il preciso termine militare romano è soggiunto a quello greco più generico (15, 16). Un tratto assai probabile di romanità si trova anche nell’episodio di Simone il Cireneo che aiutò Gesù a portare la croce: l’episodio è narrato anche dagli altri due Sinottici, ma il solo Marco aggiunge che Simone era il padre di Alessandro e di Rufo (15, 21). Perché questa inaspettata indicazione, se i due figli non sono mai più nominati in tutti i Vangeli? La spiegazione sembra offerta dalla chiusa della Lettera di Paolo ai Romani, ove l’apostolo incarica di salutare, certamente in Roma, Rufo l’eletto nel Signore e la madre sua e mia (Rom., 16, 13). È chiaro che questo Rufo era persona insigne nella cristianità di Roma, e altrettanto la madre di lui, che Paolo venera al punto di chiamarla madre propria ; ma anche la menzione di Rufo in Marco non si spiega se non perché riferita a persona notissima: è quindi del tutto spontaneo supporre che i due Rufi siano la stessa persona, tanto più che il nome di Rufo doveva essere ben raro a Gerusalemme, donde la persona proveniva (§ 604).
• § 134. Lo scritto di Marco, infine, ha un atteggiamento particolare di fronte alla persona di Pietro. Mentre in qualche episodio che lo riguarda ha talune notizie in più, come nella guarigione della suocera di lui (1, 29-31), giammai in nessun tratto lo adula, anzi tralascia fatti per lui onorifici narrati dagli altri Sinottici, quali il camminar sulle acque, il didramma trovato in bocca al pesce, e perfino il conferimento del primato. La ragione di questo atteggiamento, in conferma della tradizione, è che Pietro nelle sue catechesi orali non amava insistere su episodi onorifici a lui stesso, e il suo «interprete» ha fedelmente rispecchiato tale modestia nel suo proprio scritto. Ma esiste forse in questo scritto anche qualche allusione alla persona stessa di Marco? La tradizione antica s’accorda con Papia, al passo già visto (§ 128), nell’asserire che Marco non fu discepolo di Gesù: un paio di affermazioni contrarie (ad es. Epifanio, Hæres., XX, 4) rimangono solitarie e non autorevoli. Tuttavia questa tradizione non escluderebbe per se stessa che Marco, ancor giovanetto, abbia visto qualche volta di sfuggita Gesù, pur senza essere suo vero seguace: la circostanza già rilevata che la casa della madre di Marco era luogo d’adunanza per i cristiani di Gerusalemme, e che nell’anno 44 Pietro vi si rifugiò appena uscito di prigione (§ 127), fa supporre un’antica amicizia che poteva ben risalire a prima della morte di Gesù. Assicurata questa possibilità, entra in relazione con essa un singolare episodio della passione di Gesù, narrato dal solo Marco, episodio ben preciso anche nel suo arcano riserbo. Gabriele d’Annunzio ha scritto: Non avete mai pensato chi potesse mai essere quel giovine «amictus sindone super nudo», del quale parla il Vangelo di Marco? «E tutti, lasciatolo, se ne fuggirono. E un certo giovine lo seguitava, involto d’un panno lino sopra la carne ignuda, e i fanti lo presero. Ma egli, lasciato il panno, se ne fuggì da loro, ignudo». Chi era quel tredicesimo apostolo, che aveva preso il luogo di Giuda nell’ora dello spavento e della grande angoscia?... Era vestito d’un vestimento leggero. Si fuggì ignudo «reiecta sindone, nudus profugit ab eis». Nulla più si seppe di lui nel mondo (in Contemplazione della morte, cap. XV aprile MCMXII). Quest’episodio (14, 51-52) è, storicamente, un masso erratico: non ha alcuna colleganza con gli altri fatti della passione, tanto che si potrebbe sopprimere senza alterare la narrazione complessiva. Eppure il narratore è bene informato: sa che quel giovanetto, risvegliato forse improvvisamente dal frastuono notturno, non ha fatto in tempo a gettarsi addosso neppure un mantello, e con la sola sindone s’è messo a seguire; infine, catturato, lascia la sindone in mano ai catturatori, e fugge nudo (§ 561). I discepoli di Gesù erano già fuggiti tutti, come ha detto il narratore poco prima: anche Pietro, l’informatore principale di Marco, già era fuggito e non era più sul posto. Chi era dunque quel giovanetto, unico testimone amico fra tanti nemici? Perché Marco, che sa tutto di lui, non lo nomina, e preferisce presentarlo con la faccia occultata da un arcano velo? Quel giovanetto, forse, era Marco stesso, come pensano molti studiosi moderni. Nella stessa guisa che Pietro nella sua catechesi nascondeva fatti a sé onorifici, così anche Marco può aver velato qui la sua propria faccia, pur non volendo omettere del tutto questo episodio che nel suo scritto poteva valere come simbolico signaculum in sigillo. FINE.

Da «Vita di Gesù Cristo», Imprimatur 1940, Giuseppe Ricciotti (preghiamo l'Eterno riposo ...), 7a Edizione, 32° - 36° migliaio, Encomio solenne della Reale Accademia d’Italia, Rizzoli & C. Editori, Milano - Roma, 1941.


























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)