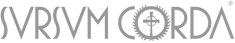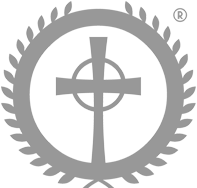Stimati Associati e gentili Sostenitori, ci eravamo salutati studiano il prezioso volumetto del P. F. S. Porporato, «La verità nei libri storici della Bibbia», SOS (Collezione di Opuscoli Apologetici per le Persone Colte), imprimatur 1945. Ricominciamo sfatando la ridicola obiezione secondo cui Gesù sarebbe il primogenito..., pertanto non sarebbe figlio unico. Tanto si è scritto nel precedente numero di Sursum Corda, dunque concludiamo affermando che un figlio è detto «Primogenito» dalla Scrittura non solo perché è stato seguito da altri, ma anche per il solo fatto che da altri non è stato preceduto «primogenitus est non tantum post quem et alii, sed ante quem nullus» (S. Hier, De Perpetua virginitate Beata Mariae adversum Elvidium, n. 10 P.L. 23, col. 192-3).
• La bestemmia di Elvidio è quindi sfatata e smentita dal momento che sfatata e smentita è l’interpretazione del vocabolo su cui era incastellata: e San Luca poté ben scrivere che Maria «partorì il figlio suo primogenito», senza recare il minimo pregiudizio alla verginità perpetua della Madre di Dio. Del resto a confusione degli antichi eretici non meno che dei moderni razionalisti che, da veri epigoni di quelli antichi, osano schierarsi contro la perpetua verginità di Maria SS.ma, rimettendo in campo obbiezioni già mille volte vittoriosamente ribattute, la Provvidenza serbava ai tempi nostri una prova delle più schiaccianti. Tutti codesti oppositori ripetono in sostanza, con Holtzmann: «Questo termine protótohos prova che anche il nostro Evangelista (Luca), come i precedenti, vede in Gesù il maggiore di una serie di fratelli e sorelle. Infatti anche qui si applica ciò che Luciano (Demonax, 29) dice di Agatocle: “Se primo non è solo, se solo non è primo”». Agatocle fu un filosofo peripatetico, che con grande boria vantava se stesso per unico e primo dei dialettici. Gli risponde argutamente Demonatte: «O Agatocle, se sei unico non sei primo, e se primo non unico». Ma la filologia con tanta baldanza invocata, è venuta a gettare loro in faccia una smentita solenne, clamorosa, mediante l’iscrizione d’una lapide sepolcrale, trovata nel 1922 negli scavi di Iehudieh, l’antica Leontopoli, già sede di una fiorente colonia ebraica. In quella iscrizione è introdotta a parlare una giovine ebrea, per nome Arsinoe, che lamenta d’esser morta, in sul fior degli anni, nei dolori del parto del suo figlio primogenito «odeíni prototókou téknou».
• Più ancora: è ivi segnato il tempo della composizione di tale iscrizione: è il vigesimoquinto anno di Cesare Augusto (= anno 5° a. C.), su per giù il tempo in cui ora si colloca generalmente la data della nascita del Salvatore. Le conseguenze di una tale iscrizione, ognuno le vede, sono di una portata al tutto eccezionale. Il figlio di Arsinoe viene chiamato protótokos — primogenito, eppure è unico. Dunque è falso che«se primo non è solo, e se solo non è primo»: in altre parole è falso che il termine protótokos = primogenito, non possa avere un senso assoluto, ma implichi sempre un senso relativo, un rapporto ad altri fratelli o sorelle, nati dopo il primo. Il figlio di Arsinoe viene chiamato protótohos — primogenito e non monogenés = unigenito, eppure era chiaro che Arsinoe era senza alcuna possibilità di averne altri. Dunque poté San Luca chiamare Gesù il Figlio primogenito di Maria anziché Figlio unigenito, pur sapendo che, posto in Maria il proposito di perpetua verginità (cf. c. I, v. 34), altri, dopo il primo, erano impossibili
• Il Grimm, che nel suo «Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti» (Lipsiae, 1888), sotto la voce adelfós scrive: «Si Maria post Jesum alios liberos non peperisset pro yion protótokon dicendum fuisset yion monogené», parimenti l’Usener che rifrigge la stessa obbiezione hanno da questo documento una confutazione perentoria, senza replica. C’era poi una ragione tutta speciale per San Luca di usare il termine primogenito, dato che quel termine era il necessario fondamento e il titolo legale della Presentazione al Tempio, da lui solo riferita (San Luca raccoglie le memorie della Vergine Maria, ndr.). Pertanto quando nel Piccolo dizionario biblico, composto a cura dell’eretica comunità valdese di Torre Pellice nel 1941, a pag. 160, sotto la voce Fratelli di Gesù leggiamo: «Quest’ultima espressione (Figliuolo primogenito, Luc. 2; 7) non dimostra essa che l’evangelista credeva che Gesù non fosse l’unico figlio di Maria?», ci prende un senso di stupore e, anche scientificamente parlando, siamo costretti a deplorare di trovarci dinanzi a cose che sanno di arretrato. Ecco come per la verità storica sia importante ben appuntare l’occhio al significato inteso dall’agiografo nell’uso che fa d’una locuzione o d’un vocabolo; quanto sia importante inquadrare locuzioni e vocaboli nella mentalità di chi scrive non meno che nelle particolarità del linguaggio corrente in cui si scrive.
• Metodo di computazione. Anche per giudicare rettamente della verità di certi computi della Scrittura conviene essere attenti a cogliere il metodo di computazione che può aver seguito l’agiografo: altrimenti si corre il rischio di mettersi in una falsa prospettiva e di pronunciare condanna che in realtà ferirà non la Scrittura ma la falsità delle nostre apprensioni intorno alla Scrittura. Un esempio ci pare di trovarlo nel libro secondo dei Paralipomeni (17, 13-17), dove sono nominati cinque capitani i quali hanno sotto di sé dei soldati come segue: Il primo trecento eleph, il secondo duecentottanta eleph, il terzo duecento eleph, il quarto duecento eleph, il quinto centottanta eleph. Se interpretiamo «eleph» per «migliaia» effettive, abbiamo in tutto 1.160.000 uomini. E dire che tutti sono residenti nella città di Gerusalemme (verso 19), tutti formanti come la coorte pretoriana del re Giosafat. Evidentemente è cifra esorbitante, fuori del credibile. Errore dell’agiografo, come vogliono i razionalisti? Sbaglio dei copisti, come dicono altri? Né l’uno né l’altro. A ridurre il computo a proporzioni ragionevoli, basterà spiegare l’»eleph» = migliaia, come valore fisso, ma convenzionale, sotto cui si raggruppano i valori reali, espressi dalle altre cifre. In altri termini sarebbero gruppi di 300, di 280, di 200, di 200, di 180 soldati appartenenti rispettivamente a cinque divisioni o coorti militari dette millenarie, alla cui testa stavano quei capitani (o capi-migliaia) come li chiama espressamente (v. 14) il testo ebraico.
• Ecco i due libri dei Maccabei. Nei dati cronologici di entrambi il lettore moderno resta dapprima sconcertato dall’uso che fanno d’un’êra speciale, quella dei Seleucidi cominciata nell’ottobre del 312 avanti Cristo. Ma, quel che è più e fa al caso nostro, talora non s’accordano fra loro nel riferire a un dato anno il medesimo fatto. La questione è che l’autore del 1° libro dei Maccabei, seguendo l’uso ebraico che poneva il principio dell’anno in primavera (Nisan, marzo-aprile), ha computato come primo anno dei Seleucidi dal marzo-aprile del 312 al febbraio-marzo del 311. In conseguenza per lui già nel marzo-aprile del 311 comincia l’anno secondo dei Seleucidi, riuscendo così in anticipo di 6 mesi sull’autore del libro secondo che lo comincia nell’ottobre seguente. Da ricordarlo, per non attribuire ad errore il trovare, nel primo libro, segnati coll’anticipo di un anno, quegli identici avvenimenti che il secondo ha datato coll’anno susseguente.
• Similmente notiamo che quando i sinottici riferiscono la profezia di Gesù: «Il Figlio dell’uomo dopo tre giorni risusciterà» (Matt. 17, 22 ; 20, 19; Marc. 9, 30; 10, 34; Luc. 18, 33), evidentemente parlano secondo il computo in uso presso gli Ebrei, per i quali una frazione di giorno contava per un giorno intero. Altro esempio dal libro di Giosuè 1-3. Giosuè dà ordine a tutto il campo di apparecchiarsi, perché tre giorni dopo si deve passare il Giordano (1, 11). Poi manda esploratori a Gerico, i quali di ritorno sul far della notte: per non incappare negli inseguitori sguinzagliati loro dietro si gettano attraverso la montagna e vi rimangono tre giorni (2, 22). Scesi poi da Giosuè e informatolo che le cose vanno bene e il momento è propizio, in fin di tre giorni si muove il campo e si giunge al Giordano (3, 2). Contraddizione fra i due ultimi dati, ovvero contrordine e ritardo a muovere il campo in attesa del ritorno degli esploratori? Né l’uno né l’altro; a tutto conciliare basta prendere per non interi i tre giorni della dimora nella montagna, ma la sola notte per il primo, e le prime ore del mattino per il terzo con solamente il secondo intero, tempo abbondante, nonché sufficiente, allo scopo. Rileviamo infatti dagli scritti rabbinici la testimonianza di R. Eleazar bar Azaria che diceva, verso l’anno 100 dopo Cristo: «Un giorno e una notte formano una ’ona (spazio di tempo equivalente a 24 ore), ma una ’ona cominciata vale una ona intera».
• San Giovanni, nel racconto della Passione, nota un particolare che pare in aperto contrasto con San Marco. Questi dice espressamente: «Era l’ora terza quando lo crocifissero (il Salvatore) (15, 25)». San Giovanni invece afferma che era quasi l’ora sesta quando Pilato pronunciò la condanna e lo diede a crocifiggere (19, 14). Ma il contrasto scompare dinanzi a una semplice riflessione sopra la divisione del giorno, seguita dai due Evangelisti. L’ora terza, comprende tutto lo spazio che decorre dall’inizio alla fine dell’ora terza, vale a dire dalle nove alle dodici. Pertanto qualunque punto di queste tre ore può verificare l’affermazione di San Marco. Ora San Giovanni non farà che meglio precisare quel punto quando scrive che la condanna di Gesù fu pronunziata circa l’ora sesta. Dichiara così che l’esecuzione, seguita immediatamente alla condanna, avvenne quando l’ora terza era sul terminare, e non è punto in disaccordo con San Marco.
• Esclusione di ogni errore? Con questo non vogliamo negare che qua e là nella Scrittura le cifre numeriche non abbiano subito delle alterazioni; ma questo punto rientra nell’ambito di un’osservazione più generale che ancora dobbiamo aggiungere per comprendere a dovere la verità della Scrittura, massime nei libri storici. Bisogna dunque sapere che l’esclusione assoluta di ogni errore, che diciamo essere proprietà essenziale della Scrittura, riguarda la Scrittura quale, nel suo testo originario, è uscita dalle mani degli agiografi. È qui dove in tutta la piena estensione del termine, ogni singola asserzione, così come è espressa per iscritto, è parola scritta da Dio, garantita perciò infallibile dall’infallibilità di Dio stesso. Ma ben lo sappiamo: coll’andar del tempo, agli autografi, che perirono, successero gli apografi, cioè le copie trascritte e, come è facile immaginare, moltiplicate in grande quantità. In questo lavorio di continua trascrizione e nella lunga serie di tanti secoli, supporre che tutto sia stato conservato appuntino, conformemente agli originali primitivi, sarebbe supporre miracoli sopra miracoli. Ora i miracoli non si suppongono, ma si provano. Avvenne pertanto ciò che in simili casi suole avvenire per altri libri.
• Gli scrivani, o per sbaglio d’occhio nella lettura o per sbaglio d’orecchio nella dettatura, o per stanchezza di mente, o per deficienza di attenzione, qua e là inciampano, scambiano una locuzione per un altra, un nome per un altro, saltano talora incisi, linee, interi periodi; cercano, a volte, di dare un costrutto qualunque a ciò che essi non intendono, quando ancora non si pigliano la libertà di aggiungere essi, ad arbitrio, qualche glossa loro propria, dove il testo offre oscurità. E la ragione è che nel copiare a mano (unico modo di edizione nell’antichità e nel medio evo) è moralmente impossibile che in un testo di qualche lunghezza non si introduca qualche modificazione: non si danno due manoscritti della medesima opera perfettamente identici per il testo. Tanto è provato da un’esperienza continua d’ogni giorno.
• Ebbene una sorte simile ebbero anche a incontrare i libri sacri. Per altro, notiamolo subito, c’è una parte nei libri sacri sulla quale indubbiamente Dio dovette invigilare con una provvidenza tutta particolare, perché, nella trascrizione del testo sacro, nell’avvicendarsi di trascrizioni innumerevoli, nulla si alterasse di ciò che riguarda la sostanza del libro ispirato, ossia di ciò che riguarda la fede e i costumi: diversamente il deposito della rivelazione non si sarebbe trasmesso sempre intatto e integro alle generazioni più remote, e sarebbe stato frustrato il fine che ebbe Dio nell’ispirare quei libri. È quindi fuori di dubbio che le parti sostanziali, sia dogmatiche sia morali, si conservarono sempre immuni da qualsiasi errore, benché talvolta possano essere andate soggette a difetti di trasmissione del testo, come varianti che non alterano sensibilmente il significato.
• Ma in modo più assoluto e perentorio bisogna dire ciò nel caso dei «passi dommatici», ossia in quelle, anche brevi, locuzioni che tecnicamente, a così dire, esprimono la verità rivelata, come, per esempio, nel racconto della consacrazione eucaristica. Invece per le parti accidentali, secondarie, che nella Scrittura sono come un accessorio, senza necessaria attinenza e intimo collegamento con la fede e i costumi, non possiamo dire altrettanto. Queste non furono esenti dall’incontrare la sorte comune di ogni altro documento letterario dell’antichità: in queste poterono infiltrarsi qua e là delle alterazioni, delle modificazioni e perfino degli errori, per le cause sopra esposte e che Dio non ha voluto impedire.
• Errori per scambio di lettere. Applichiamo ora quanto abbiamo detto ai libri storici della Bibbia, e avremo facile il modo di sciogliere parecchie difficoltà. Anzitutto ci rendiamo conto delle differenze che occorrono in questo, o in quel punto accessorio, massime a riguardo dei nomi proprii, dove lo scambio di lettere, molto simili tra loro nella forma, è tanto facile; come pure a riguardo di cifre numeriche, dato che anche queste si solevano rappresentare con segni alfabetici. Sapremo così spiegare perché un identica persona si chiama nel Genesi (3, 39) Adar, e invece in I Par. (1, 50) Adad; perché Ackar e Zabdi trovati in Giosuè (1, 1, 17, 18) si cambiano nel I Par. (12, 6. 7) in Achar e Zamri; perché nel 3° dei Re (9, 28) si dice che da Ophir si portarono a Salomone 420 talenti d’oro, mentre nel 2° Par. (8, 18) sono invece 450; perché il libro 2° dei Re (10, 8) parla di 700 carri e di 40.000 cavalieri, invece il l° Par., nel luogo parallelo, (19, 8) di 7.000 carri e di 40.000 fanti; perché secondo il quarto dei Re (8, 26) Ochozia, quando principiò a regnare, aveva 22 anni, 42 invece secondo il 2° Par. (22, 2); perché nel 2° dei Re al capo 6, 23 troviamo affermato che Micol, figlia di Saulle, non ebbe mai figli in vita sua, mentre al capo 21, 8 (per confusione avvenuta di Michol con Merob, anch’essa figlia di Saulle) leggiamo che Michol ebbe 5 figli da Adriele, figlio di Berzellai (cf. 1° Re 18, 29; 25, 24); perché nel libro di Esdra (2, 1-70) e nel libro di Nehemia (2° di Esdra 7, 8-66) benché la somma totale degli Ebrei tornati dall’esilio Babilonese in Palestina si trovi in entrambi del tutto uguale (12.360), tuttavia i numeri parziali da cui risulta variano fra loro tanto da non dare il totale notato.
• Sono tutte divergenze per cui è alterata la verità storica accessoria, verissimo; ma di cui si hanno a chiamare in colpa non altri che i copisti. È noto il giudizio di San Girolamo a riguardo del sincronismo tra i re di Giuda e Israele, quale risulta dal 3° e 4° dei Re nel testo attuate. Il grande esegeta vi trovava tanta confusione di numeri da sentenziare che tentare un accordo sarebbe fatica gettata. «Relego omnes et veteris et novi Testamenti libros et tantam annorum reperies dissonantiam et numerum inter Iudam et Israel, id est, inter regnum utrumque confusum, ut huiusmodi haerere quaestionibus non tam studiosi quam otiosi hominis esse videatur». Epist. 72 n. 5 ad Vitalem (Migne, P. L. 22, 676). Il primo libro dei Re (6, 19) ci riferisce il castigo inflitto da Dio ai Betsamiti per il contegno irriverente tenuto verso l’Arca santa, allorché questa, dalle mani dei Filistei, era tornata in Israele. Vi è detto, nel testo ebraico, che Dio «percosse del popolo settanta uomini, cinquanta mila uomini». Trattandosi d’una piccola città, quale era Betsames, la cifra ha dell’incredibile. Ma è autentica? A guardare attentamente il testo, vi si scorge una doppia irregolarità, e cioè che, contrariamente all’usato, vien premesso il numero minore al maggiore e che viene omessa, davanti al secondo numero, la congiunzione solita in tali costrutti. Ciò dimostra che il secondo numero dev’essere un’interpolazione, tanto più che esso manca in alcuni codici ebraici (Kenn. 24.210.418); e Giuseppe Flavio (Ant. VI, I, 4), narrando lo stesso fatto, parla solo di settanta uomini. Pertanto la cifra sbalorditiva non deve farsi risalire all’agiografo.
• Una crudeltà di Davide? Vi è di peggio. Con ragione il P. Condamin, a un articolo pubblicato nelle Revue Biblique (1898, p. 253-258), poneva in fronte questo titolo: «David cruel par la faute d’un copiste». Ed ecco in che modo. Davide stando al testo ebraico attuale (2 Re, 12 31 b) avrebbe fatto passare nelle fornaci di mattoni, e quindi fatti bruciare, gli Ammoniti, e non solo quelli della città di Rabbath Ammon da lui espugnata, ma quelli ancora di tutte le altre città. Eccessi sopra eccessi di crudeltà, tanto che il Mangenot nel Dictionnaire de la Bible (Vol. II, col. 1316), sotto la voce David, si crede in dovere di scrivere: «Crudeltà di questo genere, che ci fanno orrore e che non c’è bisogno di attenuare... si spiegano abbastanza, senza che si possano scusare, con i costumi barbari del tempo». Ma ormai la critica testuale, anche di parte acattolica, ha reso giustizia a Davide in questo punto. Ha dimostrato che tutto è dovuto allo scambio di due verbi «àbar = passare e àbad = lavorare», le cui consonanti finali (resc e daleth) sono molto simili tra loro. Infatti, nella forma hiphil, se invece di «heèbir = far passare» si legge «heèbid = far lavorare», subito muta pure il senso e ne risulta: «fece lavorare gli Ammoniti nelle fornaci da mattoni». Cosa ben differente e per nulla crudele, e tanto più da ammettere se si riflette che il nome, retto dal verbo e interpretato per formarci da mattoni, ha propriamente il significato di «forme da mattoni»; se di più si riflette che solo così ha il pieno accordo con quanto precede, che cioè Davide, come applicò gli Ammoniti a vari altri gravosi lavori, «alle seghe, agli erpici ferrati, alle scuri (v. 31 a), così li fece lavorare in fabbricare mattoni (31 b)». Come già accennammo, gli stessi critici razionalisti giustificano ora Davide dall’accusa di crudeltà che, per il fatto degli Ammoniti, ha gravato tanto tempo sulla sua memoria. È un caso, questo, che sta a dimostrare a che gravi conseguenze possa portare lo scambio di una lettera, e quale vigile Provvidenza siasi dovuta esercitare per preservare da ogni errore le parti sostanziali del testo originale.
• Alterazioni nelle versioni. E che diremo se passiamo a considerare il testo sacro nelle versioni? Già si sa che la versione in se stessa, voglio dire in quanto versione, non è ispirata, e San Girolamo, parlando della versione Alessandrina, la cosiddetta versione dei Settanta, che pure era accolta e adottata nell’uso pubblico della Chiesa, ebbe a dire: «Aliud est vatem, aliud est esse interpretem». Altro è scrivere sotto la divina ispirazione, altro tradurre lo scritto ispirato. Nessuna meraviglia pertanto, se qui la verità storica, in cose accessorie, anche più di frequente, abbia avuto a soffrire alterazioni; ma in pari tempo sarà anche più evidente quanto sarebbe ingiusto l’attribuire ciò all’agiografo.
• La Volgata. È ben vero che c’è nella Chiesa una versione che ha un suggello di autorità unico, perché solennemente approvata dal Concilio di Trento come autentica, ossia come documento irrefragabile della rivelazione divina scritta. È la Volgata latina. Sarà essa, per questo, scevra di errori? Sì, se si tratta di cose che appartengono al pubblico magistero della Chiesa, che riguardano cioè la materia di dogma e di morale e quanto con il dogma e la morale ha stretta attinenza; no, se si considera ciò che vi ha di meramente accessorio. Che sia così fu riconosciuto da quegli stessi Padri e Teologi che presero parte al Concilio, come è riconosciuto tuttora da quanti trattano di questo argomento. Anzi abbiamo ora la dichiarazione autentica del magistero ecclesiastico nella enciclica sugli studi biblici «Divino afflante spiritu» (Cfr. Civ. Catt., 1943, IV, 201). E non lo nasconde la stessa Volgata che, appunto nei libri storici, contiene quegli errori medesimi che più sopra abbiamo elencato a riguardo del testo ebraico, oltre ad altri che sarebbe facile ad aggiungere, dovuti non a sbagli di stampa o di tipografi, ma addirittura alla versione stessa. Qualche saggio. Chi non lo vede, quando, per esempio, legge in Giosuè (14, 15) che Adamo il massimo (e cioè il primo degli uomini) è sepolto tra gli Enacim in Ebron, mentre il testo ebraico dice chiaramente che ivi era sepolto Arbe, uomo (ebr. ’adam ma nome comune e non proprio) il più grande che sia stato tra gli Enacim? Quando legge in 2° Esdra (9, 7) che «Abramo fu da Dio tratto fuori dal fuoco dei Caldei», interpretandosi il vocabolo ebraico «Ur» come nome comune (= fuoco), mentre è nome proprio indicante la città dei Caldei? E non è manifesto controsenso quando leggiamo nei libro primo dei Re (13, 1) che «Saulle (il quale sopravanzava il popolo dalla spalla in su, cfr. .10, 23) aveva un anno quando cominciò a regnare e ne regnò due sopra Israele»? Questo versetto, che nei Settanta manca del tutto, nell’ebraico è lacunoso, essendo caduti totalmente il primo numero (quello degli anni dell’età) e parzialmente il secondo (quello degli anni del regno); ad ogni modo nella Volgata non si può a meno di vedervi un errore. Similmente un errore riscontriamo nel versicolo 28 del Capo 32 dell’Esodo. La strage che Mosè, disceso dal Sinai, unitamente con i figli di Levi, fa degli idolatri del vitello d oro, sale, stando alla Volgata, a circa 23.000 uomini. Ma è cifra errata: il testo ebraico porta circa 3.000, d’accordo in questo con la versione dei Settanta, con la parafrasi aramaica, con la versione siriaca e con l’antica latina, citata da Tertulliano (Scorpiace III, P. L. 2, 129) e da Sant’Ambrogio (Epist. 56 ad Romanum, 1; P. L. 16, 1227).
• Un altro esempio particolarmente significativo. Dopo che Sansone ebbe percosso con una mascella d’asino mille Filistei, sentendosi riarso da gran sete, levò la voce a Dio per soccorso: e «Dio, stando alla Volgata, aperse il dente molare della mascella d’asino e ne fece sgorgare delle acque, onde Sansone si ristorò» (Giudici, 15, 14 segg.). Sennonché la versione qui non ha colto il senso. Il testo legge: «e Dio aperse la roccia concava (maktesc) che è sull’altura “Mascella” e ne scaturirono delle acque». Adunque «Mascella» non è altro che il nome dato a quella località, in memoria del fatto ivi accaduto e la fonte non sgorgò dal dente mascellare dell’asino, ma dalla cavità della pietra posta sul colle «Mascella». Tanto è vero che, ancora al tempo che l’autore sacro scriveva, quella fonte era detta «la fonte di colui che invocò (Dio) sull’altura della Mascella (v. 20)».
• E che dire della frase che incontriamo nella Volgata di San Matteo (21, 1): «Vespere autem Sabbati quae lucescit in prima sabbati?». Quanto è lontana dal rendere il testo originale: «dopo il sabbato, sull’albeggiare del primo giorno della settimana». E più lontana ancora senza paragone la versione degli Atti al c. 27, v. 13. Siamo a Creta. La nave che porta Paolo prigioniero a Roma ha sostato alquanto nella baia di Buoniporti, ed ora, volendo dirigersi al porto Fenice, salpa, secondo la Volgata, da Asson e costeggia Creta. «Cum sustulissent de Asson, legebant Cretam». Ma Asson, isola o città marittima, non si trova in nessuna parte. Il traduttore ha quindi scambiato per nome proprio ciò che nel testo originale è avverbio comparativo, asson da anchi, che perciò si ha da intendere: «Avendo levate le ancore, più da vicino (asson) costeggiavano Creta».
• Dopo quanto abbiamo esposto si stenta veramente a credere come vi sia stato chi, non ha molto, abbia potuto sentenziare che il decreto Tridentino dà la «certezza del sacro testo», così che la Chiesa non ha bisogno di «ancora ricercare l’autentica lettera di Dio» (p. 7), e ciò non soltanto «in rebus fidei et morum», ma in tutti i rispetti «anche letterari, geografici, cronologici ecc...» (Acceniamo all’opuscolo che ha per titolo: «Un gravissimo pericolo per la Chiesa e per le anime. Il sistema critico-scientifico nello studio e nell’interpretazione della Sacra Scrittura, le sue deviazioni funeste e le sue aberrazioni» pubblicato in data 24 maggio 1941 sotto l’anonimo dal sac. Dolindo Ruotolo (Dain Cohenel). Se ne legga la confutazione nella Lettera circolare della Pontificia Commissione per gli Studi Bibblici diretta agli Ecc. Ordinari d’Italia, in data 20 agosto 1941. A. Vaccari, Lo Studio della Sacra Scrittura, Roma, Civiltà Cattolica, 1943). Se così fosse la Volgata ci dovrebbe dare sempre la verità esatta di tutte le narrazioni bibliche, in ogni più minuto particolare, perché sempre in tutto e per tutto vi leggeremmo con ogni certezza la autentica lettera di Dio. Ma è così? Gli esempi addotti, spigolati qua e là attraverso i libri storici della Bibbia, sono prova più che sufficiente del contrario; e non aggiungeremo altro.
• Appendice. Dire donde sia nata l’opinione che faceva gli spartani discendenti da Abramo è impossibile. Ma a torto si negherebbe che una tale opinione si sia potuta infiltrare nelle memorie di quel popolo. Leggasi quanto scrive Tacito nel libro V delle Storie, al capo 2°, intorno alle origini dei Giudei: «Si racconta che i Giudei, fuggendo dall’isola di Creta, si stabilirono sugli estremi confini della Libia, al tempo che Saturno, cacciato da Giove, abdicò al suo regno. Una prova è dedotta dal loro nome. A Creta, è celebre il monte Ida e i suoi abitanti erano chiamati Idei, nome che, aumentato per barbara corruzione d’una lettera, è divenuto Iudei. Secondo alcuni sotto il regno d’Iside, la moltitudine pollulata in Egitto, si riversò nelle terre vicine sotto la condotta di Ierosolimo e di Giuda. Parecchi vedono nei Giudei una razza d’Etiopi che timore e odio spinsero, sotto il regno di Cefeo, a mutare dimora. C’è anche chi ne fa una popolazione di emigranti Assiri, i quali, per mancanza di terra, si impadronirono d’una parte dell’Egitto, e ben presto colonizzarono, per proprio conto, le città e le terre ebraiche e le regioni vicine alla Siria. Secondo altri finalmente i Giudei hanno origini illustri: i Solimi, popolo celebre nei canti d’Omero, avrebbero fondato una città, che da essi prese il nome di Ierosolima». Non fa quindi meraviglia che Areo, forse per qualche suo particolare interesse, ricordi, scrivendo ad Orna, la comune origine che gli spartani affettavano di avere con i Giudei. Certo è che anche l’empio Giasone era di questa opinione, e fuggì a Sparta nella speranza di trovare ivi un rifugio, mosso appunto dal pensiero dell’affinità di razza (2 Macc. 5, 9)...

























![[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1](/images/stories/virtuemart/product/resized/[FRONTE WEB] CopertinaRacconti Miracolosi vol1_0x130.jpg)